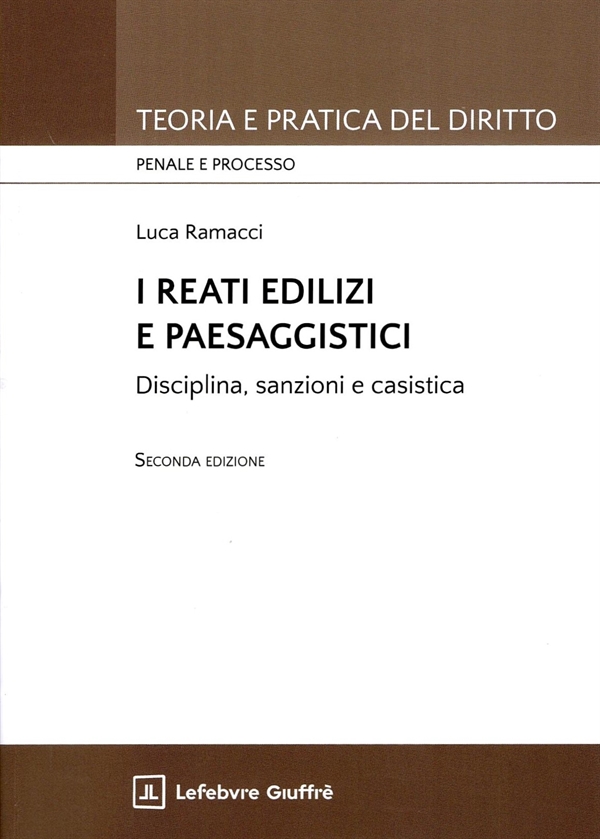Consiglio di Stato Sez. IV n. 7789 del 6 ottobre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7789 del 6 ottobre 2025
Rifiuti. Impianti di trattamento ed impatto ambientale
Dal confronto, in termini di impatto ambientale, tra il funzionamento di una piattaforma di trattamento aerobico (solo compostaggio) e di una piattaforma di trattamento anaerobico-aerobico (produzione di una fonte energetica e compostaggio) emerge che quest’ultima comporta un impatto molto minore sotto il profilo odorigeno. Infatti, il compostaggio aerobico consiste in un processo di degradazione della sostanza organica condotto in presenza di ossigeno che si realizza in capannoni chiusi dai quali è necessario estrarre l’aria, carica di composti odorigeni, da avviare al trattamento delle arie esauste. Le arie maleodoranti derivanti dal trattamento risultano dunque “cariche” di composti odorigeni in quanto il processo di degradazione avviene tutto in un’unica fase. La digestione anaerobica è, al contrario, un processo di degradazione della sostanza organica condotto in assenza di ossigeno, il quale si realizza quindi in reattori chiusi (digestori) e porta alla trasformazione del materiale biodegradabile in biogas e digestato. Avendo già subito una fase di degradazione biologica, il digestato presenta un minore impatto odorigeno. Pertanto, la successiva fase aerobica presenta un impatto minore in quanto effettuata in presenza di una matrice (digestato) che ha già subito rilevanti processi di degradazione.
Pubblicato il 06/10/2025
N. 07789/2025REG.PROV.COLL.
N. 02751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2025, proposto dal Consorzio Due Pini, dall’Associazione Osteria Nuova e S.Maria Galeria e dal Consorzio Colle dei Pini, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e da Paola Bernardini, , rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario Straordinario del Giubileo 2025, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della società Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comitato di Quartiere Insieme per Cesano e di Sabino Cacciapaglia, non costituiti in giudizio;
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V, 31 dicembre 2014 n.23911, che ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi riuniti nn. 2331/2024 e 2483/2024 R.G., il primo integrato da motivi aggiunti, proposti per l’annullamento:
dell’ordinanza 7 dicembre 2023 n.31, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.2 serie generale del 3 gennaio 2024, con cui il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha rilasciato provvedimento autorizzatorio unico regionale- PAUR relativo al progetto, proposto dalla AMA S.p.a., denominato «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano» in Comune di Roma Capitale, Municipio XV, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località via della Stazione di Cesano;
di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti e documenti tutti di causa;
udito il relatore dott. Luigi Furno alla pubblica udienza del giorno 17 luglio 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso di primo grado recante RG n. 2024/2231, il Consorzio Due Pini, l’associazione Osteria Nuova e S.Maria Galeria, il Consorzio Colle dei Pini e Paola Bernardini hanno impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 31, del 7 dicembre 2023, pubblicata in G.U. in data 3 gennaio 2024, emessa del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 recante “Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ” relativo al progetto di «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano» nel Comune di Roma Capitale, Municipio XV, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località via della Stazione di Cesano. Società proponente: AMA S.P.A”.
1.2. A sostegno del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi di gravame:
1) “Illegittimità punto 1 dell’ordinanza 31/2023, contraddittorietà estrinseca, violazione del principio dell’affidamento, irragionevolezza, violazione art. 97 Costituzione, difetto di motivazione” atteso che il provvedimento impugnato avrebbe disposto la modifica sostanziale ( mediante l’aggiunta di nuova sezione anaerobica di trattamento di fanghi e produzione di biogas nonché mediante l’aumento a 110.000 tonnellate all’anno dei rifiuti trattati, rispetto ai 60.000,00 t/a inizialmente previste per il solo impianto di compostaggio aerobico) all’impianto originariamente autorizzato (con determinazione G 09974 del 30 agosto 2020 dalla Regione Lazio) in contrasto con quanto, invece, precedentemente previsto dalla stessa Regione Lazio, che, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, aveva escluso la possibilità di riconvertire l’impianto di compostaggio aerobico in anaerobico. Ciò, peraltro, in assenza di qualsiasi puntuale motivazione;
2) “Illegittimità del punto 2 dell’ordinanza 31/2023 e dell’allegato 1, violazione dell'allegato I Direttiva 2001/42 ce lett. b ), degli articoli 3 e 5 della Direttiva 2011/92- violazione artt. 3, 5, 7, 8, 13, 20 e allegato I parte 2 direttiva 2012/18 – omessa valutazione e motivazione in ordine alla ubicazione dell'impianto proprio a Cesano - omessa valutazione dell'impatto ambientale derivante dalla modifica dell'impianto – omessa motivazione in ordine alla scelta di approvare la modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio - omessa valutazione del cumulo con gli altri impianti – insufficiente istruttoria e considerazione dell'impatto da incidente rilevante” atteso che, a seguito della predetta modifica sostanziale dell’impianto, la proponente avrebbe dovuto fornire, ai sensi dell'art.5, primo comma, della Direttiva 2011/92, i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sul contesto ambientale di Cesano (già gravato dalla presenza di numerosi stabilimenti, tra cui il più pericoloso è il Centro ricerche ENEA Casaccia, impianto a rischio di incidente rilevante di grandi dimensioni), effettuando una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame (compresa quella di non provvedere alla modifica dell'impianto già autorizzato), con indicazione delle principali ragioni della scelta di trasformare l'impianto di compostaggio in un biodigestore, il quale prevede la produzione di biogas e biometano e quindi una tecnologia molto più complessa ed inquinante;
3) “Illegittimità del punto 2 dell’ord. 31/2023 e dell’allegato 1, difetto di istruttoria, omessa valutazione impatto sull'aria, sull'acqua e sulle aree protette, violazione dell'allegato III Direttiva 2014/ 52, art. 7 Regolamento 517/2014, artt. 3, e 8 bis della Direttiva 2011/92, artt. 1 e 4 Direttiva 2000/60, art. 1 direttiva 2010/7, art. 5 comma lett. d) Direttiva 2011/92 – direttiva 1992/ 43 CEE”, sia per omessa valutazione in merito al maggiore impatto ambientale determinato dalla modifica sostanziale sulla matrice aria rispetto all'impianto di compostaggio; sia per omessa valutazione dell'impatto derivante dalla ingente emissione di Co2 in atmosfera determinata dall'impianto stesso (mediante l’incremento rispettivamente delle missioni odorigene e olfattive). Nella prospettiva in esame, i profili di rischio tra l’originario impianto e quello modificato sarebbero completamente diversi: mentre nell’impianto di compostaggio il rischio sarebbe limitato all’incendio dei cumuli di materiale stoccato, il biodigestore produrrebbe gas infiammabili ed esplosivi come il biogas e il biometano (immagazzinato in forma liquida); inoltre, in caso di rottura del biodigestore, sussisterebbe anche il rischio di sversamento di liquidi inquinanti;
4) “Illegittimità punto 3 dell’ord. 31/2023 e dell’allegato 2, violazione art. 13 del d.l. 50/2022 convertito in legge 91/2022, violazione direttiva 96/61/ce, violazione Direttiva 84/360/CE, violazione Direttiva 2006/11/ce, violazione Direttiva 2008/1/ce, violazione Direttiva 2009/31/CE, violazione art. 97 Costituzione, violazione del principio dell’azione ambientale ex art. 3 quater del c.a, difetto di istruttoria, difetto di motivazione” atteso che le prescrizioni contenute nell'allegato 2 non sarebbero idonee ad evitare danni all’ambiente;
5) “Illegittimità punto 3 dell’ord. 31/2023, violazione della decisione di esecuzione 2018/1447, violazione delle BAT”. Ciò sul rilievo che l’allegato tecnico 2 prevedrebbe che il rispetto della BAT 1, ossia l’adozione di un sistema di gestione ambientale, fosse garantita tramite certificazione ISO 14001/2015, mentre lo studio di impatto ambientale contemplerebbe anche la necessità certificazione EMAS, in quanto ritenuta più efficace al fine di perseguire il principio dello sviluppo sostenibile in ragione del fatto che è affidata ad un doppio controllo pubblico e privato. Inoltre l’impianto autorizzato violerebbe le BAT 15 – 16 perché avrebbe prodotto troppo Biogas a scapito del Biometano, in contrasto quindi con i principi in materia ambientale;
6) “Illegittimità punto 4 dell’ordinanza 31/2023, violazione dell’art. 13 del d.l. 50/2022 convertito in legge 91/2022, violazione del principio dell’azione ambientale, violazione del d.lgs. 42/2004, violazione art. 14 ter l. 241/1990, violazione 9 della Costituzione, violazione art. 97 Cost.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 131, 142, co. 1, lett. m, e 146 d.lgs. 42/2004, del PTRP e del piano dei rifiuti regionale – omessa e/o insufficiente istruttoria e motivazione – eccesso di potere travisamento irragionevolezza – violazione Direttiva UE 2014/52 e convenzioni consiglio europeo richiamate dalla direttiva” atteso, da un lato, che il punto 4 del PAUR prescriverebbe ad Ama s.p.a. di recepire ex post le prescrizioni della Soprintendenza in merito al completamento delle indagini archeologiche nonché in merito alla possibile riconfigurazione della infrastruttura viaria di nuova realizzazione, violando, in tal modo, il diritto comunitario nella parte in cu richiede che le autorizzazioni ambientali siano emanate a seguito di una attenta istruttoria e che contengano già tutte le prescrizioni per evitare danni (articolo 9 della Direttiva 2008/1/CE); dall’altro, in quanto, in ogni caso, sarebbe stato necessario rimodulare completamente il progetto, considerato il contenuto del parere negativo e vincolante emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo, che nel parere stesso aveva rilevato la violazione del D. Lgs. 42/2004.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti gli originari ricorrenti hanno dedotto ulteriori censure avverso il medesimo atto già impugnato, e segnatamente:
i) “Illegittimità per violazione dell'art. 5 lett. l e l bis del codice dell'ambiente- illegittimità punto 2 dell’ord. 31/2023 e dell’Allegato 1, violazione dell'allegato I Direttiva 2001/42 CE lett. b), degli articoli 3, 5, 8 bis della Direttiva 2011/92- omessa valutazione dell'impatto ambientale derivante dalla modifica dell'impianto – violazione allegato I Direttiva 2012/18- insufficiente istruttoria e considerazione dell'impatto da incidente rilevante -violazione dell'art. 97 della Costituzione”.
L’'ordinanza impugnata sarebbe viziata da illegittimità per violazione dell'art. 8 bis, della Direttiva 2011/92, così come modificata dalla Direttiva 2014/52, ai sensi del quale, già in sede di adozione di una valutazione positiva dell'impatto ambientale, l'autorità competente avrebbe dovuto indicare tutte le misure idonee ad evitare, prevenire o ridurre le conseguenze negative sull'ambiente: il che necessariamente presupponeva un progetto definito in tutti i suoi aspetti.
4. Con autonomo ricorso recante R.G. n. 202402483, l’Associazione Pro Territorio e Cittadini odv ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio, chiedendone l’annullamento, la predetta ordinanza n. 31, del 7 dicembre 2023, deducendo i seguenti (diversi) motivi di gravame:
1) “carenza di potere / eccesso di potere / sviamento di potere”, atteso che sarebbe stato disatteso il parere negativo dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale; 2) “violazione e falsa applicazione del D. Lgs 42/2004 (cd Codice dei Beni Culturali)” atteso che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale – con nota protocollo SABAP-VT-EM_UO3 n. 0015763-P del 20 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale n. RM2575 - aveva espresso parere (obbligatorio e vincolante) negativo alla realizzazione dell’intervento ritenendo “le opere non compatibili con il contesto di riferimento e di troppo impatto ambientale”; 3) “carenza di motivazione” atteso che l’atto era stato adottato in assenza di adeguata motivazione in ordine all’inosservanza del parere della Soprintendenza nonché della V.I.A. -valutazione 7 di impatto ambientale e rilasciata con determinazione Regione Lazio n. G08169 del 10 luglio 2020.”.
5. Con sentenza 31 dicembre 2024, n. 23911, il T.a.r Lazio, dopo aver riunito per ragioni di connessione (essendo stato impugnato lo stesso provvedimento PAUR) i predetti ricorsi, li ha dichiarati entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione del successivo bando di gara, pubblicato in data 14 marzo 2024, mediante il quale Invitalia ha messo a gara la progettazione e realizzazione del Biodigestore.
5.1. Il T.a.r, in particolare, ha così argomentato la decisione di improcedibilità: “Premesso, in limine litis, sul piano strettamente processuale in fatto, che le resistenti hanno eccepito la mancata impugnazione del successivo bando di gara pubblicato in data 14 marzo 2024, mediante il quale Invitalia ha messo a gara la progettazione e realizzazione del Biodigestore, e che sul punto le ricorrenti di entrambi i giudizi non hanno allegato alcunché e provato di aver invece impugnato tale ultimo atto, deve conseguentemente ritenersi, in base al principio di non contestazione e per come correttamente dedotto in punto di diritto dalle stesse resistenti, che dalla omessa impugnazione del bando discenda l’improcedibilità di tutti i ricorsi.
L’eventuale giudicato favorevole alle ricorrenti, infatti, non potrebbe comunque sortire alcun effetto (soprattutto caducante in via automatica) rispetto ad atti adottati da soggetti terzi (nella fattispecie, Invitalia) – in base al principio per cui il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio - la cui inoppugnabilità rispetto agli stessi ricorrenti dei giudizi riuniti comporta, di conseguenza, uno svuotamento del loro interesse sotteso ai vari ricorsi: anche ammettendone, in via astratta, l’accoglimento, non ricaverebbero l’utilità sottesa, ossia la non realizzazione del Biodigestore, oggetto della gara.
Infatti, come evidenziato dalle resistenti, Invitalia è soggetto terzo rispetto al presente giudizio, cui non ha partecipato, mentre allo stesso tempo il bando dalla stessa adottato (atto logicamente connesso a quelli impugnati nella presente sede, ma distinto da questi perché appartenente ad un diverso e successivo procedimento amministrativo) è certamente espressivo di un agere valutativo non potendo ontologicamente ritenersi invece atto vincolato nel contenuto, in quanto espressione appunto del potere di scelta, quantomeno, del tipo di gara e dei requisiti partecipativi e tecnici degli aspiranti operatori interessati a partecipare”.
6. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per le ragioni indicate nella parte in diritto.
7. Si sono costituiti nel giudizio di secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario del Giubileo 2025, Ama s.p.a. e Roma Capitale, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
8. Alla pubblica udienza del giorno 17 luglio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato i ricorsi proposti in primo grado improcedibili in ragione dell’omessa impugnazione del bando, pubblicato in data 14 marzo 2024, mediante il quale Invitalia, quale Centrale di Committenza delegata da AMA s.p.a., ha indetto una gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione per un anno dell'impianto di Cesano, sul rilievo per cui l’eventuale caducazione del PAUR non avrebbe effetti caducanti atti conseguenziali tra cui anche quelli della predetta gara ad evidenza pubblica.
In senso contrario, rileva la parte appellante che l'effetto caducante è una conseguenza automatica che si verifica quando un atto viene annullato e questo incide sulla validità dell'atto successivo. Circostanza, quest’ultima, che si sarebbe verificata nel caso in esame, posto che l’ordinanza impugnata costituisce il presupposto per l'adozione dell'atto successivo.
1.2. In via subordinata, gli appellanti chiedono di sollevare “una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in ordine alla compatibilità di una simile interpretazione alle finalità del diritto eurounitario”, deducendo inoltre che si tratterebbe “sicuramente [di] una questione da sottoporre all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato” (pag. 8 dell’appello).
1.3. Il motivo è fondato.
In via preliminare, il Collegio rileva che la questione in esame investe il tema della invalidità derivata degli atti, che, come è noto, è stato oggetto di particolare approfondimento, sia in dottrina, sia in giurisprudenza.
In particolare, la questione dei riflessi processuali del nesso di presupposizione tra atti è stata tradizionalmente indagata sotto il profilo degli effetti, caducanti o meramente vizianti, che l’annullamento dell’atto presupposto illegittimo può produrre sull’atto presupponente.
In questi casi, secondo una impostazione largamente condivisa, non basterebbe semplicemente constatare il carattere viziato dell’atto presupposto al fine di “contagiare” anche l’atto presupponente, ma occorrerebbe provocare l’annullamento dell’atto a monte al fine di trasmettere il vizio anche al conseguente atto a valle (vizio caducante o viziante, a seconda della intensità del legame che avvince il nesso di presupposizione).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).
La connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postula, dunque, un aspetto strutturale ed uno funzionale.
Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo.
Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.
Quanto all’aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati.
Alla luce i tali coordinate, ritiene il Collegio che la procedura di gara in esame trovi il suo presupposto imprescindibile nel provvedimento di PAUR monte e sia con esso legata da un nesso di presupposizione necessaria.
In tal senso è possibile trarre decisivo argomento dal fatto che il bando di gara in esame, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione per un anno, inclusa manutenzione, dell'impianto di Cesano, non avrebbe potuto essere indetto in assenza dell'atto amministrativo che costituisce il titolo abilitante la predetta attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto di Cesano, vale a dire il PAUR oggetto di impugnazione.
1.4. Non convince del contrario l’assunto Ama (cfr. pag. 9 della memoria del 1° luglio 2025), secondo cui la dimostrazione del fatto per cui la gara in esame non rappresenta la “inevitabile ed ineluttabile conseguenza” dell’ordinanza del Commissario “senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” si ricaverebbe dal fatto che, astrattamente, l’impianto in esame avrebbe potuto essere realizzato anche in economia o tramite società in house.
Ad avviso del Collegio, tale assunto, per quanto suggestivo, non è idoneo a sostenere la tesi che Ama s.p.a. intenderebbe far valere, posto che, senza il PAUR, non vi sarebbe alcuna attività da affidare né mendiate gara, né ricorrendo all’istituto dell’in house ovvero alla realizzazione dell’impianto in economia.
Ciò in quanto “la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione per un anno” (oggetto della gara gestita da Invitalia) è, come detto, un’attività necessariamente conseguente all’approvazione del PAUR stesso.
1.5. Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, il fatto che il bando sia stato indetto da Invitalia, non trattandosi di soggetto terzo, come affermato dal giudice di prime cure, bensì di soggetto delegato da Ama s.p.a. a svolgere la procedura di gara.
1.6 Per le ragioni indicate, i ricorsi di primo grado, diversamente da quanto statuito nella decisione impugnata, avrebbero dunque dovuto essere ritenuti procedibili.
1.7 L’accoglimento del motivo comporta., come logica conseguenza, la non rilevanza della questione pregiudiziale che la parte ha chiesto, dichiaratamente in via subordinata, di sollevare avanti la Corte di Giustizia dell’Unione, questione peraltro prospettata in termini assolutamente generici (cfr. sopra § 1.2).
2. Nondimeno, come si avrà modo di argomentate nel prosieguo, i ricorsi sono infondati nel merito, ciò che consente al Collegio di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito riproposte, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., da Ama nel giudizio di appello (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione 27 aprile 2015, n. 5).
3. Tanto premesso, con il secondo mezzo di gravame gli appellanti lamentano la illegittimità dell’ordinanza impugnata, atteso che con essa si sarebbe disposta una modifica sostanziale (mediante l’aggiunta di una nuova sezione anaerobica di trattamento di fanghi e produzione di biogas) all’impianto originariamente autorizzato (con determinazione G 09974 del 30 agosto 2020 dalla Regione Lazio) in contrasto con quanto, invece, precedentemente previsto dalla stessa Regione Lazio, che, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, aveva escluso la possibilità di riconvertire l’impianto di compostaggio aerobico in anaerobico.
Ad avviso degli appellanti, il Commissario straordinario, con l’adozione della predetta ordinanza avrebbe, in assenza di adeguata motivazione, autorizzato un impianto “più impattante” rispetto a quello originariamente previsto dalla Regione.
3.1. Il motivo non è fondato.
È, preliminarmente, infondata la premessa da cui muove la parte appellante nel motivo in esame, posto che, come si desume chiaramente dal contenuto dell’ordinanza contestata, il PAUR in esame non ha autorizzato una “riconversione” dell’impianto, ma, più limitatamente, ha autorizzato l’introduzione di una sezione di digestione anaerobica della FORSU a monte dell’impianto di trattamento aerobico di compostaggio già autorizzato. Ciò attraverso un “impianto integrato”, il quale costituisce una “modifica sostanziale del progetto approvato con determinazione n. G09974 del 30 agosto 2020 della Regione Lazio”.
3.2. Tanto premesso, in senso contrario rispetto alla prospettazione della parte appellante è agevole osservare come gli usi produttivi dell’impianto in esame non differiscono da quelli di cui al progetto precedentemente autorizzato dalla Regione Lazio.
Peraltro, trattandosi di prescrizione rilasciata all’interno di un’autorizzazione, l’impianto realizzato sulla base dell’ultima autorizzazione concessa non potrà essere modificato se non a seguito di rilascio di nuova, specifica autorizzazione.
3.3. Parimenti infondato è l’assunto della parte appellante, secondo cui l’impianto previsto dal progetto risulterebbe “più impattante”.
In senso contrario, rileva il Collegio che la l’introduzione della sezione anaerobica non determina di per sé, un maggiore impatto o una maggiore pericolosità. Al contrario, essa costituisce una delle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, come si ricava dalla decisione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147 (cfr. par. 3.3.).
Ciò avuto riguardo anche al fatto che la fase anaerobica non risulta rilevante ai fini dell’impatto dell’impianto, trattandosi di una fase che avviene interamente al chiuso in assenza di ossigeno, durante la quale si produce biogas da utilizzare per scopi energetici.
Al contrario, l’implementazione della sezione anaerobica comporta diversi benefici.
Tale sezione genera infatti la produzione di circa 16.500.000 Nm3/a di biogas corrispondenti a circa 9.075.000 Nm3/di biometano, da cui si ricava la produzione di circa 37.000.000 KWh/a di energia elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 8.399.000 kg/anno, secondo il rapporto di 227 g CO2eq/kWh tra il totale delle emissioni e la produzione complessiva di unità di energia.
3.4. La conclusione in esame trova riscontro nel fatto che il ricorso a impianti di tipo anaerobico anziché aerobico è incentivato sia dalla normativa eurounitaria, sia da quella nazionale, al fine di favorire il recupero di energia dai rifiuti con la produzione di biogas.
In tal senso, assumono rilievo:
i) la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI), che, al punto 111, : “raccomanda di sostenere lo sviluppo di catene del valore locali basate sul riciclaggio dei rifiuti organici per la produzione di energia rinnovabile, come il biometano, per creare legami più stretti tra le comunità rurali e urbane, attuando pienamente nel contempo la gerarchia dei rifiuti;”
ii) il PNGR che, al paragrafo 1.6, recante “Valutazioni gestionali generali a supporto del Programma, criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali” riporta come: “L'analisi condotta sui rifiuti urbani ha permesso di rilevare che le realtà associate al maggior rendimento ambientale, cioè a minori potenziali impatti, presentano un sistema di gestione rifiuti caratterizzato dai seguenti elementi: […] 7 - presenza di impianti di digestione anaerobica o di tipo integrato aerobico/anerobico che, rispetto al compostaggio delle frazioni organiche, permette anche il recupero di energia dalle frazioni organiche da raccolta differenziata, in particolare con recupero di biometano; […]”
iii) analogamente orientati sono il Rapporto UTILITALIA sulla “Gestione dei Rifiuti Urbani- Scenari di sviluppo infrastrutturale: comparazione del rendimento ambientale” e il Rapporto “Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities” della European Environment Agency.
Di qui l’infondatezza del motivo esaminato.
4. Con un terzo mezzo di gravame gli appellanti censurano l’ordinanza impugnata nella parte in cui, anche alla luce della direttiva 2011/92 (modificata dalla direttiva 2014/52), non avrebbe considerato l’impatto dell’impianto sull’ambiente, con riferimento, in particolare, ai seguenti profili relativi:
i) alla localizzazione dell’impianto e alle alternative al progetto;
ii) al rischio incidenti, in relazione al quale si assume “che l’impianto produrrà biogas (materiale infiammabile riportato al punto 18 dell’allegato I parte 2 della direttiva 2012/18 UE), trasformato in biometano e che a Cesano è ubicato il più grande deposito nazionale di scorie radioattive, era doveroso verificare: a) l’impatto derivante dalla vulnerabilità del progetto a rischi di incidenti e/o calamità (cfr. art. 3 II comma della direttiva 2011/92) b) se il progetto ricada o meno in un’attività esposta a rischio di incidente rilevante”;
iii) al fatto che il commissario ha escluso che l’impianto in esame sia soggetto alla normativa in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III) “ponendo alla base di tale valutazione i soli quantitativi di biometano stoccati nell’impianto, senza considerare che l’impianto effettua anche la produzione di biogas, che è materiale esplosivo ed infiammabile”;
iv) all’impatto cumulativo.
4.1. In particolare, ad avviso della parte appellante, a seguito della modifica sostanziale dell’impianto, la proponente avrebbe dovuto fornire, ai sensi dell'art.5, primo comma, della Direttiva 2011/92, i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sul contesto ambientale di Cesano (già gravato dalla presenza di numerosi stabilimenti, tra cui il più particolare e pericoloso era il Centro ricerche ENEA Casaccia, impianto a rischio di incidente rilevante di grandi dimensioni), effettuando una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame (compresa quella di non provvedere alla modifica dell'impianto già autorizzato), con indicazione delle ragioni della scelta di trasformare l'impianto di compostaggio in un biodigestore, il quale prevede la produzione di biogas e biometano e quindi una tecnologia molto più complessa ed inquinante
4.2. Il motivo non è fondato.
In via preliminare, rileva il Collegio che la scelta di modificare il progetto del 2020 da impianto di compostaggio a biodigestore è stata effettuata nel quadro del PGR di Roma Capitale, al precipuo fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti.
In tale contesto, non essendo stato realizzato il progetto del 2020, Ama s.p.a ha ritenuto di valutare gli impatti ambientali considerando come scenario di base lo stato attuale dell’ambiente in conformità a quanto stabilito nell’Allegato IV, punto 3 della Direttiva VIA, a mente del quale il progetto deve contenere, tra l’altro: “Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.”.
4.3. Tanto premesso, diversamente da quanto, peraltro genericamente, dedotto dalla parte appellante, i relativi studi sono stati svolti dagli Enti competenti. In particolare, la Città Metropolitana ha redatto la cartografia delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti dalla quale è emersa l’idoneità dell’area in esame alla localizzazione dell’impianto.
A risultati convergenti è giunta la sintesi dello Studio di impatto ambientale secondo cui “Le analisi effettuate nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale hanno preso in considerazione tutti i possibili effetti e impatti indotti dalla presenza dell’impianto, e […] hanno portato a concludere per una sostanziale compatibilità dello stesso con il territorio coinvolto. La localizzazione proposta appare inoltre del tutto coerente con i criteri di localizzazione proposti dal Piano Regionale dei Rifiuti del Lazio” (cfr. pag. 12 Sintesi non tecnica – Studio di impatto ambientale).
La positiva conclusione della procedura VAS e l’approvazione del PGR-RC hanno confermato la positiva localizzazione dell’impianto di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che la digestione anaerobica, come si è già avuto modo di osservare in occasione dell’esame del secondo motivo di appello, ha un rendimento ambientale migliore del compostaggio e, quindi, contribuisce nel complesso a migliorare sotto tale profilo, la compatibilità dell’impianto stesso.
Un’ulteriore conferma di queste conclusioni si desume dalle analisi di dettaglio svolte nel corso dell’espletamento della fase di VIA, durante la quale sono state ascoltate, valutate e riscontrate tutte le osservazioni pervenute, che hanno confermato l’idoneità del sito per la realizzazione dell’impianto di trattamento integrato.
4.6. Analoghe considerazioni si impongono in relazione al paventato rischio incidenti, atteso che, come si ricava dall’allegato 1 all’ordinanza impugnata, tale profilo è stato oggetto di apposita istruttoria, all’esito della quale è stato rilevato che “L’impianto in progetto non è soggetto alla normativa in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (D. Lgs. 105/2015) in quanto, in base alle capacità di stoccaggio 15 complessiva del biometano liquido (100.000 litri), classificato al punto 18 dell’Allegato I, Parte 2 al D. Lgs. 105/2015 come “Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL)” è minore della soglia inferiore per tali sostanze, fissata pari a 50 tonnellate, assumendo una densità del biometano liquido pari a 0,45 kg/l (equiparato a GNL)” (pag. 23 del doc. 22.8 dei ricorrenti).
Peraltro, nel corso della fase istruttoria, dall’analisi della documentazione progettuale allegata dalla società proponente non è emersa alcuna evidenza in ordine alla possibilità che nello stabilimento potessero essere detenute quantità di sostanze pericolose superiori alle soglie di cui al citato D. Lgs. n. 105/2015.
4.7. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel presente motivo di appello, l’impianto autorizzato non prevede una “sezione di incenerimento”.
Come, infatti, riportato alle pagine 14 e 15 del parere tecnico-istruttorio (Allegato I all’Ordinanza n. 2023/0000031 del 7 dicembre 2023), le sezioni dell’impianto sono costituite da:
i)sezione di pretrattamento della FORSU;
ii)sezione di produzione di biogas da digestione anaerobica;
iii)sezione di separazione solidi del digestato;
iv)sezione di trattamento aerobico del digestato solido con produzione di Ammendante Compostato Misto;
v)sezione di trattamento digestato liquido.
Ne discende che tutto il volume del digestore è destinato al contenimento della FORSU, mentre per la funzione di stoccaggio il progetto prevede uno specifico accumulo.
4.8. Infine, quanto all’asserita omessa valutazione di un “impatto cumulativo”, occorre in senso contrario rilevare che la stima degli impatti sulle diverse matrici ambientali è stata effettuata sulla base della caratterizzazione dello “stato attuale dell’ambiente”( conformemente al punto 3 dell’Allegato IV alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE) che rappresenta la sommatoria di tutte le pressioni ambientali risultanti dalle diverse “determinanti” (attività antropiche) presenti in una determinata area.
In particolare, tale profili sono stati verificati nello Studio di impatto ambientale, ove si riporta che “Nella località di Casaccia, sulla strada per Anguillara Sabazia, si trova il Centro ricerche Casaccia dell'ENEA che occupa un’area complessiva di 90 ettari, suddivisa in due aree separate dalla via Anguillarese. Di fronte al sito di progetto si trova infine una vasta area occupata dalle attrezzature della Radio Vaticana e dalla parte opposta, a qualche centinaio di metri il depuratore COBIS che serve tutti i Comuni dell’area” (cfr. pag. 11 Sintesi non tecnica – Studio di impatto ambientale).
Il profilo in esame risulta, inoltre, preso in considerazione anche nell’allegato 1 all’ordinanza, in cui si riporta che “Né l’ENEA né Radio Vaticana hanno espresso osservazioni nell’ambito del procedimento in corso. Inoltre, si sottolinea che le osservazioni indicate sono già state valutate nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ad oggi conclusa. Ciò premesso, in relazione alla prescrizione n. 8 del provvedimento di VIA relativo all’impianto di produzione di compost (provvedimento di VIA, Determinazione Dirigenziale n. G08169 del 10 luglio 2020) si evidenzia che la Prefettura di Roma è stata coinvolta nel procedimento in corso sin dalla sua attivazione e non ha mai espresso osservazioni né segnalato eventuali criticità in merito al piano di emergenza relativo agli impianti nucleari e depositi di rifiuti radioattivi del Centro ENEA”.
Alla luce delle osservazioni che precedono, anche il terzo motivo di appello è, dunque, infondato.
5. Con il quarto mezzo di impugnazione la parte appellante lamenta la illegittimità del PAUR in esame per omessa valutazione dell’impatto su “aria”, “acque superficiali”, “acque profonde” e “biodiversità”.
5.1. In particolare, con riferimento all’impatto “sull’aria”, gli appellanti sostengono che gli atti impugnati sarebbero illegittimi sotto due diversi profili: il primo, riguardante la mancata valutazione sulla matrice aria rispetto all’impianto di compostaggio; il secondo, discendente dall’impatto derivante dalla ingente emissione di Co2 in atmosfera determinata dall’impianto.
5.1.1 In relazione al primo profilo, assumono gli appellanti che la scelta di incrementare la capacità di trattamento e quella di adottare la tecnologia della digestione anaerobica comporterebbero un aggravio pesantissimo per il territorio in termini di inquinanti e di unità odorigene emessi, con conseguente negativo impatto sulla qualità dell’aria.
Sotto un concorrente profilo, la parte appellante ripropone le censure formulate con i motivi aggiunti al ricorso principale di primo grado recante RG n. 2024/2231, lamentando il fatto che Ama s.p.a. avrebbe modificato il progetto posto a base di gara rispetto a quello approvato con il provvedimento impugnato. In particolare, nella prospettiva in esame, Ama s.p.a avrebbe escluso la possibilità “per il pubblico interessato” “di poter presentare osservazioni e partecipare alla decisione ambientale in evidente dispregio della Convenzione di Aarhus che il Commissario dovrebbe applicare”.
Inoltre, Ama s.p.a. avrebbe unilateralmente modificato il progetto di cui trattasi senza sottoporlo nemmeno alla valutazione del Commissario o di altro Ente.
5.1.2. In relazione al secondo aspetto sopra menzionato, gli appellanti sostengono che Ama s.p.a. avrebbe unilateralmente inserito una linea di liquefazione della CO2, con recupero per uso alimentare, al fine di sostituire le emissioni di CO2 in atmosfera, senza sottoporla ad alcuna amministrazione pubblica ai fini di una sua valutazione.
In particolare, rispetto a tale modifica non sarebbero stati esaminati gli impatti ambientale e sanitario determinati dalla linea di liquefazione della CO2, né valutato se tale sostituzione fosse preferibile rispetto alla precedente proposta progettuale, in termini di impatti e sostenibilità.
5.1.3. la Parte appellante censura, inoltre, la, a suo dire, unilaterale sostituzione dell’impianto di liquefazione del biometano con un impianto di compressione e raffreddamento del biometano gassoso e con l’introduzione di una stazione di rifornimento carri bombolai.
Anche in relazione a quest’ultima modifica, si assume che “il Commissario non ha potuto infatti valutare i diversi impatti che tale modifica progettuale è suscettibile di determinare e la loro sostenibilità”.
Sul piano degli effetti, tale ultima modifica impatterebbe negativamente sull’ambiente attesa la “necessità di movimentare un volume di gas almeno 3 volte superiore a quello liquefatto (a parità di produzione annua) con tutti i rischi di incidente – non valutati- connessi a tale movimentazione ed agli effetti negativi ambientali determinati dall’aumento del traffico e delle relative emissioni”.
5.1.4. Infine, gli appellanti assumono che “Il PAUR non considera infine l’impatto sull’aria derivante da condizioni di funzionamento anomale, durante le quali il biogas sarà inviato in atmosfera previa combustione nelle torce di emergenza”.
In particolare, nella prospettiva in esame, “La possibilità di derogare ai valori limite per meno di 500 ore/anno, secondo i criteri stabiliti dal vigente Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, non esimeva tuttavia il Commissario dal valutare l’impatto determinato anche da tali 500 ore/ anno nello studio di dispersione”.
5.1.5. Sempre con riferimento, all’impatto sull’ “aria” viene censurata la carenza istruttoria con riferimento alla caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria locale in ragione della esiguità dei dati di riferimento presi in considerazione e della breve durata della campagna di monitoraggio.
5.1.6. Infine, vengono dedotte problematiche di funzionamento delle c.d. “torce di emergenza”, riguardano: a) la mancata valutazione, nell’ambito del SIA, del potenziale impatto sulla matrice “aria” connesso alle “condizioni di funzionamento anomale” durante le quali il biogas viene bruciato in torcia di emergenza; b) il mancato rispetto da parte del progetto delle BAT 15 e 16 riportate nella DE 2018/1147.
5.2. In relazione all’impatto sulle “acque superficiali”, gli appellanti sostengono anzitutto che “Per il funzionamento dell’impianto di depurazione, l’ARPA non solo aveva imposto il divieto di utilizzare alcuni CER tra cui il 10 12 13 (doc. 15, pag. 8) a causa delle ripercussioni ambientali che l’utilizzo di tale rifiuto può comportare, ma aveva richiesto al gestore di chiarire meglio l’assetto tecnologico e gestionale “al fine di prevedere adeguate modalità di monitoraggio e controllo, nonché identificare i pozzetti di prelievo” e di specificare “gli obiettivi della depurazione” .
5.2.1. Gli appellanti sostengono, inoltre, che dall’impianto in esame deriverebbe un ulteriore deterioramento della qualità del fiume Arrone.
5.2.3. Con specifico riguardo al codice EER 10 12 13, lamentano che la prescrizione n. 3 non recepirebbe l’indicazione del D.P.A., lasciando aperta la possibilità di utilizzo di detto codice.
5.2.4. Inoltre, in contrasto con quanto prescritto dall’ARPA (doc. 15, pag. 21), la prescrizione 44 non prescriverebbe obiettivi di depurazione e, di conseguenza, non assicurerebbe il raggiungimento dell’obiettivo della qualità dei corpi idrici.
5.3. Con riferimento al parametro delle “acque profonde”, gli appellanti lamentano il fatto che il provvedimento impugnato non ne avrebbe valutato l’impatto.
5.4. Infine, con riferimento all’impatto sulla “biodiversità”, gli appellanti censurano la “mancata valutazione dell’impatto ambientale e dell’incidenza sulle aree naturali determinato dall’impianto in violazione dell’art. 3, I comma, lett. b), della direttiva 2011/92”, alla luce del fatto che l’impianto “preleverà tramite pozzo il 58 per cento del fabbisogno idrico necessario al suo funzionamento”.
Di qui la conclusione per cui l'impatto ambientale non risulterebbe individuato.
5.5. Il motivo, complessivamente formulato non è fondato per le ragioni che seguono.
5.5.1. Con riferimento all’impatto sull’aria, il Collegio rileva che, diversamente da quanto ritenuto nel presente motivo di appello, a fronte del medesimo quantitativo di rifiuti organici, l’implementazione della sezione anaerobica non muta l’impatto emissivo in atmosfera in quanto il ricambio dell’aria riguarda esclusivamente gli edifici destinati al trattamento aerobico (compostaggio).
Dal che discende che i volumi di rifiuti restano invariati.
In tal senso appare decisiva la circostanza, non considerata dagli appellanti, che, nel progetto posto a base di gara, Ama s.p.a. ha previsto il totale recupero della CO2 e la sua commercializzazione in linea con gli indirizzi della direttiva comunitaria sull’economia circolare.
Inoltre, come in parte già si è avuto modo di rilevare, dal confronto, in termini di impatto ambientale, tra il funzionamento di una piattaforma di trattamento aerobico (solo compostaggio) e di una piattaforma di trattamento anaerobico-aerobico (produzione di una fonte energetica e compostaggio) emerge che quest’ultima comporta un impatto molto minore sotto il profilo odorigeno. Infatti, il compostaggio aerobico consiste in un processo di degradazione della sostanza organica condotto in presenza di ossigeno che si realizza in capannoni chiusi dai quali è necessario estrarre l’aria, carica di composti odorigeni, da avviare al trattamento delle arie esauste. Le arie maleodoranti derivanti dal trattamento risultano dunque “cariche” di composti odorigeni in quanto il processo di degradazione avviene tutto in un’unica fase. La digestione anaerobica è, al contrario, un processo di degradazione della sostanza organica condotto in assenza di ossigeno, il quale si realizza quindi in reattori chiusi (digestori) e porta alla trasformazione del materiale biodegradabile in biogas e digestato. Avendo già subito una fase di degradazione biologica, il digestato presenta un minore impatto odorigeno. Pertanto, la successiva fase aerobica presenta un impatto minore in quanto effettuata in presenza di una matrice (digestato) che ha già subito rilevanti processi di degradazione.
5.5.2. Con riferimento all’impatto derivante dall’emissione di CO2, occorre rilevare che è previsto espressamente che, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente individui possibili soluzioni tecnologiche che consentano di valorizzare i notevoli quantitativi di CO2 prodotta dal processo di upgrading del biogas, in un’ottica di economia circolare oltre che per la riduzione delle emissioni, ovvero adeguate misure che possano compensare le medesime.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, il progetto autorizzato con l’ordinanza impugnata è già stato definito puntualmente, essendo stata demandata alla successiva fase di esecuzione solo l’enucleazione di profili meramente operativi/tecnici e di dettaglio, inerenti all’attuazione del progetto e, in quanto tali, da definirsi all’esito dell’aggiudicazione della gara volta all’individuazione dell’operatore per la realizzazione e gestione dell’impianto.
È ciò sulla base della logica premessa per cui alcuni aspetti meramente operativi o tecnici possono essere definiti solo una volta individuato l’aggiudicatario, anche in considerazione del fatto che essi attengono a profili oggetto del confronto competitivo e su cui i concorrenti saranno chiamati a offrire le proprie soluzioni.
Alla luce di tale rilievo appare inconferente la giurisprudenza citata dall’appellante alla pagina 22 dell’atto di appello, concernendo fattispecie in alcun modo sovrapponibili a quella in esame, e segnatamente un’autorizzazione a “perturbare un certo numero di specie animali e vegetali protette nonché a degradare o a distruggere talune zone del loro habitat naturale rispettivo, in relazione al progetto di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione di attuare una serie di misure di mitigazione” ovvero il caso di procedimenti relativi a piani e programmi diversi e, segnatamente, se “l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/4/CE implichi che la nozione di “piani e programmi (…) nonché le loro modifiche (…) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale (…)” includa un piano o un programma elaborato e/o adottato congiuntamente da un’autorità a livello locale e da un committente del settore privato quale proprietario di terreni adiacenti a quelli di proprietà di un’autorità locale”.
5.5.3. Infondato è anche il sub-motivo con il quale la parte appellante ripropone nel giudizio di appello le censure formulate con i motivi aggiunti al ricorso di prime cure, e segnatamente quella secondo cui Ama s.p.a. avrebbe modificato il progetto posto a base di gara rispetto a quello approvato con il provvedimento impugnato senza averlo previamente sottoposto alla valutazione dell’amministrazione.
In particolare, assume la parte appellante che Ama avrebbe “unilateralmente modificato il progetto oggetto del provvedimento impugnato, senza sottoporlo nemmeno a valutazione da parte del Commissario o di altro ente”.
Tale sub-motivo è infondato alla luce del fatto che il Codice dell’ambiente non impone la rinnovazione delle autorizzazioni per ogni modifica progettuale, ma solo in caso di modifiche sostanziali.
Infatti, soltanto nel caso di variazioni sostanziali che portino ad un progetto sensibilmente diverso occorre procedere alla acquisizione di una nuova VIA, pena l'elusione del giudizio di compatibilità ambientale.
In tal senso risulta orientata anche la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui “la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato” (ex multis, Cons. St., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142).
Alla luce di tale orientamento, reputa il Collegio che, non integrando quelle censurate modifiche sostanziali, esse non avrebbero dovuto sottostare a un’ulteriore autorizzazione/valutazione da parte dell’amministrazione.
I due progetti presentano, infatti, le medesime caratteristiche e soluzioni tecniche di fondo, le quali sono state solo ottimizzate nel progetto posto a base di gara, anche al fine di determinarne un miglioramento sotto il profilo del complessivo impatto ambientale.
L’assunto trova conferma nella stessa relazione (alla pagina 13) allegata al bando per la realizzazione dell’impianto prodotta dagli stessi appellanti, ove si chiarisce che: “1. Per detta tipologia di impianto, ai sensi dell’art. 5 lettera l-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modifiche proposte non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e, con riferimento non hanno come effetto l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima 2 Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell’Allegato III alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. né al punto zb) dell’Allegato IV alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii 3 Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 14 dell’art. 15 della Legge Regionale 27/98 e s.m.i 4 Non comportano l’avvio, all’interno del complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.; 5 Non comportano la modifica dei codici CER in ingresso 6 Non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle 22 già autorizzate 7 Non sono peggiorative in quanto non comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose 8 Non comportano nuovi punti emissivi in atmosfera rispetto a quelli già autorizzati, comporteranno, all'opposto, un punto di emissione in meno grazie al recupero della CO2 9 Non comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. in particolare delle emissioni in atmosfera in termini di flusso di massa complessivo 10 Non comportano una variazione qualitativa delle emissioni in aria e in acqua 11 Non comportano nuovi scarichi idrici; ci sarà un risparmio nell’utilizzo delle risorse e una diminuzione degli scarichi in acque superficiali 12 non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno del perimetro dell’impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06”.
5.5.4. Infondata è anche la censura relativa alla produzione di CO2.
È, in particolare, infondata la premessa da cui la parte appellante trae le mosse per argomentare la censura in esame.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, infatti, la stessa ordinanza commissariale prevedeva già tale modifica, il che priva di fondamento la tesi per cui essa avrebbe dovuto essere oggetto di una ulteriore valutazione da parte della stessa amministrazione.
Di qui l’infondatezza dell’assunto secondo cui si tratterebbe di una modifica decisa unilateralmente da Ama s.p.a.
Tale conclusione trova riscontro nella relazione tecnica di Ama s.p.a. ove si chiarisce che la modifica era stata chiesta in sede di autorizzazione.
5.5.5. Né miglior sorte può avere la censura secondo la quale, in tal modo operando, Ama s.p.a. avrebbe escluso la possibilità “per il pubblico interessato” “di poter presentare osservazioni e partecipare alla decisione ambientale in evidente dispregio della Convenzione di Aarhus che il Commissario dovrebbe applicare”, atteso che gli appellanti non indicano quali osservazioni sarebbero state presentate e come queste avrebbero potuto consentire una diversa soluzione , né indicano con quale diversa soluzione avrebbe dovuto essere attuata la richiesta del commissario in relazione alle emissioni di CO2.
Più in radice, il Collegio rileva che anche tale modifica comporta diversi benefici a livello ambientale, in quanto mentre nella versione precedente del progetto era previsto che le emissioni di CO2 venissero rilasciate in atmosfera, in quella oggetto di modifica queste ultime vengono recuperate e riutilizzate, azzerando quindi le emissioni dalla sezione di upgrading.
Ne costituisce una riprova il fatto che, nel progetto a base di gara, il bilancio complessivo dell’emissione di CO2 nell’impianto risulta significativamente ridotto rispetto a quello della versione originaria del progetto.
5.5.6. Parimenti infondate sono le prospettazioni della parte appellante relative all’impianto di compressione e raffreddamento.
In senso contrario, occorre rilevare che anche la modifica in esame determina, in realtà, una riduzione dell’impatto ambientale dell’impianto. La stessa, infatti, non comporta lo svolgimento di nuove attività, ma al contrario la loro diminuzione, con la conseguente eliminazione dei possibili elementi di rischio. L’impianto di compressione e raffreddamento consente, infatti, di eliminare lo stoccaggio di rilevanti quantitativi di biogas, previsto dalla soluzione originaria, il quale poteva costituire un fattore di pericolosità.
Peraltro, trattandosi di attività espletate nell’impianto, la stessa non potrebbe, in ogni caso, essere considerata come sostanziale, tenuto conto della definizione data dall’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006, secondo la quale una modifica può ritenersi sostanziale solo nei casi di variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto.
5.5.7. Del tutto generica, e come tale inammissibile, è la censura relativa all’impatto sull’aria derivante da condizioni di funzionamento anomale, durante le quali il biogas sarà inviato in atmosfera previa combustione nelle torce di emergenza.
Non viene, infatti, chiarita quale disposizione del d.lgs. n. 155/2010 sarebbe nel caso in esame, violata.
5.5.8. Non coglie nel segno neanche la censura relativa all’asserita carenza di istruttoria in relazione alla caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria locale, in ragione della esiguità dei dati di riferimento presi in considerazione, e della breve durata della campagna di monitoraggio.
In senso contrario, è sufficiente rilevare che, nell’ambito del procedimento istruttorio, la società proponente ha fornito uno studio integrativo di caratterizzazione del fondo ambientale vista la nuova possibilità di disporre di dati da parte di ARPA Lazio (riferiti all’anno 2022) relativi ai campi di concentrazione nel dominio di calcolo, così come previsto all’Allegato 2 – Procedura Tecnica n. 2 (“Linee Guida per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria dei punti di emissione di un impianto”) delle NTA del PRQA della Regione Lazio (DCR n.8/2022). Tali dati hanno consentito di definire il “fondo” ambientale (situazione “ante operam”) in cui si collocherà l’impianto in esame, che consente di tener conto anche del contributo correlato alla preesistenza nell’area di altri impianti/attività. Diversamente da quanto affermato dalla parte appellante, detto fondo ambientale è stato utilizzato per giungere ad una caratterizzazione più verosimile possibile dello stato della qualità dell’aria locale a impianto realizzato.
5.5.9. Infondata si rivela, inoltre, la prospettazione secondo cui l’uso della torcia “confligge, con alta probabilità, con gli standard di qualità dell’aria”.
In senso contrario, occorre in primo luogo premettere che, per la tipologia di impianto progettato (Impianto di trattamento integrato, anche “I.T.I.”), di regola non viene effettuata la valutazione di impatto sulla matrice aria delle torce di emergenza, stante il ridotto e discontinuo numero di ore di funzionamento, nonché l’esigua entità dei volumi di biogas combusti. Trattandosi di dispositivi di emergenza, non è possibile prevedere a priori il numero di accensioni giornaliere, né la durata del loro eventuale funzionamento.
Tanto premesso, la prospettazione della parte appellante trova una netta smentita nell’Allegato 2 dell’OCG n. 31/2023, la cui prescrizione n. 32, lettera a), stabilisce: “in conformità a quanto previsto dalla BAT 15, la combustione in torcia è consentita esclusivamente per ragioni di sicurezza (condizioni di emergenza e pre-emergenza) o in condizioni operative straordinarie: durante le operazioni di avvio, arresto, surplus di produzione di biogas rispetto a quella con cui è possibile alimentare il motore cogenerativo, in caso di fermo motore prolungato per guasti o attività di manutenzione straordinaria su di esso. È escluso l’utilizzo della torcia per la combustione di biometano fuori specifica.”.
Inoltre, secondo la lettera c) della medesima prescrizione n. 32, aggiunge che: “le torce dovranno soddisfare i criteri costruttivi e prestazionali, nonché attenersi alle 500 ore/anno di funzionamento di cui al comma 7 dell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRQA (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022). In caso di superamento delle 500 ore/anno di funzionamento, il Gestore dovrà darne immediata notifica alla Autorità Competente e ad ARPA”.
5.5.8. Infondate sono, inoltre, le censure relative all’impatto sulle “acque superficiali”, con le quali la parte appellante si duole della carente istruttoria in punto di tutela dei corpi idrici superficiali, sotto lo specifico profilo dell’omessa valutazione dell’“effetto cumulativo” rispetto allo scarico del depuratore.
Con specifico riguardo al codice EER 10 12 13, gli appellanti, come anticipato, lamentano che la prescrizione n. 3 non recepirebbe l’indicazione del D.P.A., lasciando aperta la possibilità di utilizzo di detto codice.
La prospettazione della parte appellante non trova corrispondenza nelle risultanze procedimentali.
I soli codici EER autorizzati in ingresso all’impianto – e non altri – sono quelli espressamente indicati nelle disposizioni n. 2) e n. 3) dell’AIA (pagine 48 e 49), nelle quali non figura il codice EER 10 12 13.
Ne consegue che correttamente detto codice non è stato oggetto di valutazione nel procedimento di AIA in quanto il Gestore aveva già rinunciato al suo utilizzo, come comunicato dallo stesso con l’integrazione trasmessa il giorno 15 settembre 2023 recante “Riscontro nota ARPA Lazio - 19 Dipartimento pressioni sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori nota n. 11/08/20230056514.U”, nella quale si dà atto che
“Il rifiuto EER 10 12 13 è stato erroneamente inserito tra gli inoculi freschi da destinare all’impianto di depurazione delle acque e ai digestori della sezione anaerobica. Si precisa pertanto che non è da considerare tra i rifiuti in ingresso, in quanto non necessario al fine delle attività di recupero dell’impianto, e quindi tutta la documentazione (Piano di Monitoraggio e Controllo “AMACE Scheda E” e AMACE R2 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare”) è stata aggiornata in tal senso.”.
Come indicato nel documento citato, il Gestore ha poi presentato il documento di progetto “AMACE R2 – Allegato C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare - Revisione settembre 2023” nel quale il codice EER 10 12 13 non era presente nell’elenco dei codici per i quali era richiesta l’autorizzazione. Anche dalla seconda Tabella del paragrafo 1.4 “Rifiuti in ingresso e operazioni di recupero” dell’AIA, nel quale detto codice non figura, si evince che l’impiego del codice EER 10 12 13 era stato escluso dal Gestore.
Diverso è il divieto di utilizzo di specifici codici EER, espressamente riportato nella prescrizione n. 3) dell’AIA, nella quale, coerentemente con quanto indicato da ARPA Lazio, il divieto al Gestore è stato messo per iscritto in quanto i codici vietati erano stati proposti per consentire un’attività di trattamento rifiuti non compresa tra quelle oggetto dell’autorizzazione.
Pertanto, in tal modo, è stata implicitamente vietata anche l’attività per la quale il Gestore intendeva ottenere l’autorizzazione, come emerge dalla citata prescrizione, secondo cui: “3) Non è autorizzato l’utilizzo dei rifiuti aventi codici CER 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 e 19 08 05 per la fase di avvio e messa a regime dell’impianto biologico di trattamento acque o in caso di necessità operativa come proposto dal Gestore, in quanto tale attività si configurerebbe come un’ulteriore attività di trattamento rifiuti non oggetto della modifica impiantistica proposta.”.
5.5.9.A differenza di quanto sostengono gli appellanti, inoltre, la prescrizione 44 non determina alcuna elusione dell’obiettivo della qualità dei corpi idrici.
Ciò si desume pianamente dal tenore della prescrizione in esame, secondo cui: “Il Gestore dovrà fornire l’assetto tecnologico e gestionale definitivo in entrata e in uscita dall’impianto di trattamento acque risolvendo le incongruenze registrate nella documentazione presentata. A tale riguardo, in linea con l’aggiornamento presentato della Tavola “AMACE G13 –Diagramma tecnologico”, il Gestore dovrà presentare entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’aggiornamento della Tavola “AMACE G14- Flow Chart processo produttivo”, specificando i percorsi e gli stoccaggi dei singoli flussi di permeato e concentrato risultanti da ogni fase di trattamento e della Tavola “AMACE G09 – Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica”, aggiornata agli scarichi e relativi pozzetti di controllo autorizzati”.
Più in generale, ricorda il Collegio che la materia in esame è governata dal principio di precauzione il cui fondamento concettuale viene comunemente ricondotto al principio del cosiddetto maximin, in base al quale, quando si tratta di assumere una decisione in condizioni di incertezza, le scelte devono essere valutate tenendo conto del peggior scenario possibile in termini di possibili conseguenze.
Da ciò consegue che, in nome dell’idea di precauzione, l’intervento preventivo non può attendere l’inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche “attualmente” e “progressivamente” disponibili.
Allo stesso tempo, la valutazione scientifica deve fondarsi su dati scientifici affidabili e su un ragionamento logico che porti ad una conclusione, la quale esprima la possibilità del verificarsi e l’eventuale gravità del pericolo sull’ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati, mentre nel caso in esame le prospettazioni della parte appellante intregnano, al più, delle mere illazioni prive di solide basi anche sul piano meramente empirico.
5.5.10. Nemmeno può essere condivisa la censura con la quale la parte appellante assume che dall’impianto in esame deriverebbe un ulteriore deterioramento della qualità del fiume Arrone.
In senso contrario si rileva che, come riportato nella Sintesi non tecnica relativa allo Studio di impatto ambientale, “Le acque di scarico ed i digestati saranno sottoposte ad un trattamento molto spinto prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale costituito dal fiume Arrone. Lo scarico massimo previsto dal progetto risulta pari a 163.225 t annue, circa 453 t/giorno; i quantitativi corrispondono al 2% dello scarico giornaliero del vicino depuratore COBIS, che scarica nel Fiume Arnone, circa 18.000 t/giorno”.
Ne consegue che il nuovo progetto determinerà uno scarico nelle acque nettamente inferiore rispetto a quello del vicino depuratore COBIS con una conseguente diminuzione dell’impatto ambientale.
5.5.11. Parimenti infondate sono le censure formulate in relazione al mancato impatto del progetto sulle “acque profonde”.
In senso contrario, occorre considerare che nell’ultima versione del progetto dell’impianto che sarà posta a base di gara è stato previsto un minor consumo di acqua da parte dell’impianto. Ne deriva quindi anche una riduzione dei prelievi di acqua da pozzo e dunque una riduzione dell’impatto dell’impianto.
In ogni caso, trattandosi di aspetti esecutivi, trova in relazione alla fattispecie in esame applicazione la prescrizione 55, secondo la quale “In sede di progettazione esecutiva, il Gestore dovrà presentare una relazione idrogeologica per stabilire, in accordo con ARPA, l’esatta collocazione dei piezometri di monte e di valle rispetto alla direzione di flusso della falda”.
Proprio il confronto con l’ARPA rappresenta, sotto il profilo in esame, una garanzia di in termini di perseguimento dell’interesse pubblico.
5.5.12. E’ parimenti infondata l’affermazione per cui “Sussiste altresì una violazione dell'art. 14 della Direttiva 2010/75 che prevede che debbano essere adottate misure per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti in sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee...”.
In senso contrario, come si riportato nell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 31/2023 da allegato 1, “le aree interessate dalle diverse sezioni impiantistiche, dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei materiali in ingresso/uscita dall’impianto sono impermeabilizzate e collegate alla rete di collettamento e depurazione delle acque, garantendo adeguata prevenzione da fenomeni di potenziale inquinamento delle acque sotterranee, peraltro rinvenibili a profondità significative rispetto al piano campagna.”.
5.5.13. In relazione al controllo delle acque sotterranee, occorre, poi, rilevare, a confutazione della impostazione dell’appellante, che il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale prevede il monitoraggio periodico della qualità delle stesse.
5.5.14. Nemmeno può essere condiviso l’assunto dell’appellante secondo cui “Non è inoltre stato considerato l'impatto cumulativo sulle acque profonde rispetto alle esigenze del Centro ricerche ENEA Casaccia e ciò nonostante, come visto, nelle sue osservazioni al Piano rifiuti, quest'ultimo avesse espresso preoccupazioni proprio con riferimento all'impatto del biodigestore sulle falde e sull'approvvigionamento dell'acqua”.
Contro tale assunto è agevole osservare che l’Ente preposto a valutare gli impatti delle opere di captazione è Roma Capitale legittima al rilascio delle relative concessioni
5.5.15. Infine, infondata è la censura con la quale si lamenta la carente valutazione dell’impatto sulla biodiversità.
In senso contrario, il Collegio rileva che il documento progettuale è stato esaminato, in fase di conferenza dei servizi, dalla competente Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente, la quale, con nota protocollo n. 10233, del 4 gennaio 2023, ha comunicato che non sono ipotizzabili interferenze sui valori ambientali tutelati dai Siti della Rete Natura 2000 e pertanto non ha ritenuto necessaria l’espressione della Valutazione di Incidenza.
In tal senso depone anche l’allegato 1 all’ordinanza impugnata, il quale, al punto “3.5.4 Valutazioni” chiarisce che “Considerata l’assenza di potenziali incidenze sulla ZPS “Comprensorio Bracciano – Martignano” e sugli obiettivi di conservazione, anche in relazione alle misure di conservazione previste dalla D.G.R. Lazio n.612 del 16/12/2011, ed altresì l’assenza di elementi ecosistemici, faunistici e vegetazionali di particolare valenza o di interesse conservazionistico, non si prevedono impatti negativi significativi sulla biodiversità”.
La stessa ordinanza impugnata precisa, inoltre, che “l’Area protezione e gestione della biodiversità della Direzione regionale ambiente, con nota protocollo n. 10233 del 4 gennaio 2023, ha comunicato che non sono ipotizzabili interferenze sui valori ambientali tutelati dai siti della Rete Natura 2000 e pertanto non ha ritenuto necessaria l’espressione della valutazione di incidenza”.
Da quanto riportato emerge che, contrariamente a quanto ritenuto nel presente motivo di appello, l’incidenza sulla biodiversità è stata espressamente considerata nell’ambito del procedimento di cui trattasi.
6. Con il quinto, e ultimo, mezzo di gravame la parte appellante lamenta la circostanza per cui commissario straordinario non avrebbe tenuto conto del parere negativo della Soprintendenza. Pertanto “Del tutto non considerate sono state quindi le criticità sollevate dalla Soprintendenza anche con riferimento all'area di sedime dell’impianto”.
6.1. Sotto un ulteriore profilo, gli appellanti sostengono poi che “a seguito degli approfondimenti eseguiti da Ama s.p.a. in forza del PAUR, è stata rinvenuta in sito addirittura una necropoli etrusca” e che tale ritrovamento sarebbe stato sottaciuto da parte di Ama s.p.a, di talché neanche la Soprintendenza, allorquando ha reso il parere negativo, era a conoscenza della presenza della necropoli e tanto meno il Commissario del Giubileo. 6.3. Sotto un profilo ancora diverso gli appellanti lamentano che il progetto di cui al PAUR si trovava ad uno stato talmente embrionale da non potere essere approvato dal Commissario.
6.4. Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
6.4.1. È, in primo luogo, infondato il sub-motivo con il quale si assume che il commissario straordinario non avrebbe tenuto conto del parere negativo della Soprintendenza.
L’assunto della parte appellante trascura di considerare che proprio dopo il parere della Soprintendenza è stata indetta una conferenza di servizi decisoria nella quale la stessa Soprintendenza ha rilevato la necessità di impartire prescrizioni ad Ama s.p.a., le quali sono state recepite nell’ordinanza impugnata.
Argomenti in tale direzione si ricavano dalla stessa ordinanza impugnata, la quale chiarisce come all’esito della “Conferenza svolta in forma semplificata è stato necessario procedere con l’esame contestuale, tramite la modalità sincrona, degli interessi coinvolti nel procedimento ai sensi dell’art. 14-bis comma 6, in quanto è stato espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale di cui alla citata nota protocollo SABAP-VT-EM_UO3 n. 0015763-P del 20/09/2023, che ritiene le opere non compatibili con il contesto di riferimento e di troppo impatto ambientale, e rileva che “… il diniego potrà essere superato qualora il Proponente approfondisse lo studio di impatto ambientale e paesaggistico e rimodulasse del tutto il progetto secondo una nuova proposta che rispetti la vocazione agricola del luogo e il contesto storico di riferimento (ovvero lo riconduca all’impianto di compost già autorizzato), andando contestualmente a risolvere, in accordo con la Scrivente, le evidenti interferenze presenti nella zona di accesso all’area”;”. Pertanto “con nota protocollo n. RM 2623 del 25/09/2023, è stata indetta la Conferenza 31 di Servizi decisoria, in modalità sincrona, ex art. 14-ter della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi i soggetti e le Amministrazioni coinvolti”.
Nella conferenza di servizi “la Soprintendenza, nel confermare il parere negativo già espresso in data 20/09/2023, ha ribadito le possibili soluzioni ai fini del superamento del diniego e ha fornito alcune prescrizioni circa l’approfondimento necessario ai fini della conclusione delle operazioni conoscitive e delle emergenze archeologiche”. E così, “con Determinazione Dirigenziale n. 4, protocollo n. RM 2726 del 29/09/2023 del Direttore della Direzione 2 dell’Ufficio di supporto al Commissario, è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art.14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con condizioni e prescrizioni indicate nei pareri espressi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti e con la ricezione delle prescrizioni della Soprintendenza in merito agli approfondimenti archeologici sull’intera area, così come la possibile riconfigurazione dell’infrastruttura viaria di nuova realizzazione, non considerandole come cause ostative all’approvazione del progetto”. La determinazione è stata “trasmessa alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti con nota protocollo n. RM 2750 del 03/10/2023” e tenuto conto che sono “decorsi i termini stabiliti dall’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. per l’eventuale opposizione alla conclusione della Conferenza di Servizi, è da considerarsi efficace”.
6.4.2. Del resto, depone chiaramente a sostegno di questa conclusione il fatto che la Soprintendenza non abbia presentato opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi dimostra per tabulas che le criticità dalla stessa fatte valere sono state superate.
Analogamente, anche nella parte dispositiva, l’ordinanza impone “che AMA S.p.a. recepisca le prescrizioni della Soprintendenza in merito al completamento delle indagini archeologiche per la valutazione della presenza, dello stato di conservazione e della quota delle preesistenze, nonché in merito alla possibile riconfigurazione dell’infrastruttura viaria di nuova realizzazione, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione per lavori su beni vincolati ed il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali”.
In definitiva, come emerge dall’atto impugnato, il parere negativo alla base della censura ha dato avvio a un approfondimento istruttorio che ha portato alla richiesta 32 della Soprintendenza di adottare prescrizioni.
Queste ultime sono state recepite dall’ordinanza impugnata e pertanto il parere negativo della Soprintendenza deve ritenersi superato come dimostra il fatto che la stessa Soprintendenza non ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria. È quindi errata in fatto l’affermazione secondo la quale “il Commissario ha emesso il PAUR su un progetto ed uno studio di impatto ambientale chiaramente da rivedere, del tutto provvisorio e del quale non è nemmeno stato congruamente valutato l'impatto con riferimento al rischio archeologico” (pag. 34 dell’appello).
6.4.3. Privo di pregio è, inoltre, il sub-motivo con il quale Ama s.p.a. avrebbe sottaciuto il ritrovamento di una necropoli etrusca, di modo che, a dire della parte appellante, “neanche la Soprintendenza, allorché ha reso il parere negativo, era a conoscenza della presenza della necropoli e tanto meno il Commissario del Giubileo”.
In senso contrario, si osserva che il procedimento amministrativo di adozione del PAUR si è concluso recependo le prescrizioni della Soprintendenza.
La Soprintendenza, con riferimento al ritrovamento della necropoli, non ha rilevato alcuna ragione ostativa, ma ha imposto soltanto alcune prescrizioni tra cui “un’area di rispetto di 20 metri attorno all’area della necropoli e di 5 metri ai lati della strada” (come riportano gli stessi appellanti a pag. 35 dell’appello). In definitiva anche in questo caso non emerge alcun elemento ostativo alla realizzazione dell’opera.
6.4.4. Quanto alla doglianza secondo cui la presenza di una zona di interesse archeologico costituirebbe un fattore escludente la localizzazione dell’impianto in esame, il Collegio rileva in senso contrario che l’impianto in questione non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; solo il raccordo stradale si colloca, in parte, all’interno della fascia di rispetto associata a beni paesaggistici appartenenti alla categoria “zone di interesse archeologico”, di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 142 del Codice, sottoposta a vincolo per legge.
La rilevazione da parte della VPIA dell’elevato rischio archeologico non comporta, di per sé, l’applicazione della tutela paesaggistica relativa alle zone di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 42/2004.
Pertanto, il ritrovamento di alcuni reperti archeologici all’interno dell’area non comporta un’applicazione automatica del sopracitato vincolo, rilevandosi, sotto tale profilo, corretto il punto 4 dell’Ordinanza, nella parte in cui dispone che Ama s.p.a. dovrà procedere all’acquisizione dell’autorizzazione per lavori su beni vincolati ex art. 21 del Codice dei beni culturali. In tal senso rileva anche l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 31/2023 in proposito prevede espressamente: “per l’area del nuovo raccordo stradale, come riportato nella stessa Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, è necessario completare le indagini in corso nell’area dell’impianto ed eseguire indagini archeologiche lungo il tracciato della nuova viabilità di progetto, al fine di prevedere tutte le opportune misure di prevenzione e tutela dei beni archeologici e paesaggistici”.
Una conferma di questa conclusione si ricava anche dal fatto che la stessa Soprintendenza stessa ha dichiarato nel parere che gli obiettivi di tutela indicati dalla norma del PTPR in questo caso non risultano essere cogenti dato l’assetto vincolistico dell’area.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, nel suo complesso, essere respinto.
8. La particolare complessità della fattispecie è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.2751/2025 R.G.), lo respinge.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore



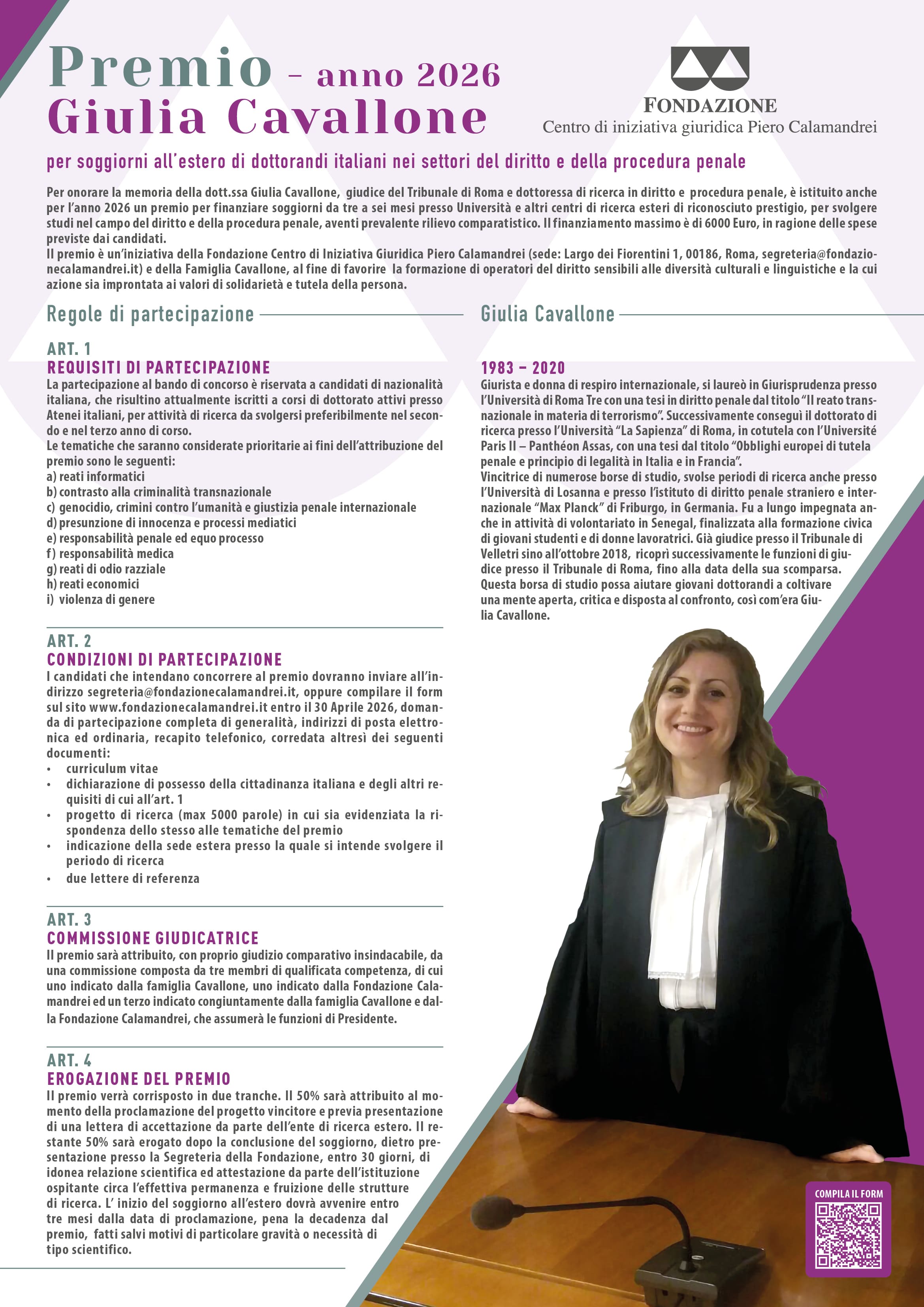 Scarica la locandina
Scarica la locandina