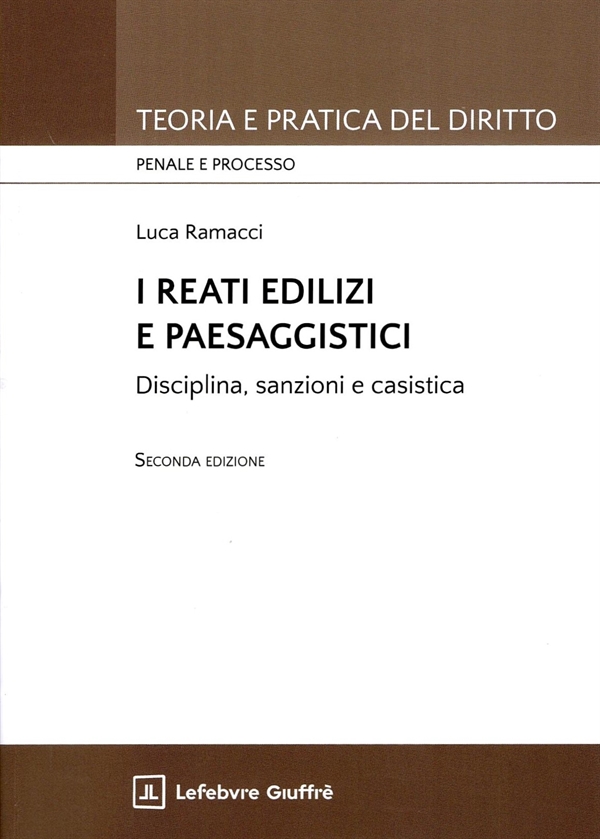Cass. Sez. III n. 32260 del 30 settembre 2025 (UP 10 set 2025)
Cass. Sez. III n. 32260 del 30 settembre 2025 (UP 10 set 2025)
Pres. Di Nicola Est. Noviello Ric. Sorrentino
Alimenti.Frode in commercio
Nella frode in commercio il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile. Da qui la correttezza della motivazione del giudice del merito censurata, laddove ai fini della configurazione del reato ha sottolineato come l'uso della locuzione "tipo Parma" abbia costituito quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, a prescindere dalla sua richiesta, necessario e sufficiente ai fini in esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del tribunale di Lanciano con la quale Sorrentino Marino era stato condannato in ordine al reato di cui a g li artt. 515 e 517 c.p. per avere commercializzato prosciutto crudo "in violazione della normativa posta a tutela delle DOP 'prosciutto di Parma' e di conseguenza consegnando beni di qualità differente a quello pattuito".
2. Avverso la suindicata pronuncia Sorrentino Marino propone, mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, attraverso sei motivi di impugnazione.
3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge per avere il giudice ritenuto indifferente rispetto al reato la circostanza relativa all'oggetto della intervenuta contrattazione se cioè inerente o meno alla vendita e acquisto di prosciutto di Parma Dop. Mentre invece non si sarebbe potuto prescindere dalla analisi della richiesta specifica rivolta dall'acquirente al venditore.
4. Con il secondo rappresenta il vizio di motivazione omessa e/o illogica atteso che la decisione dei giudici circa la rilevanza del profilo decettivo della locuzione usata a prescindere dalla richiesta dell'acquirente non risponderebbe al rilievo difensivo per cui "se il Legislatore ha costruito la tutela penale del marchio protetto come una circostanza aggravante, nel processo penale è necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato base".
5. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla mancata valutazione della prova dimostrativa della estraneità dell'imputato rispetto alla attività di assunzione degli ordini da parte dell'Ufficio estero della ditta amministrata dall'imputato.
6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione circa la valutazione di prove dimostrative di una prassi commerciale riguardante l'utilizzo non decettivo dell'espressione "tipo Parma" 7. Con il quinto motivo rappresenta il vizio di motivazione in ordine all'art.
131 bis c.p.
8. Con l'ultimo motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente, quanto alle denegate attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio applicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile. Si premette che l'articolo 515 del codice penale, rubricato "frode nell'esercizio del commercio", punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Si vuole in altri termini sanzionare pratiche commerciali ingannevoli che ledano la fiducia dei consumatori e l'integrità delle transazioni. L'art. 517 bis c.p. poi, configura l'aggravante per cui le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 cod. pen. sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Già da tali preliminari notazioni consegue che ai fini della integrazione del reato in parola non è determinante l'analisi della pattuizione specificamente intervenuta tra le parti interessate alla intervenuta consegna, quanto, piuttosto, la necessità di tutelare la correttezza degli scambi commerciali in funzione della tutela della fiducia dei consumatori e quindi anche di interessi degli stessi produttori. Tanto spiega come la corte di Cassazione abbia, in proposito, tra l'altro, sottolineato che per la configurabilità della pur distinta ipotesi del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (cfr. Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915 - 01).
In tale quadro è coerente la sottolineatura della giurisprudenza di legittimità secondo cui il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile (in motivazione, Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, Rv. 286909 - 01; Sez. 6, n. 8266 del 28/05/1981, Rv. 150203 - 01; Sez. 6, n. 7167 del 26/02/1973, Rv. 125225 - 01; Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, non mass. sul punto).
Da qui la correttezza della motivazione qui censurata, laddove ai fini della configurazione del reato i giudici hanno sottolineato come l'uso della locuzione "tipo Parma" abbia costituito quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, a prescindere dalla sua richiesta, necessario e sufficiente ai fini in esame.
2. Il secondo motivo è anche esso inammissibile, a fronte di una corretta e pertinente risposta, sia alla luce di quanto già osservato in sede di analisi del primo motivo, sia in ragione del rilievo, già formulato da questa Suprema Corte, per cui la consegna di un bene diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine, come nel caso di specie, integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (Cass. Pen. Sez. 3 n. 2617/2013).
3. In ordine alla terza censura più che adeguata è la motivazione fornita dai giudici nella parte in cui escludono la rilevanza della circostanza dedotta in ricorso valorizzando piuttosto il dato essenziale, certamente riconducibile all'imputato, costituito dall'uso della più volte evidenziata locuzione decettiva.
4. Quanto al quarto motivo, manifestamente infondato, la motivazione della Corte appare complessa rispetto alla censura difensiva, atteso che i giudici non solo hanno escluso l'emersione di una prassi commerciale fondata sulla comune utilizzazione della locuzione "tipo" ricollegata a prodotti di minore qualità ma con caratteristiche merceologiche similari rispetto a quello di maggior pregio, ma hanno anche supportato tale affermazione con l'ulteriore rilievo della totale assenza di affinità merceologica, per mancanza di ogni collegamento del prodotto venduto con la zona di Parma. Sicché, la deduzione difensiva, da una parte, non si confronta appieno con tale complessiva considerazione - peccando di carenza di specificità estrinseca (per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) - la quale smentisce alla radice - con la evidenziazione della assenza di ogni somiglianza merceologica - ogni prospettazione circa la esistenza di prassi commerciali comunque correlate a prodotti vicini a quello di notorio riferimento, seppur di minor pregio, dall'altra, si pone su un piano meramente fattuale, e come tale inammissibile in questa sede, tendendo a fornire una personale valutazione del peso da attribuire, sul punto, a talune circostanze all'uopo richiamate.
5. Anche il quinto motivo è inammissibile, atteso che a fronte della congrua motivazione negativa, che valorizza la diffusione della rete commerciale fraudolenta verso plurimi acquirenti, si oppone una mera personale e opposta valutazione di merito, che peraltro tende a valorizzare quei profili inerenti sia il tipo di pattuizione intervenuta sia la prassi commerciale difensivamente dedotta, già esclusi e citati in sede di analisi di precedenti motivi.
6. L''ultimo motivo è in parte fondato. La corte ha formulato plurime considerazioni, certamente riconducibili, nel quadro di una lettura complessiva della sentenza, al tema del trattamento sanzionatorio, tra cui, quella relativa alla tipologia, quantità e destinazione del prodotto venduto con falsa denominazione che appare certamente già di per sé in grado di supportare le scelte sanzionatorie qui contestate. Al contrario, rispetto ad una deduzione difensiva proposta con l'appello, tesa a valorizzare, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'avvenuto ritiro della merce all'indomani dei fatti contestati, appare carente e apodittica la decisione di rigettare la richiesta sulla base della mera affermazione della insussistenza di elementi positivi, senza alcuna altra specificazione
7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia e dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. Con condanna altresì dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3616,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3616,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.