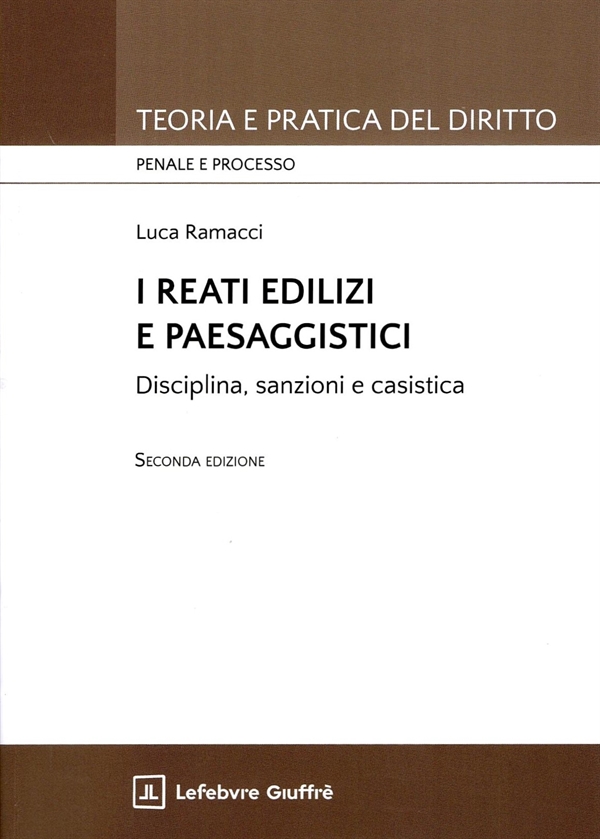Consiglio di Stato Sez. IV n. 7396 del 19 settembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7396 del 19 settembre 2025
Rifiuti.Bonifiche ed abuso della personalità giuridica
Un macroscopico uso distorto dello schema societario, con riferimento ai soci, prende, come è noto, il nome di “abuso dello schermo della personalità giuridica”. Riconosciuto in ambito internazionale come “piercing the corporale veil” ossia “perforamento del velo societario”, la nozione di “abuso della personalità giuridica” è stata tradizionalmente intesa, nella cultura giuridica anglosassone, quale forma di godimento da parte di un soggetto di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione e non è propria solo dell’ordinamento italiano, ma anche altri ordinamenti prevedono nei propri sistemi rimedi all’abuso della personalità giuridica. A quest’ordine di idee la giurisprudenza anglosassone ha aderito da tempo, con l’affermazione del principio per cui la persona giuridica deve essere considerata un soggetto distinto dalle persone fisiche dei suoi membri fino a quando non sussista un ragionevole motivo per affermare il contrario. L’abuso della personalità giuridica, inteso, dunque, quale uso strumentale, o per meglio dire elusorio, di una diversa soggettività è un fenomeno sul quale a lungo ha riflettuto la più qualificata dottrina, la quale l’ha definito come l’operazione del «trarre cioè illegittimo profitto dall’interpretazione dello “schermo” della persona giuridica», il che «significa, tecnicamente, godere della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione: significa fruire dell’esenzione dal diritto comune oltre i limiti entro i quali il legislatore aveva inteso contenerla». Il rimedio principale all’abuso della personalità giuridica consiste principalmente nel superare lo schermo della personalità giuridica disapplicando in primis il beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei soggetti che vi abbiano abusato, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata e la personale soggezione al fallimento in caso di insolvenza della società.
Pubblicato il 19/09/2025
N. 07396/2025REG.PROV.COLL.
N. 09830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9830 del 2023, proposto da Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Molinari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Zennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ferrara, Comune di Bondeno, Regione Emilia Romagna, Ausl Ferrara, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00248/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Molinari s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Luigi Furno e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
FATTO
1. La Molinari s.r.l. è proprietaria dal 2005 di un’area sita nel Comune di Bondeno (via Pironi n. 110) adibita a deposito e commercializzazione di carburanti sin dagli anni cinquanta.
Nell’anno 2005, a seguito del decesso del titolare della società Molinari Dario Carburanti (proprietaria e gestore dell’area in questione sin dai primi anni Cinquanta), la proprietà del sito è stata trasmessa in via ereditaria alla signora Franca Molinari, figlia del Sig. Dario Molinari, e legale rappresentante della Molinari s.r.l.: la gestione delle attività svolte sino ad allora su quel sito era stata, invece, ceduta alla Molinari Petroli s.r.l. mediante la stipula di un contratto di locazione tra quest’ultima società e la Molinari s.r.l..
Mentre la proprietà restava (e resta tuttora) in capo alla Molinari s.r.l., la gestione delle attività ha subito poi un ulteriore cambiamento nell’anno 2007, quando la società A.F. Petroli s.p.a. ha acquisito in affitto il ramo d’azienda dalla Molinari Petroli s.r.l., con contestuale stipulazione di uno specifico contratto di locazione commerciale con la società proprietaria dell’area.
1.1. Il sito in esame è stato interessato nel corso del tempo da fenomeni di contaminazione; in particolare A.F. Petroli s.p.a., con nota del 5 luglio 2008, trasmetteva all’Amministrazione allora competente (ossia la Provincia di Ferrara) comunicazione di potenziale contaminazione, ai sensi dell'art. 242, del d.lgs. n. 152/2006. Tale comunicazione faceva seguito a un incidente avvenuto il 4 luglio 2008 durante le operazioni di riempimento della cisterna n. 10 e al quale era conseguito lo sversamento di 200 litri di gasolio per autotrazione in un areale di 50 mq.
Nell’ambito di queste analisi veniva, tuttavia, rilevata l’esistenza di una doppia potenziale contaminazione: infatti, accanto a quella derivante dallo sversamento dovuto all’incidente nel riempimento della cisterna, si ravvisava anche una potenziale contaminazione che non poteva essere ricondotta al predetto incidente, ma che doveva necessariamente essere più risalente.
Quindi A.F. Petroli effettuava le operazioni richieste dalla normativa di settore per rimuovere la contaminazione.
Molinari s.r.l., con nota del 10 febbraio 2009, trasmetteva all’Amministrazione una comunicazione di potenziale contaminazione, ai sensi degli artt. 242 e 304, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e la Provincia avviava la relativa gestione ai sensi del citato art. 242.
In esito alla Conferenza di Servizi tenutasi nel 2020 e riguardante la valutazione dell’analisi di rischio ambientale, l’’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna(Arpae), con determinazione prot. n. DT-AMB-2020-4859, del 14 ottobre 2020, prescriveva alla Molinari s.r.l. la presentazione entro 6 mesi del progetto di bonifica del sito stante la presenza di significativi rischi ambientali.
2. Tanto premesso, con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Emilia Romagna, la Molinari s.r.l. ha impugnato quest’ultima determinazione unitamente al verbale della Conferenza dei Servizi del 6 ottobre 2020, deducendo motivi così rubricati:
I)violazione del principio comunitario “chi inquina paga”; violazione degli artt. 3-ter, 242, 245 e 304 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; violazione del procedimento; Carenza di istruttoria; irragionevolezza ed arbitrarietà; eccesso di potere per difetto di motivazione;
II) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 3-ter, 242, 245 e 252 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., erroneità e/o travisamento dei fatti; violazione del procedimento; illogicità, carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione;
III) violazione degli artt. 239 e 242, del d.lgs 152/2006; violazione del procedimento. Illogicità; sviamento; carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione; IV) violazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 239, del d.lgs. 152/2006; incompetenza; carenza di istruttoria; violazione del principio di legalità; eccesso di potere per sviamento;
V) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 239, 242, 245 e 246, del d.lgs 152/2006; violazione del procedimento; carenza di istruttoria; illogicità. violazione del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti la Molinari s.r.l. ha impugnato l’atto con il quale, in data 7 maggio 2021, Arpae l’ha diffidata alla presentazione di un progetto di bonifica, deducendo doglianze in via derivata rispetto al gravame introduttivo, oltre che in via autonoma, ma sempre per violazione del principio “chi inquina paga” oltre che dei principi del “giusto procedimento” e della collaborazione.
4. Con secondo ricorso per motivi aggiunti corredato da nuova istanza cautelare la Molinari s.r.l. ha impugnato la comunicazione del 22 marzo 2022 inviata dall’Arpae al Comune di Bondeno, ai sensi dell'art. 250, del d.lgs. n. 152/2006, inerente l’obbligo comunale di provvedere alla bonifica in ipotesi di inadempimento del responsabile, deducendo le medesime doglianze veicolate con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.
5. Con sentenza 24 aprile 2023 n. 248, il T.a.r. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.
6. L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
7. Si è costituita nel giudizio di secondo grado la Molinari s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
8. All’udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006, e l’art. 2043 c.c. in relazione al principio “chi inquina paga”.
1.1. Ad avviso della parte appellante, nel disconoscere la responsabilità della Molinari s.r.l., la decisione impugnata avrebbe erroneamente fatto riferimento al paradigma di cui all’art. 2043, mentre, in realtà, la funzione ripristinatoria-reintegratoria della responsabilità ambientale imporrebbe un distacco dal canone della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., il quale non risulterebbe “uno strumento adatto a trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale, soprattutto nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a omissioni o atti di taluni soggetti”.
Su tali basi, osserva la parte appellante che, dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, si ricaverebbe come il principio eurounitario del “chi inquina paga” prescinderebbe dall’elemento soggettivo, attribuendo la responsabilità “della bonifica” non solo al produttore ma, appunto, anche al mero detentore inteso come soggetto che abbia la disponibilità del rifiuto.
Di qui la conclusione nel senso della affermazione della responsabilità della odierna società appellata.
1.2. Tale conclusione si imporrebbe, a giudizio della parte appellante, anche in considerazione del fatto che Franca Molinari è l’erede universale di Dario Molinari, e che gli obblighi di bonifica del sito sarebbero trasmissibili mortis causa.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. L’esame del merito delle questioni sollevate con il primo motivo di appello presuppone una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento e dello stato della giurisprudenza interna ed eurounitaria.
All’indomani dell’entrata in vigore del “Codice” del 2006 (il quale, fra l’altro, ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva 2004/35/CE, attuativa del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191 TFUE) la materia della bonifica di siti contaminati risulta disciplinata in modo piuttosto compiuto dalla Parte IV, Tit. V (articoli da 239 a 253).
In via di estrema sintesi, il relativo quadro normativo può essere così ricostruito:
i) l’art. 242 (rubricato “Procedure operative ed amministrative”) individua gli obblighi ricadenti sul soggetto responsabile della contaminazione per ciò che riguarda (inter alia) le misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza di emergenza dell’area. La disposizione in questione non riferisce alcun obbligo al proprietario dell’area;
ii) l’art. 244 (rubricato “Ordinanze”) disciplina il caso in cui la contaminazione dell’area abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSR). In tali ipotesi la provincia territorialmente competente diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi degli artt. 242 e seguenti. L’ordinanza in questione viene comunque notificata anche al proprietario dell’area “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253” (ovvero al fine di rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sull’area);
iii) l’art. 245 (rubricato “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”) consente al proprietario incolpevole – ma in assenza di un obbligo specifico – di attivare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica dell’area. Il comma 2 fa carico al proprietario il quale abbia rilevato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di darne comunicazione alle amministrazioni competenti e di attuare le necessarie misure di prevenzione. Lo stesso comma 2 stabilisce che è comunque riconosciuta al proprietario la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in propria disponibilità;
iv) l’art. 250 (rubricato “Bonifica da parte dell’Amministrazione”) stabilisce che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di legge ovvero non siano individuabili e non vi provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dalle amministrazioni competenti, “avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”;
v) da ultimo, l’art. 253 del “Codice” (rubricato “Oneri reali e privilegi speciali”) stabilisce che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sulle aree oggetto di contaminazione «costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250» e che l’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Ai sensi del successivo comma 2, le spese sostenute per gli interventi di cui sopra sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (art. 2748, cpv. c.c.). Il successivo comma 3 stabilisce che «il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità». Infine, il comma 4 prevede che «(…) il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato (…) le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito».
In relazione al delineato quadro normativo interno (come si dirà fra breve, solo in parte di diretta scaturigine europea), la giurisprudenza nazionale si era profondamente divisa circa la possibilità di imporre al proprietario incolpevole l’adozione delle misure di prevenzione e di riparazione di cui alla Parte IV, Tit. V del “Codice dell’ambiente”.
In particolare, in base a un primo – e minoritario – indirizzo, tale possibilità doveva senz’altro essere ammessa sulla base di alcuni indici normativi e sistematici.
I fautori di tale orientamento osservavano, in particolare: i) che la più ampia e rigorosa applicazione del principio “chi inquina paga” porta ad escludere (persino nelle ipotesi-limite in cui non sia identificabile il responsabile dell’inquinamento) che gli oneri di bonifica ambientale possano essere addossati alla collettività; ii) che la tradizione giuridica nazionale (nonché di altri Paesi dell’Europa continentale) ben conosce ipotesi di imposizione al proprietario dell’area di specifici doveri di protezione e custodia connessi al mero dato della relazione con la res (in base a una sorta di pura e semplice “responsabilità da posizione”); iii) che il richiamo normativo alla figura dell’onere reale (art. 253 del “Codice dell’ambiente”) testimonia la volontà del Legislatore di individuare il proprietario attuale come soggetto su cui gravano i richiamati obblighi.
Essi osservavano, inoltre: iv) che la più recente dottrina e giurisprudenza in ambito civilistico hanno, ormai, riconosciuto che il principio colpevolistico rappresenta uno soltanto dei possibili criteri di imputazione delle conseguenze del danno (ben potendosi affiancare ad esso un diverso criterio di imputazione basato sulla mera relazione con la res, al pari di quanto previsto nel caso di danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.);
v) che «in coerenza col fondamento stesso del principio “chi inquina paga”, il “chi” non andrebbe inteso solo come colui che con la propria condotta attiva abbia posto in essere le attività inquinanti o abusato del territorio immettendo o facendo immettere materiali inquinanti, ma anche colui che – con la propria condotta omissiva o negligente – nulla faccia per ridurre o eliminare l’inquinamento causato dal terreno di cui è titolare».
Secondo un orientamento di segno contrario, il pertinente quadro normativo nazionale ostava a una ricostruzione volta a far gravare in capo al proprietario incolpevole della contaminazione gli obblighi di cui alla Parte IV, Tit. V del “Codice” del 2006.
In particolare, in tale diverso ordine di idee, si evidenziava che: i) il principio di matrice eurounitaria “chi inquina paga” (art. 191 TFUE) deve essere correttamente inteso secondo le categorie tipiche della responsabilità personale, senza che sia possibile fare ricorso ad indici presuntivi o a forme più o meno accentuate di responsabilità oggettiva; ii) le disposizioni di cui al richiamato Tit. V impongono chiaramente al proprietario incolpevole dell’inquinamento un novero piuttosto limitato di comportamenti (come l’adozione delle misure di prevenzione di cui al comma 2 dell’art. 245), la cui individuazione sembra insuscettibile di interpretazioni di carattere estensivo, atteggiandosi quale tendenziale numerus clausus; iii) deve essere valorizzato l’art. 245 del “Codice” il quale contempla come semplice “facoltà” quella per cui il proprietario dell’area ritenga di realizzare egli stesso le necessarie misure di ripristino ambientale; iv) deve essere parimenti valorizzato il successivo art. 250 il quale (con evidente previsione “di chiusura”) stabilisce che l’obbligo di realizzare “in ultima istanza” le misure in questione gravi sugli enti pubblici competenti e non sul proprietario dell’area (sul quale ricadranno, al contrario, le sole conseguenze di carattere patrimoniale di cui al successivo art. 253); v) nell’ordinamento interno le ipotesi di responsabilità oggettiva per danno ambientale costituirebbero pur sempre un numerus clausus, tendenzialmente inestensibile in via interpretativa ed applicativa.
Con due ordinanze sostanzialmente “gemelle” (si tratta della n. 21/2015 e della n. 25/2015), l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito i termini del richiamato contrasto giurisprudenziale e ha concluso nel senso che il pertinente quadro normativo interno debba essere inteso nel senso di non consentire alle Autorità nazionali di imporre al proprietario incolpevole l’adozione delle misure di cui alla Parte IV, Tit. V, “Codice dell’ambiente”.
Inoltre, l’Adunanza plenaria ha evidenziato alcuni possibili contrasti, con il principio “chi inquina paga”, nonché con i principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente da comportamenti di operatori economici.
L’Adunanza Plenaria ha, quindi, rivolto alla Corte di Lussemburgo il seguente quesito interpretativo: «se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, [del TFUE] e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (…) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica».
La Corte di Giustizia, con la decisione del 4 marzo 2015, C-524/13, ha, in primo luogo, chiarito che : i) che il principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191, par. 2 del TFUE si limita a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale; ii) che esso è rivolto in primis a regolare l’azione dell’Unione (e solo in via mediata quella degli Stati membri); iii) che quindi «detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE»(il riferimento va alle previsioni della direttiva 2004/35/CE che ha declinato in prescrizioni puntuali il richiamato principio generale “chi inquina paga”).
Correlativamente, la Corte ha evidenziato che l’art. 192 TFUE non può essere invocato dalle autorità nazionali al fine di imporre al proprietario incolpevole misure di prevenzione e riparazione in assenza di un fondamento giuridico nazionale (e, prima ancora, europeo).
Tanto chiarito dal punto di vista dell’applicazione (in senso oggettivo) del diritto europeo, la Corte ha sottolineato che, ai sensi del diritto UE derivato, esiste una rilevante distinzione fra:
i)da un lato, le ipotesi di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), (si tratta del danno ambientale causato da una delle attività professionali “sensibili” elencate nell’allegato III). In tali ipotesi, il criterio di imputazione della responsabilità per danno ambientale è di carattere rigidamente oggettivo e prescinde dalla necessaria verifica di una volontà colpevole da parte dell’operatore (c.d. responsabilità ambientale oggettiva);
ii)dall’altro, le ipotesi di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) (si tratta del danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, «in caso di comportamento doloso o colposo dell’operatore» (cd. responsabilità ambientale soggettiva).
Tanto premesso, la Corte ha sottolineato che, pur dovendosi dare atto del più rigido criterio di imputazione della responsabilità che attinge l’operatore nelle ipotesi di “responsabilità ambientale oggettiva”, nondimeno, viene sempre richiesta – perché una forma di responsabilità sia configurabile – la sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta dell’agente e l’evento lesivo per l’ambiente.
In tal senso la Corte di giustizia ha tratto argomento dall’art. 8, par. 3, della direttiva secondo cui «non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza (…)».
Da quanto osservato discende che l’Ordinamento UE (e segnatamente la direttiva 2004/35/CE, che ha tradotto in disposizioni puntuali il generale principio di cui all’art. 191 TFUE), dunque, non conosce alcuna ipotesi in cui la responsabilità per il danno ambientale possa essere fatta gravare su un operatore il quale non abbia cagionato – sotto il profilo causale – il danno di cui si discute.
Resta salva, nel ragionamento sviluppato dalla Corte di giustizia, naturalmente, la possibilità che il Legislatore nazionale, avvalendosi della clausola di maggior rigore di cui all’art. 16 della direttiva, decida in via autonoma di dotarsi di una normativa interna che preveda una siffatta forma di responsabilità “da mera posizione”.
Tuttavia, la Corte di Giustizia osserva che l’Ordinamento italiano non si è, ad oggi, avvalso della facoltà di introdurre le richiamate disposizioni di maggior rigore (quanto meno, per ciò che riguarda i criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale).
Si tratta, d’altronde, soggiunge la Corte di giustizia, di una scelta di fatto comune a quella operata dai principali Stati membri dell’Unione (Francia, Germania, Spagna) i quali – pur nella diversità delle scelte nazionali di recepimento – hanno escluso la possibilità di coinvolgere il proprietario incolpevole in forme di responsabilità per il danno ambientale cagionato da altri sulle aree successivamente acquisite. La sentenza in esame risulta di notevole importanza sistematica in quanto riconferma in termini quanto mai netti che, al fine di configurare una responsabilità per danno ambientale, è sempre necessaria la sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta dell’operatore e l’evento dannoso.
In definitiva, conclude la Corte nella decisione in esame, l’Ordinamento UE consente – a talune condizioni – che la sussistenza di un siffatto nesso di causalità possa essere dimostrata facendo ricorso a meccanismi presuntivi, ma non ammette in alcun modo la configurabilità di forme di responsabilità “da mera posizione”.
Nel solco dei principi elaborati dalla Corte di giustizia, di recente, la Cassazione, con la decisione, a Sezioni Unite, 1° febbraio 2023, n. 3077, ha escluso che la misura della «messa in sicurezza di emergenza», di cui all'art. 240, comma 1°, lett. m), d. legis. n. 152/2006, possa ricondursi sotto l'indice delle «misure di prevenzione», di cui alla lett. i), le quali soltanto possono giustificare, per gli effetti di cui al successivo art. 245, comma 1°, obblighi di facere in capo al proprietario (o ad altro soggetto interessato) non responsabile della potenziale contaminazione.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che il proprietario non responsabile dell'inquinamento è solo tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2°, t.u. ambiente, ad adottare le misure (iniziali) di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1°, lett. i), ma non le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui alle lett. m) e p) della stessa disposizione, di fatto respingendo quel diverso orientamento, il quale, richiamandosi al principio di precauzione ammette, invece, l'inerenza (anche) di tali misure a quelle preventive (di cui alla lett. i), come tali potenzialmente gravanti anche sul proprietario (o detentore), in quanto tale.
2.2. In applicazione del delineato quadro normativo e del suesposto orientamento interpretativo, il Collegio evidenzia che, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, il sito contaminato era storicamente in proprietà di Dario Molinari, che, per 50 anni, vi ha esercitato, attraverso la propria ditta individuale, l’attività di stoccaggio e commercializzazione carburanti sino al 2004, anno della sua morte.
Come riportato nella parte in fatto, nel sito, già dal 2007, operava la AF Petroli s.r.l. che attivò una procedura di MISE nel 2008 a seguito di uno sversamento di carburante e fu proprio nell’ambito di quella procedura che, l’anno successivo, venne riscontrata la contaminazione storica che ha portato, poi, alla vicenda oggetto del presente giudizio.
Da quanto osservato discende che, sulla base delle prove in atti, la contaminazione è riconducibile all’attività svolta prima del 2009.
La Molinari s.r.l. è stata costituita nel 1984 dai soci Franca Molinari e Luca Docci; il signor Dario Molinari non ha mai fatto parte della società e la signora Franca Molinari non ha mai avuto partecipazioni in altre società che non fossero la Molinari s.r.l. (società che esercita attività nell’ambito del commercio immobiliare) e la D.M. di Pantalone Gioachino s.a.s., società, quest’ultima, che gestiva un ristorante al Lido degli Estensi e di cui la signora Molinari era socia accomandante.
Ne discende che, non solo le società in esame sono sempre state distinte l’una dall’altra, ma anche le persone fisiche hanno avuto ruoli e partecipazioni solo nelle singole e distinte società: Dario Molinari nella sua ditta e Franca Molinari nella sola Molinari s.r.l., che non è subentrata nell’attività svolta dalla ditta Dario Molinari e di cui il signor Dario Molinari non era socio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e avuto riguardo agli elementi probatori in atti, deve escludersi la responsabilità della Molinari s.r.l..
Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, di dimostrare che, nel caso in esame, Molinari s.r.l. sia solo apparentemente un soggetto diverso da Molinari Franca e che, dunque, in ultima analisi, il centro di imputazione degli interessi economici sia, nella realtà, rappresentato dalle società riconducibili prima a Molinari Dario, poi alla di lui erede Franca Molinari, quindi alla Molinari Petroli e, infine, alla Molinari s.r.l.
Laddove si fornisse una prova di tal fatta, si verificherebbe, infatti, un macroscopico uso distorto dello schema societario che, con riferimento ai soci, prende, come è noto, il nome di “abuso dello schermo della personalità giuridica”.
Riconosciuto in ambito internazionale come “piercing the corporale veil” ossia “perforamento del velo societario”, la nozione di “abuso della personalità giuridica” è stata tradizionalmente intesa, nella cultura giuridica anglosassone, quale forma di godimento da parte di un soggetto di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione e non è propria solo dell’ordinamento italiano, ma anche altri ordinamenti prevedono nei propri sistemi rimedi all’abuso della personalità giuridica.
A quest’ordine di idee la giurisprudenza anglosassone ha aderito da tempo, con l’affermazione del principio per cui la persona giuridica deve essere considerata un soggetto distinto dalle persone fisiche dei suoi membri fino a quando non sussista un ragionevole motivo per affermare il contrario.
L’abuso della personalità giuridica, inteso, dunque, quale uso strumentale, o per meglio dire elusorio, di una diversa soggettività è un fenomeno sul quale a lungo ha riflettuto la più qualificata dottrina, la quale l’ha definito come l’operazione del «trarre cioè illegittimo profitto dall’interpretazione dello “schermo” della persona giuridica», il che «significa, tecnicamente, godere della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione: significa fruire dell’esenzione dal diritto comune oltre i limiti entro i quali il legislatore aveva inteso contenerla».
Il rimedio principale all’abuso della personalità giuridica consiste principalmente nel superare lo schermo della personalità giuridica disapplicando in primis il beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei soggetti che vi abbiano abusato, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata e la personale soggezione al fallimento in caso di insolvenza della società.
Più recentemente, nel solco delle riflessioni di autorevole dottrina italiana, anche la Corte di cassazione ha aderito a tale pregevole impostazione concettuale. In particolare, la giurisprudenza italiana ha individuato il rimedio contro gli abusi della personalità giuridica nel superamento (parla significativamente al riguardo della necessità di “bucare” il velo societario, cfr. Cass. civ., 3.11.2021, n. 31319) da parte del giudice dello schermo della personalità giuridica, con l’imputazione degli atti o delle condotte illecite direttamente a coloro che si sono avvalsi strumentalmente di tale istituto.
Nondimeno, come rilevato, nel caso in esame, dall’analisi delle risultanze probatorie c compendiate nell’istruttoria procedimentale condotta da Arpae, manca la prova che un abuso, nei termini indicati, vi sia stato.
3. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 242, 244 e 245 nonché del d.lgs. n. 152/2006.
3.1. Ad avviso della Agenzia appellante, il T.a.r., nella decisione impugnata, avrebbe erroneamente ritenuto che la comunicazione del 10 febbraio 2009 non potesse equivalere ad un obbligo legale o negoziale di effettuare le operazioni di bonifica non esprimendo, tale comunicazione, alcuna volontà da parte di Molinari di assumere tale ruolo.
In senso contrario la parte appellante assume che il deposito del piano di caratterizzazione costituirebbe implicita assunzione di responsabilità per la situazione di inquinamento registratasi nel sito in esame. Ciò in quanto il proprietario (ancorché non responsabile), che abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, avrebbe assunto spontaneamente l’impegno di eseguire il complessivo intervento di bonifica.
L’assenza di una responsabilità diretta in ordine alla contaminazione, nella prospettiva in esame, sarebbe, dunque, irrilevante essendo sufficiente, per riconoscere la responsabilità della Molinari s.r.l., il mero riferimento all’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, contenuto nella comunicazione del 10 febbraio 2009.
A sostegno di tale assunto, l’appellante richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5158/2021 che aveva respinto l’appello cautelare di Molinari s.r.l., confermando l’ordinanza del T.a.r Emilia-Romagna n. 315/2021, valorizzando in tale senso la previsione testuale della comunicazione e richiamando la sentenza Cons. Stato n. 5372/2020.
4. Il motivo non è fondato.
4.1. Questa Sezione si è già occupata, con la decisione 2 febbraio 2024, n. 1110, della possibilità di poter rinvenire una possibile deroga ai principi sopra esposti in materia di responsabilità ambientale nell’operatività dell’istituto della negotiorum gestio.
Il Collegio rileva, nondimeno, che la fattispecie in esame diverge dal caso oggetto del richiamato precedente. Reputa, infatti, il Collegio che l’assunzione di un impegno così gravoso debba trovare fondamento in una inequivoca manifestazione di volontà del soggetto non responsabile dell’inquinamento, mentre nella fattispecie in esame così non è, non potendosi ritenere che a tal fine possa ritenersi sufficiente la comunicazione del 19 febbraio 2009, con la quale, ai sensi degli artt. 242 e 304, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, la Molinari s.r.l., qualificandosi come proprietaria del sito in Via Pironi 110 a Bondeno (FE), si è limitata a evidenziare agli Enti di competenza che, nel corso di un intervento di messa in sicurezza già attivato dalla conduttrice del sito AF Petroli s.p.a. a seguito di uno sversamento di gasolio da una cisterna, era stato riscontrato sul fondo scavo ed in parete un superamento delle CSC che non poteva essere ricondotto al predetto incidente, ma, semmai, ad una situazione di contaminazione storica e risalente del sito.
E in effetti, con tale comunicazione, la Molinari s.r.l., lungi dal manifestare l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, si è limitata a “prendere atto” della situazione di contaminazione, anticipando che avrebbe provveduto alla redazione e trasmissione del Piano di Caratterizzazione del sito.
Non può, dunque, essere condivisa la prospettazione della parte appellante, secondo cui, con la comunicazione in esame, la Molinari s.r.l. si sarebbe auto qualificata come responsabile della contaminazione e, in ogni caso, si sarebbe obbligata a portare a compimento la bonifica per il solo fatto di aver volontariamente attivato la procedura ex art. 242 D.Lgs. 152/2006.
Alla luce di quanto esposto, occorre, dunque, ribadire che il proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell'inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d'ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo. Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata né, quindi, l'obbligo di bonificare il sito o di adottare le misure di messa insicurezza di emergenza per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all'inquinamento riscontrato (ex pluribus, Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6885).
Alla luce delle osservazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere



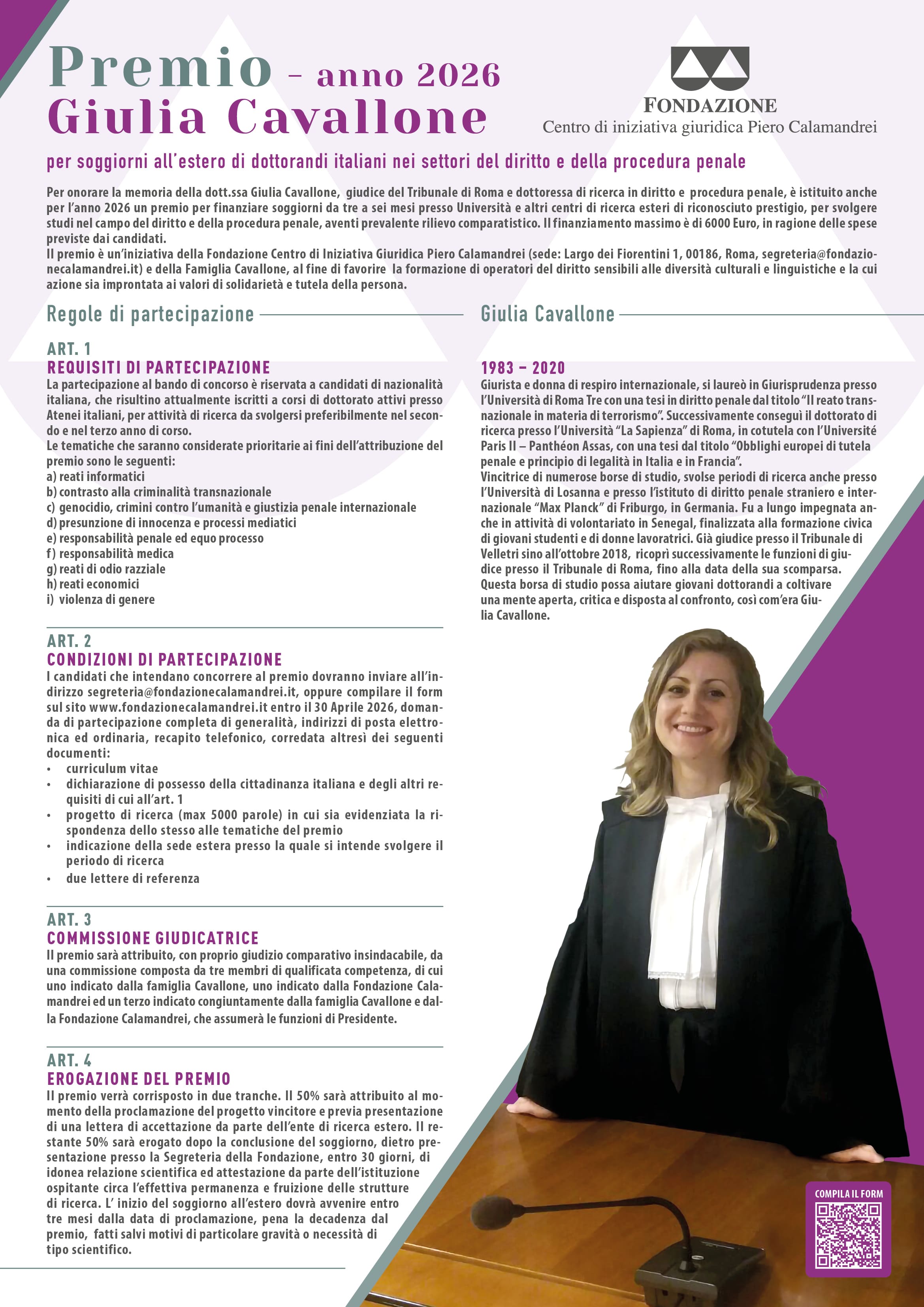 Scarica la locandina
Scarica la locandina