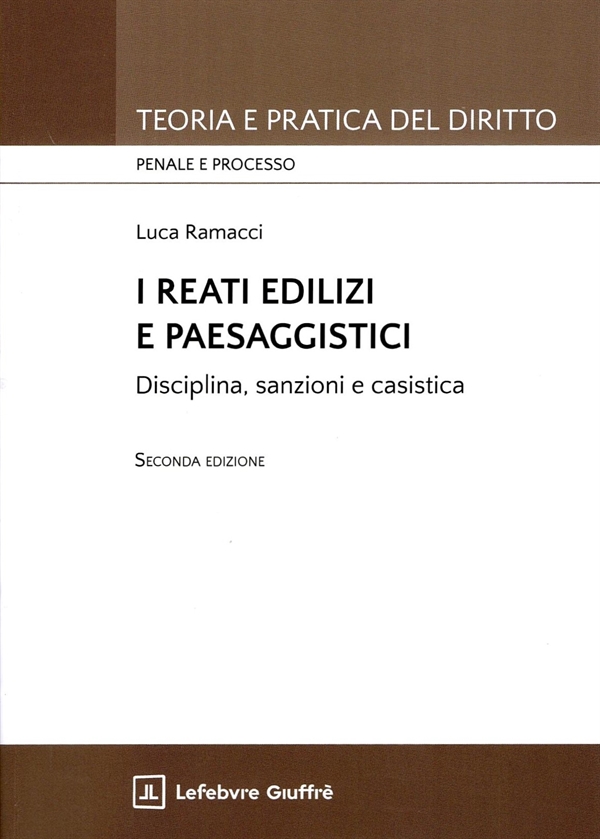Corte Costituzionale sent. 273 del 22 luglio 2010
Corte Costituzionale sent. 273 del 22 luglio 2010
Oggetto: Reati e pene - Impossessamento abusivo di acque pubbliche - Configurazione, in virtù del d.lgs. n. 152 del 1999, quale illecito amministrativo - Denunciata depenalizzazione della fattispecie.
Dispositivo: inammissibilità
SENTENZA N. 273
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), che sostituisce l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza del 3 marzo 2009, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di R.A. ed altri, di C.M. e P.V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Tullio Padovani, Eriberto Rosso, Anna Francini per S.G. ed altri, Giuseppe Giuffrè e Giandomenico Falcon per R.A., Gemma Bearzotti per C.M., Paolo Dell’Anno per P.V. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. − Con ordinanza depositata il 3 marzo 2009, il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), nella parte in cui, sostituendo l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell’autorità competente.
1.1. – Il rimettente riferisce che il procedimento a quo riguarda soggetti, già responsabili di cantieri approntati per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Bologna, ai quali si contesta l’indebito impossessamento di acque pubbliche utilizzate nel corso dei lavori. In particolare, agli imputati è contestato il delitto di furto aggravato, perpetrato «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle rispettive qualità ricoperte nell’arco temporale indicato, al fine di trarne un ingiusto profitto (consistito nell’impiego gratuito di acqua pubblica a servizio delle proprie attività di cantiere con particolare riferimento all’impiego di acqua negli impianti di betonaggio e al lavaggio dei mezzi meccanici e in generale all’impiego di acque chiare nelle attività di cantiere)».
Il rimettente riferisce ancora che l’acqua oggetto di furto, per un quantitativo stimato in non meno di cinque milioni di metri cubi, sarebbe stata in parte prelevata dalle falde sotterranee intercettate durante i lavori di scavo nelle gallerie, in parte estratta mediante perforazione di pozzi, e in parte prelevata dai corsi d’acqua limitrofi ai cantieri, il tutto in assenza delle prescritte autorizzazioni e concessioni del Genio Civile della Provincia di Firenze. Sempre in ipotesi accusatoria, le condotte contestate sarebbero state poste in essere nel periodo dal 1997 al 2005 (con l’esclusione del 2001, anno in cui era stata chiesta la concessione).
Il pubblico ministero – secondo quanto segnala il rimettente – ritiene ininfluente, in punto di qualificazione penalistica delle condotte, la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999, che sanziona come illecito amministrativo la condotta di «derivazione o utilizzo» di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione, perché diverso sarebbe il bene giuridico tutelato penalmente, attraverso la fattispecie del furto aggravato, rispetto a quello presidiato dalla sanzione amministrativa: nel primo caso il patrimonio dello Stato, nel secondo la regolamentazione del prelievo delle acque e la tutela della salubrità di queste. Di conseguenza, la stessa condotta, ove accertata, darebbe luogo alla violazione sia del precetto penale sia di quello amministrativo, con applicazione concomitante delle due norme indicate.
In senso contrario, prosegue il giudice a quo, le difese degli imputati hanno sostenuto la tesi della specialità della norma che prevede l’illecito amministrativo, rispetto alla previsione del delitto di furto, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prelievo di acque sotterranee o superficiali per fini industriali, a norma dell’art. 9 della legge 24 novembre 1989, n. 681 (Modifiche al sistema penale).
1.2. – Il rimettente considera pregiudiziale, nel contesto descritto, una verifica della asserita prevalenza della norma che sanziona in via amministrativa il prelievo abusivo di acqua su quella penale contestata, «atteso che qualunque verifica in fatto della imputazione deve presupporre necessariamente la giurisdizione del giudice penale».
Lo stesso rimettente procede quindi a richiamare per grandi linee l’evoluzione della disciplina delle acque, osservando come, ancor prima della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), già l’art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933 avesse attribuito alle acque classificate di «pubblico generale interesse» il carattere della demanialità. Le acque prive di rilevanza pubblica, e non inserite espressamente negli elenchi previsti dalla legge, erano rimaste oggetto delle disposizioni del codice civile. Con la legge n. 36 del 1994, emanata in una fase storica in cui era ormai diffusa l’attenzione alla tutela delle risorse idriche, il legislatore nazionale ha proceduto a ridefinire l’intera disciplina delle acque pubbliche, in una prospettiva di vero e proprio rovesciamento dei principi sottesi alla regolamentazione del prelievo e dell’utilizzo dell’acqua. Per effetto della cosiddetta legge Galli, si è passati da un regime ordinario di carattere privatistico, che richiedeva una specifica classificazione da parte della pubblica amministrazione per qualificare un’acqua come di pubblico interesse, ad un regime «rigidamente pubblico in ordine alla proprietà della risorsa idrica», nel quale tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche, rimanendo nella discrezionalità della pubblica amministrazione soltanto il potere di disciplinare diversamente le modalità di utilizzo delle acque, a seconda dei soggetti e delle finalità.
Successivamente, è entrato in vigore il d.lgs. n. 152 del 1999, di recepimento di numerose direttive comunitarie, il quale ha dettato norme a tutela delle acque dall’inquinamento, ed è intervenuto anche sul testo unico approvato con il r.d. n. 1775 del 1933, in particolare sostituendo l’art. 17 di quest’ultimo con il comma 4 dell’art. 23 del citato d.lgs. La previsione richiamata ha stabilito il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente, comminando al contravventore, «fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti», una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla cessazione dell’utenza abusiva e al pagamento dei canoni non corrisposti.
A partire quindi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 1999, si è posto il problema di individuare la norma sanzionatoria applicabile in relazione a condotte di impossessamento di acque pubbliche analoghe a quelle descritte nel capo di imputazione.
Il giudice a quo segnala come, dopo qualche iniziale incertezza, la giurisprudenza di legittimità si sia consolidata su posizioni di «sostanziale abrogazione della rilevanza penale della condotta descritta», affermando da ultimo (Corte di cassazione, sentenza n. 25548 del 2007) che la previsione contenuta nell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 624 del codice penale, in quanto presenta due elementi specializzanti: l’oggetto dell’impossessamento (l’acqua pubblica) ed il dolo specifico (la finalità industriale).
Il rimettente richiama anche un precedente di segno contrario (Corte di cassazione, sentenza n. 37237 del 2001), che aveva ritenuto sussistente un concorso reale e non apparente tra le norme, là dove la previsione amministrativa sarebbe volta a tutelare la salubrità delle acque e quella codicistica il bene nel suo valore patrimoniale. Il Tribunale tuttavia, in assonanza con la giurisprudenza più recente, ritiene che la verifica del rapporto di specialità debba fondarsi su una comparazione strutturale tra le fattispecie più che sulla loro funzione protettiva, ed aggiunge, richiamando ancora la sentenza n. 25548 del 2007 della Corte di cassazione, che «anche il d.lgs. n. 152 del 1999, art. 23 tutela la proprietà delle acque, sia pure sotto un peculiare profilo». In particolare, la disposizione che configura l’illecito amministrativo presidierebbe gli interessi patrimoniali dell’Erario in quanto stabilisce che il contravventore deve corrispondere, in ogni caso, i canoni evasi, i quali rappresentano il corrispettivo del bene ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 36 del 1994. Inoltre, nel caso oggetto del procedimento principale, la condotta di impossessamento dell’acqua sotterranea e superficiale sarebbe stata posta in essere con specifica finalità industriale, con la conseguenza che, in base al criterio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 681 del 1989, dovrebbe trovare applicazione la sola sanzione amministrativa.
Tutto ciò premesso, il rimettente ritiene che la disposizione che configura l’illecito amministrativo sia costituzionalmente illegittima, per violazione del canone della ragionevolezza e del principio di uguaglianza.
1.3. – Con riguardo alla rilevanza della questione, il Tribunale precisa, innanzitutto, che fino alla pubblicazione del d.lgs. n. 258 del 2000, di integrazione e correzione del d.lgs. n. 152 del 1999, le condotte di impossessamento di acque pubbliche per fini di vantaggio patrimoniale erano punite a titolo di furto. Pertanto, per i fatti antecedenti posti ad oggetto del procedimento a quo, in ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ha configurato l’illecito amministrativo, potrebbe nuovamente trovare applicazione la fattispecie incriminatrice, non ostandovi il principio sancito dall’art. 2 cod. pen., a sua volta attuativo dell’art. 25 Cost.
Dopo aver richiamato ampiamente la sentenza n. 394 del 2006 della Corte costituzionale sul tema del sindacato di costituzionalità con effetti in malam partem, il giudice a quo afferma che la norma censurata sarebbe sussumibile nella categoria delle «norme di favore», in quanto avrebbe operato una «depenalizzazione “di favore” in relazione a determinati soggetti, con carattere di irragionevolezza con riferimento alla gerarchia dei beni giuridici tutelati dall’ordinamento».
1.4. – Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo nuovamente si riporta alla sentenza n. 394 del 2006, nella parte in cui si afferma che «un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio». Ciò che ricorrerebbe nel caso odierno, in quanto il regime sanzionatorio introdotto nel 1999 per le condotte di derivazione e utilizzo abusivi di acque pubbliche a fini industriali, sarebbe viziato «da irragionevolezza e grave contraddizione con alcune norme di rango costituzionale».
In particolare, l’introduzione di una norma di depenalizzazione dell’impossessamento abusivo, a fini di lucro, di un bene giuridico di cui si è riconosciuto il valore fondamentale per la collettività, risulta, secondo il rimettente, «manifestamente privo di razionalità e di armonia con il sistema di tutela dato», ancor più se si pone mente al fatto che in precedenza, cioè fino all’anno 2000, le stesse condotte erano sanzionate penalmente.
L’irrazionalità della scelta legislativa sarebbe ancor più palese considerando che continua ad essere penalmente sanzionata la sottrazione di beni patrimoniali i quali, nella scala di valori, risultano di importanza di gran lunga inferiore alla risorsa idrica.
Sussisterebbero dunque, secondo il Tribunale di Firenze, profili di illegittimità costituzionale della norma censurata, là dove essa «non soltanto introduce una disparità di trattamento sanzionatorio di condotte identiche relative allo stesso bene giuridico, ancorché poste in essere in momenti diversi, senza che emerga ragione a fondamento, ma introduce una disparità di trattamento sanzionatorio fra beni di diverso valore sociale, apprestando tutela diminuita proprio a quel bene che, con la medesima legge, si intende tutelare più incisivamente».
Inoltre, l’illegittimità della norma censurata emergerebbe anche in relazione al diverso trattamento riservato ad «altre condotte di impossessamento relative al medesimo bene giuridico, e da ritenersi ancora sanzionate dalla norma incriminatrice generale di cui all’art. 624 cod. pen.».
A tale proposito il rimettente richiama nuovamente la giurisprudenza della Corte di cassazione, e in particolare la già citata sentenza n. 25548 del 2007, per dissentire dalla affermazione ivi contenuta, secondo la quale le due norme – artt. 624 cod. pen. e 23, comma 4, d.lgs. n. 152 del 1999 – regolano la stessa materia, vale a dire l’impossessamento di un bene altrui per trarne vantaggio. Ciò sarebbe vero solo con riferimento alle condotte che, al pari di quelle contestate nel procedimento principale, consistano in «derivazione o utilizzo», locuzioni che, peraltro, configurerebbero soltanto alcuni possibili modi di impossessamento dell’acqua. Vi sarebbero dunque «casi di impossessamento che non vengono realizzati attraverso una derivazione, o che non sono finalizzati all’utilizzo industriale del bene, ma che sono comunque caratterizzati da fine di lucro, i quali necessariamente sfuggono alla previsione della norma amministrativa, e ricadono […] sotto l’impero della fattispecie penale, questa volta essa stessa speciale rispetto alla norma amministrativa».
A titolo esemplificativo, il Tribunale cita il caso di un soggetto il quale procedesse alla trivellazione di un pozzo di acque sotterranee, ritenendole di pregio, al fine di farne commercio, «anche eventualmente mediante la pura e semplice cessione a terzi. In tal caso l’impossessamento non si realizzerebbe mediante derivazione, né avrebbe come finalità un utilizzo dell’acqua pubblica a fini industriali (utilizzo che presuppone nella quasi totalità dei casi il rilascio del bene stesso dopo il suo utilizzo), e quindi necessariamente sarebbe la norma penale a dispiegare i propri effetti».
Pertanto, la norma censurata avrebbe anche introdotto una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra condotte di identico disvalore, relative allo stesso bene, «ancorché poste in essere con motivazioni differenti».
1.5. – Il Tribunale di Firenze argomenta ulteriormente sul profilo della rilevanza della questione, con specifico riguardo al fenomeno della successione delle leggi, osservando come, nella perdurante vigenza della norma censurata, una parte delle condotte in contestazione – quelle successive alla depenalizzazione – risulterebbe priva di rilevanza penale, mentre l’altra parte, costituita dalle condotte precedenti, risulterebbe non più punibile ai sensi dell’art. 2, secondo comma, cod. pen.
In caso di accoglimento della questione, si verificherebbe «la nuova espansione della norma incriminatrice penale», quantomeno per i fatti pregressi, al momento non ancora prescritti. Trattandosi infatti di condotte antecedenti all’entrata in vigore della norma di favore, non verrebbe in rilievo il principio di irretroattività della norma penale, bensì il diverso principio della retroattività della norma penale più mite, che, peraltro, nella specie non potrebbe spiegare alcun effetto.
In proposito, è ancora richiamata la sentenza n. 394 del 2006 della Corte costituzionale, nella parte in cui si trova affermato che «è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima».
Le stesse conclusioni sarebbero applicabili, sempre secondo il rimettente, alla ipotesi della declaratoria di illegittimità di una norma a carattere amministrativo con effetti di depenalizzazione.
2.− Con atto depositato il 16 febbraio 2010, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata.
La difesa dello Stato osserva come il giudice a quo – il quale dichiara di aderire all’orientamento della Corte di cassazione secondo cui l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 è norma speciale rispetto all’art. 624 cod. pen. –, non abbia assolto all’onere di verificare se sia possibile dare un’interpretazione costituzionalmente orientata alla norma in esame.
Sarebbe questo, a parere dell’Avvocatura generale, il percorso da seguire nel caso di specie, posto che il citato art. 23, nel sanzionare in via amministrativa le condotte di derivazione e utilizzo abusivi di acque pubbliche, intende assicurare la realizzazione degli obiettivi indicati dall’art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sarebbe dimostrato dalla previsione della possibilità di presentare domanda di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del medesimo decreto.
Differente, invece, risulterebbe l’ambito di applicazione del delitto di furto, sicché tra le due previsioni non ricorrerebbe un rapporto di specialità, come affermato dal rimettente, bensì un concorso formale di reati, disciplinato dall’art. 81 cod. pen.
Tale opzione ermeneutica, secondo la difesa dello Stato, consentirebbe di fugare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente.
3. – Con comparsa depositata l’11 febbraio 2010, si è costituito in giudizio M.C., imputato nel procedimento principale, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
La difesa dell’imputato richiama l’ordinanza di rimessione nella parte in cui il giudice a quo effettua la comparazione tra l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999, che punisce la violazione del divieto di derivazione o utilizzo di acqua pubblica con la sanzione amministrativa, e l’art. 624 cod. pen., dando atto che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche non riveste (più) rilevanza penale (Corte di cassazione, sentenza n. 25548 del 2007).
Ciò posto, si osserva come il rimettente, che pure dichiara di aderire a tale orientamento giurisprudenziale, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la previsione richiamata in contrasto con l’art. 3 Cost., sicché la violazione del principio di uguaglianza deriverebbe proprio dall’elemento specializzante della «finalità industriale».
In realtà, prosegue la stessa difesa, il rimettente avrebbe omesso di analizzare le ragioni su cui si fonda la scelta di non sanzionare penalmente la condotta descritta nell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999, avendo focalizzato la sua attenzione sulla presunta contraddittorietà tra il sistema delineato dal d.lgs. n. 152 del 1999, di tutela rafforzata del bene giuridico costituito dalle acque pubbliche, e la introduzione, in quello stesso sistema, di una norma che ne depenalizza «l’impossessamento illecito a fini di lucro».
La parte privata segnala inoltre come, nel percorso logico del giudice a quo, il fine industriale venga equiparato al fine di lucro, ciò che appare quanto meno riduttivo se si considera che il primo, a differenza del secondo, presuppone un’organizzazione di lavoro e trascende l’interesse del singolo.
Sarebbe poi evidente che, mentre nella fattispecie che punisce il delitto di furto l’interesse primario è rappresentato dalla tutela della proprietà privata, in quella delineata dall’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 oggetto di tutela è la riserva idrica, all’interno di un regime concessorio, con sanzioni pecuniarie sicuramente elevate se raffrontate al costo dell’acqua.
Il differente disvalore sociale delle condotte indicate, giustificherebbe quindi il diverso sistema sanzionatorio.
Del resto, nel bilanciamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela, non di rado il legislatore ha privilegiato l’attività industriale e commerciale a scapito delle esigenze ambientali, come avviene per l’inquinamento acustico delle zone limitrofe agli aeroporti e per l’inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi di trasporto urbani. Si tratta di scelte sicuramente discutibili sul piano politico, ma non prive di ragionevolezza, sicché la questione sarebbe manifestamente infondata.
4. – Con atto depositato il 15 febbraio 2010, si sono costituiti in giudizio R.A., S.C., G.G., Z.F., L.M., M.N., F.G., C.U., O.C., M.P.P. e M.C., tutti imputati nel procedimento a quo, nonché il Consorzio C.A.V.E.T. Alta Velocità Emilia-Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
La difesa delle parti indicate svolge alcune considerazioni sul ragionamento prospettato dal giudice a quo a fondamento della questione, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della stessa.
4.1. – Si osserva in primo luogo, sotto il profilo della rilevanza, che il rimettente si sarebbe limitato ad affrontare le ricadute dell’eventuale pronuncia di accoglimento in rapporto al fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolato dall’art. 2 cod. pen., mentre in realtà, come sollecitato dalla stessa difesa, il giudice a quo avrebbe dovuto prioritariamente stabilire se, stante il disposto dell’art. 48 del r.d. n. 1775 del 1933, nel caso di specie possano trovare applicazione la norma censurata ovvero quella che punisce il furto, invocata in alternativa dal medesimo giudice.
Il richiamato art. 48, terzo comma, stabilisce che «quando il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato».
Se infatti, incontestabilmente, l’esecuzione del tracciato ferroviario per l’alta velocità tra Firenze e Bologna è qualificabile alla stregua di un’opera di pubblica utilità eseguita dallo Stato, esiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 48, terzo comma, con la conseguenza che sarebbe esclusa in radice l’antigiuridicità delle condotte, venendo così a mancare la rilevanza della questione.
4.2. – Nel merito, la difesa osserva come rientri nella piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza delle opzioni assunte, l’individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni.
Nel caso in esame, pur essendo innegabile che l’acqua pubblica costituisca un oggetto di tutela di primario valore, ciò che assume importanza nel sistema normativo «non è tanto la materiale fisicità del bene, quanto la concreta disponibilità dello stesso». Posto dunque che la capacità di disporre delle acque pubbliche non è libera ma amministrata, la scelta di qualificare come illecito amministrativo il prelievo abusivo delle predette acque sembra tutt’altro che irrazionale, risultando il naturale completamento di una disciplina di base amministrativa, e dimostrandosi consona alla peculiare forma aggressiva in esame.
Più specificamente, mentre il delitto di furto tipizza un’aggressione ad un potere altrui (che non è proprio, o anche, dell’agente), la fattispecie di prelievo abusivo di acque pubbliche tipizza «una aggressione ad un potere che è di tutti, ma che è tale in forza di una programmata e controllata parcellizzazione ad opera di un soggetto-filtro la cui volontà, in definitiva, è la prima e più importante ad essere frodata».
Non risulterebbe sussistente neppure la disparità di trattamento sanzionatorio tra il prelievo abusivo di acque pubbliche finalizzato al mero commercio della risorsa idrica, in assunto del rimettente punito come illecito penale, e il medesimo prelievo diretto ad uso industriale, punito come illecito amministrativo. Il ragionamento del giudice a quo sarebbe sul punto viziato dalla mancata considerazione del rilievo che riveste, nella fattispecie sanzionata in via amministrativa, il dolo specifico, che, pur non essendo un elemento materiale del fatto, nondimeno costituisce elemento della fattispecie e concorre alla tipizzazione della stessa.
L’elemento del dolo specifico, sottolinea la difesa, «determina una indubbia specificazione dell’illecito, contribuendo all’emersione di una peculiarità che poi si riflette sull’intera struttura di quello, rendendola un unicum e, conseguentemente, meritevole di un proprio non estensibile giudizio disvaloriale».
La differente struttura delle fattispecie di prelievo abusivo di acque pubbliche finalizzato al commercio delle stesse, e di prelievo abusivo finalizzato all’uso industriale, esige, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, un trattamento differenziato, in ossequio al principio sancito dall’art. 3, secondo comma, Cost.
5. – Con atto depositato il 15 febbraio 2010 si è costituito in giudizio P.V., pure imputato nel procedimento a quo, per sostenere la manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Firenze.
5.1. – La difesa della parte procede innanzitutto al riepilogo del quadro normativo di riferimento, per evidenziare come il solo sintetico esame degli interventi legislativi succedutisi nella regolamentazione della materia in esame sarebbe sufficiente a smentire le argomentazioni poste dal rimettente a fondamento dell’incidente di legittimità costituzionale.
È vero infatti che l’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, come novellato dal d.lgs. n. 152 del 1999, regola la medesima fattispecie contemplata dalla previsione del furto di cosa pubblica, e che pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata, trova applicazione il disposto dell’art. 9, comma 2, della legge n. 689 del 1981, con conseguente prevalenza della disciplina amministrativa.
La condotta contemplata dalle due fattispecie è perfettamente coincidente e consiste nell’impossessamento mediante sottrazione del bene al legittimo detentore, mentre risulta «irrilevante l’altro elemento strutturale che caratterizza il reato ex art. 624, il dolo specifico – finalità di profitto – dal momento che l’illecito amministrativo è circoscritto alla sola condotta del prelievo volontario ed al correlato utilizzo della risorsa idrica senza concessione e senza pagamento del canone».
5.2. – La difesa dell’imputato procede quindi all’esame delle censure prospettate dal rimettente, secondo il quale la discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle condotte connotate da disvalore sociale e nella scelta delle sanzioni applicabili, sarebbe stata male esercitata.
La stessa difesa richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa incontra il limite dell’arbitrarietà, o manifesta irragionevolezza dell’opzione adottata (sentenze n. 206 del 2003 e n. 287 del 2000), vizi entrambi ravvisabili quando «la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare protetta da alcuna ragionevole giustificazione» (sentenza n. 394 del 2006).
Nella specie, tuttavia, non emergerebbero indizi in tal senso: lungi dall’aver semplicemente depenalizzato la fattispecie del prelievo abusivo di acque pubbliche, l’intervento legislativo attuato con il d.lgs. n. 152 del 1999 «ha disciplinato in modo organico, innovativo e globale» la materia delle utenze idriche, introducendo uno speciale regime amministrativo di consenso.
Nemmeno sarebbe ravvisabile un contrasto con altre norme di rango costituzionale, peraltro non indicate dal rimettente, giacché la disciplina in esame risulterebbe perfettamente coerente con il più ampio disegno governativo di gestione delle risorse idriche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, che assoggetta a permessi tanto il prelievo quanto lo scarico di acque dopo l’utilizzo.
A proposito poi della distinzione tra «fruizione» e tutela delle risorse ambientali, la difesa richiama ancora la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 105 del 2008), con riguardo all’affermazione secondo cui l’emersione del problema ambientale avrebbe spinto il legislatore ad intervenire per la tutela della risorsa idrica mediante specifica e organica disciplina, superando così l’impostazione del testo unico del 1933, limitata alla regolamentazione del solo profilo della fruizione (sentenza n. 1 del 2010).
Risulterebbe del resto opinabile l’idea di fondo che sorregge il percorso motivazionale seguito dal giudice a quo, secondo cui per assicurare tutela puntuale ed efficace l’ordinamento non può fare a meno della sanzione penale detentiva; al contrario, la sanzione amministrativa, specie se consistente, può rappresentare un efficace deterrente per enti e imprese.
In una prospettiva più ampia, prosegue la difesa, la scelta legislativa di trasformare la risorsa idrica in un bene esclusivamente pubblico si giustifica, come avviene per altri beni del demanio, con la necessità di regolarne l’uso (con misure di programmata gestione) in modo da consentirne la fruizione diffusa, risultando altresì rilevante la diversità ontologica della risorsa idrica, come bene pubblico, rispetto agli altri beni protetti dall’art. 624 cod. pen.
La stessa difesa passa quindi ad esaminare la denunciata disparità di trattamento sanzionatorio tra la condotta di prelievo non autorizzato di acque, sanzionata in via amministrativa, e l’impossessamento di altri beni, perseguito a titolo di furto, e ciò perfino in casi di particolari forme di impossessamento del medesimo bene costituito dall’acqua pubblica.
Dopo aver segnalato la genericità ed indeterminatezza dell’assunto, si osserva che, per un verso, i beni protetti dalla norma penale non rivestono minore significato valoriale rispetto alla risorsa idrica, come agevolmente desumibile da un pur sintetico esame delle circostanze aggravanti menzionate dall’art. 625 cod. pen. (la tutela riguarda, infatti, non solo l’oggetto dell’impossessamento, ma anche le modalità con le quali si realizza tale effetto), e, per altro verso, che la denunciata disparità di trattamento sanzionatorio delle possibili diverse condotte di impossessamento dell’acqua è frutto di un ragionamento privo di fondamento.
Premessa la condivisibile distinzione tra la condotta di impossessamento e quella di utilizzazione (in rapporto di presupposizione), la difesa dell’imputato rileva come la condotta delineata dalla norma oggetto di censura non distingua tra derivazione e utilizzazione, né ponga un limite finalistico all’utilizzazione dell’acqua, posto che l’unico limite esistente, costituito dall’uso domestico, opera in senso inverso, esentando l’utente dall’obbligo di ottenere la previa concessione.
In realtà, a parere della stessa difesa, l’illecito amministrativo deve ritenersi integrato per il solo fatto che l’utente abusivo si è sottratto non solo al potere di controllo dell’amministrazione concedente, ma anche alla corresponsione del canone per l’uso dell’acqua, con la conseguenza che tutti gli altri usi, ad eccezione di quello domestico, risulterebbero ugualmente sanzionabili ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999.
La questione di legittimità costituzionale sarebbe dunque inammissibile perché sollevata su una erronea interpretazione della normativa censurata.
6. – In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa di S.C., G.G., Z.F., L.M., M.N., F.G., C.U., O.C., M.P.P., M.C., e del Consorzio C.A.V.E.T. Alta Velocità Emilia-Toscana, ha depositato memoria illustrativa nella quale sono riesaminati i profili di censura prospettati dal rimettente.
6.1. − In via preliminare, la difesa delle parti suddette reputa le questioni inammissibili in quanto la prevalenza della norma che sanziona in via amministrativa le condotte in esame, affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e condivisa dal rimettente, costituisce espressione di una scelta politico-criminale riservata al legislatore, non manifestamente irragionevole né lesiva del principio di uguaglianza.
Il rimettente, prosegue la difesa, vorrebbe che la norma che configura l’illecito amministrativo fosse dichiarata illegittima allo scopo di consentire la «riespansione» della norma penale, in tal modo richiedendo un intervento con esiti in malam partem, ma la Corte ha già più volte dichiarato inammissibili questioni con le quali venivano richiesti interventi di contrasto alle scelte depenalizzatrici compiute dal legislatore ordinario.
Né varrebbero in senso contrario gli argomenti con i quali la stessa Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la normativa «di favore» in materia di reati elettorali (sentenza n. 394 del 2006): nella citata pronuncia si trova affermato che, per potersi qualificare una norma come «di favore», deve trattarsi di norma di privilegio in senso proprio, la quale sottrae una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, e si trovi in rapporto di compresenza con quest’ultima.
La norma censurata dall’odierno rimettente, viceversa, non presenterebbe i caratteri indicati, trattandosi di previsione che al più, secondo la teorizzazione contenuta nella stessa sentenza n. 394 del 2006, «delimita l’area di intervento di una norma incriminatrice», con la quale si esprime una valutazione legislativa in termini di meritevolezza ovvero di “bisogno di pena”, cui la Corte non potrebbe sovrapporre una diversa strategia di criminalizzazione.
6.2. – Un ulteriore profilo di inammissibilità delle questioni sarebbe collegato alla applicabilità, alle condotte contestate, della disposizione contenuta all’art. 48, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933.
L’argomento, sul quale il rimettente non avrebbe preso posizione nonostante le sollecitazioni provenienti dalle parti, è già stato esposto nella memoria di costituzione e sintetizzato al paragrafo 4.1.
6.3. – La difesa assume inoltre che la norma che sanziona il delitto di furto non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso in esame, stante la natura dell’opera eseguita. L’applicazione del richiamato art. 48, pure se non intesa come limite al divieto di derivazione senza provvedimento concessorio, determinerebbe una “disponibilità materiale” in capo al soggetto esecutore dell’opera pubblica, qualificabile come detenzione, tale da escludere a priori la configurabilità del furto. Tutt’al più si potrebbe ipotizzare l’applicabilità delle diverse fattispecie dell’appropriazione indebita, sanzionata dall’art. 646 cod. pen., ovvero della deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita dall’art. 632 cod. pen., dovendosi peraltro considerare, quanto alla prima fattispecie, che mancherebbe comunque la querela, e, riguardo alla seconda fattispecie, che essa ricorre solo in presenza della «totale sottrazione dell’acque dalla sua naturale destinazione, in modo permanente o anche solo saltuario» (è richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 48057 del 2009).
Risulterebbe pertanto erronea la individuazione della norma penale che verrebbe a «riespandere» il proprio campo di applicazione, ove la previsione dell’illecito amministrativo fosse dichiarata illegittima costituzionalmente.
6.4. − Nel merito, la stessa difesa evidenzia l’infondatezza della questione.
Richiamati i profili di censura prospettati dal rimettente, si osserva che oggetto di tutela della norma censurata non è la risorsa in sé, quanto la funzione amministrativa che garantisce il contemperamento di diversi interessi. Non vi sarebbe dunque una “intangibilità” assoluta della risorsa idrica, e l’intero sistema dei «servizi idrici», per quanto fondato sul riconoscimento delle acque come risorsa da proteggere, è finalizzato a disciplinare «non l’acqua ma gli usi della stessa».
L’articolato modello organizzativo presuppone che la capacità di disporre delle acque pubbliche non è libera ma, appunto, amministrata e dunque controllata. In tal senso, la tutela del profilo quantitativo delle risorse idriche risulta più appropriata di quella penale, che può invece risultare tecnicamente necessaria nell’ambito della tutela qualitativa, ove occorre evitare il deterioramento potenzialmente irreversibile della risorsa e della salute, quali effetti dell’inquinamento.
La difesa richiama la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata ai «Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative» (Circ. P.C.M. 19.12.1983), nella quale sono indicati i principi di proporzionalità e sussidiarietà ai quali deve ispirarsi il legislatore, tanto più nei casi in cui oggetto di tutela sia una funzione amministrativa di gestione.
Quanto alla censura di disparità di trattamento di condotte diverse, egualmente aggressive del medesimo bene giuridico, la stessa sarebbe manifestamente infondata per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il rimettente muoverebbe da un erroneo presupposto, vale a dire che il legislatore avrebbe distinto tra le diverse motivazioni che sorreggono la condotta vietata, mentre in realtà la distinzione esiste tra “ambiti oggettivi di attività”: da un lato le attività strumentali all’uso domestico, per le quali non è necessaria autorizzazione, e dall’altro le attività non strumentali a tale uso. Tra queste ultime nessuna distinzione può essere fatta: sono tutte vietate, a prescindere dal fine di lucro, se consistono in derivazione o utilizzazione di acqua in assenza di provvedimento autorizzativo dell’autorità competente.
E del resto, come correttamente posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la sanzione amministrativa tutela anch’essa gli interessi patrimoniali dello Stato, con la conseguenza che la norma censurata e la fattispecie che punisce il furto si trovano sicuramente in rapporto di specialità.
In conclusione, si richiama l’attenzione sulla diversità intercorrente tra la situazione oggetto del procedimento principale, di realizzazione di un’opera di interesse pubblico, e altri casi di uso della risorsa idrica a fini di lucro al di fuori di tale contesto. L’eventuale differente trattamento sanzionatorio non sarebbe irragionevole.
7. – In data 15 giugno 2010 ha depositato memoria R.A., imputato nel procedimento a quo, già costituito nel giudizio incidentale.
La difesa dell’imputato richiama i termini della questione e quindi argomenta sui possibili profili di inammissibilità.
7.1. – In primo luogo, si assume l’erronea individuazione della norma oggetto, in quanto l’esclusione della sanzione penale non sarebbe conseguenza diretta della disposizione che ha introdotto l’illecito amministrativo, ma discenderebbe dall’applicazione delle regole che disciplinano il concorso apparente di norme, e in particolare dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, che il rimettente non ha censurato.
Sarebbe inoltre incompleta la motivazione in punto di rilevanza della questione, in quanto lo stesso rimettente dà per scontato che qualora non vi fosse la sanzione amministrativa, troverebbe applicazione la disposizione che punisce il furto.
È quindi richiamato l’art. 48 del r.d. n. 1775 del 1933, a sostegno della mancanza di antigiuridicità delle condotte contestate, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli già sintetizzati al paragrafo 4.1, cui si rinvia.
7.2. – Nel merito, le questioni risulterebbero infondate.
Con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra condotte realizzate prima o dopo l’entrata in vigore della norma di depenalizzazione, la difesa osserva come, a prescindere dalla circostanza che l’effetto depenalizzante opererebbe anche per le condotte antecedenti, la censura risulti oltremodo singolare, in quanto tutte le disposizioni che intervengono a modificare disposizioni precedenti introducono necessariamente una “disparità di trattamento” tra condotte identiche, né il legislatore ha l’onere di far emergere ragioni a fondamento delle proprie scelte.
Quanto alla prospettata irragionevolezza della scelta legislativa di tutelare le risorse idriche in modo meno pregnante rispetto ad altri beni, di importanza sicuramente inferiore, la difesa sottolinea la differenza esistente tra la condotta di spossessamento del legittimo proprietario, al quale venga sottratta la cosa mobile, al fine di trarne profitto, e la condotta di derivazione e utilizzazione dell’acqua in assenza di provvedimento concessorio o autorizzatorio: in tale secondo caso non vi è alterazione della destinazione del bene, costituendo al contrario l’uso industriale uno degli usi consentiti dell’acqua.
Nella specie, verrebbe in rilievo la necessità che l’uso dell’acqua sia regolato attraverso specifici provvedimenti amministrativi, come confermato anche dalla previsione della possibile continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
Con riguardo, infine, alla prospettata ulteriore disparità di trattamento che il rimettente individua nel mantenimento della incriminazione di altre condotte, di aggressione al medesimo bene, la difesa rileva che, nell’ipotesi esemplificativamente riportata nell’ordinanza di rimessione, quella cioè del soggetto che si appropri di acqua di pregio per imbottigliarla e venderla, saremmo di fronte ad un uso non consentito della risorsa, e dunque ad un comportamento che non potrebbe essere autorizzato.
Peraltro, e conclusivamente, ove mai esistessero altri comportamenti, di disvalore pari a quello delle condotte in esame, che fossero sanzionati penalmente, ciò dovrebbe comportare l’illegittimità costituzionale della perdurante incriminazione, non già della previsione dell’illecito amministrativo, come invece pretenderebbe il rimettente.
Considerato in diritto
1. − Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), nella parte in cui, sostituendo l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell’autorità competente.
La norma è oggetto di censura in radice, per l’irragionevolezza che avrebbe contrassegnato la scelta legislativa di «depenalizzare» condotte in precedenza perseguite a titolo di furto, a fronte della finalità, dichiarata nell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1999, di rafforzare la tutela della risorsa idrica.
Ulteriori censure sono prospettate sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, derivante sia dal raffronto con la tutela apprestata ad altri beni, di valore sicuramente inferiore all’acqua, la cui indebita appropriazione è presidiata dalla sanzione penale, sia dal raffronto tra le stesse condotte di impossessamento abusivo dell’acqua, a seconda che siano state poste in essere prima o dopo l’entrata in vigore della norma in esame, ovvero che risultino sorrette o non dalla «finalità industriale».
Con riferimento a quest’ultimo profilo, l’illegittimità costituzionale è costruita dal rimettente secondo lo schema della «norma di favore», sul presupposto che la sanzione amministrativa trovi applicazione nei confronti di un’unica categoria di soggetti, cioè di coloro i quali si impossessano abusivamente di acqua pubblica per fini industriali.
2. – Preliminarmente deve essere disattesa la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, che sostiene l’inammissibilità della questione, per non avere il rimettente esplorato la possibilità di dare della norma censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sulla coesistenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale. In particolare non opererebbe, nel caso di specie, il principio sancito all’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Detto principio è infatti applicabile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, all’ipotesi dell’impossessamento abusivo di acqua pubblica in forza del necessario riferimento alla struttura delle fattispecie, piuttosto che al bene protetto, per l’identificazione del rapporto di specialità tra norma amministrativa e norma penale, con la conseguenza che l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 deve prevalere sull’art. 624 cod. pen. (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 21008 del 2010; n. 25548 del 2007; n. 186 del 2006; n. 39977 del 2005; n. 26877 del 2004).
D’altra parte, la coesistenza della sanzione penale e di quella amministrativa non sarebbe necessariamente il frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata. L’effetto di depenalizzazione, scaturente dall’applicazione del principio di specialità, è stato voluto dal legislatore, che ben conosceva il sistema normativo nel quale la nuova disposizione andava ad inserirsi. La valutazione sulle questioni si riduce, dunque, in questa prospettiva, alla verifica della non manifesta irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con l’introduzione della norma censurata.
3. – Le questioni sono inammissibili per ragioni diverse, di seguito specificate.
3.1. – Il rimettente censura come irragionevole la scelta del legislatore di depenalizzare l’impossessamento abusivo di acqua pubblica, perché in contraddizione con il complessivo indirizzo legislativo degli ultimi decenni, volto a rafforzare la tutela del bene acqua, preservando la sua fruizione da parte della generalità dei cittadini. Tale orientamento di maggior tutela dell’ambiente e degli interessi della collettività sarebbe in contrasto con l’attenuazione del rigore punitivo nei confronti dei soggetti che sottraggono quantitativi più o meno ingenti di acqua all’uso pubblico, per realizzare profitti diretti, derivanti da eventuali commercializzazioni dell’acqua abusivamente captata, o indiretti, derivanti da utilizzazione dell’acqua stessa per finalità industriali o comunque produttive, ottenendo la disponibilità del bene senza sostenere alcun costo.
3.2. – Occorre ricordare, con riferimento a tale censura, come questa Corte abbia costantemente affermato che «il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reati […] rientra nella discrezionalità legislativa censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole» (sentenza n. 364 del 2004, ed in precedenza, ex plurimis, sentenza n. 313 del 1995, ordinanze n. 110 del 2003, n. 144 del 2001, n. 58 del 1999).
A proposito dell’efficacia delle sanzioni penali e di quelle amministrative, questa Corte ha pure osservato: «La sanzione penale non è l’unico strumento attraverso il quale il legislatore può cercare di perseguire la effettività dell’imposizione di obblighi o di doveri […]. Vi può essere uno spazio nel quale tali obblighi e doveri sono operanti, ma non assistiti da sanzione penale, bensì accompagnati da controlli e da responsabilità solo amministrative o politico-amministrative. Ed è anzi rimesso alla scelta discrezionale del legislatore, purché non manifestamente irragionevole, valutare quando e in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, che per sua natura costituisce extrema ratio, da riservare ai casi in cui non appaiano efficaci altri strumenti per la tutela di beni ritenuti essenziali» (ordinanza n. 317 del 1996).
4. – In conformità ai principi sopra ricordati, nel caso di specie non si può ritenere che la scelta di depenalizzazione operata dal legislatore con la norma censurata sia manifestamente irragionevole.
Deve essere innanzitutto considerato il contesto normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, che attua il disegno del legislatore di regolare in modo sistematico e programmato l’utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, come l’acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto dominicale. L’integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee è stata strettamente legata dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà. Da questo doppio principio discende la conseguenza che deve essere la pubblica amministrazione a disciplinare e programmare l’uso delle acque, allo scopo di consentire un equilibrato consumo per finalità diverse da quelle domestiche, nel quadro della fondamentale distinzione contenuta negli artt. 17, comma 1, e 95, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933. Non viene in rilievo la contrapposizione tra lo Stato, proprietario del bene, ed i privati, ma l’integrazione tra pubblico e privato, nel quadro della regolazione programmata e controllata dell’uso dell’acqua, che costituisce bene di tutti e, in quanto tale, deve essere distribuita secondo criteri razionali ed imparziali stabiliti da apposite regole amministrative.
La legge non distingue tra i soggetti privati che si impossessano di acque sotterranee, ma, a norma del citato art. 95, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, regola diversamente gli usi domestici, definiti e delimitati dall’art. 93 del medesimo t.u., e gli usi diversi, per i quali sono necessarie l’autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l’utilizzo, secondo il piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione.
In questo quadro, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati. Questi ultimi hanno titolo ad utilizzare le acque sotterranee, nel rispetto delle norme amministrative poste a salvaguardia dell’integrità della risorsa, che non può essere indiscriminatamente depauperata da prelievi che sfuggono ai poteri regolativi della pubblica amministrazione.
Da quanto appena detto si deduce che la scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole, giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Tale rapporto viene alterato dalla violazione di norme che non sono poste soltanto a presidio della proprietà pubblica del bene, collocato in una sfera separata rispetto a quella dei cittadini, ma soprattutto a garanzia di una fruizione compatibile con l’entità delle risorse idriche disponibili in un dato territorio e con la loro equilibrata distribuzione tra coloro che aspirano a farne uso. Se tutti hanno diritto di accedere all’acqua, l’aspetto dominicale della tutela si colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi, allo scopo di evitare che impossessamenti incontrollati possano avvantaggiare indebitamente determinati soggetti a danno di altri o dell’intera collettività.
La sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata, d’altra parte, non è irrisoria e priva di efficacia dissuasiva, giacché i trasgressori, previa cessazione delle utenze abusive, sono tenuti al pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro, oltre che dell’intero importo dei canoni non corrisposti. L’intento principale del legislatore è quello di ricondurre nell’alveo della regolarità un uso dell’acqua non in linea con la disciplina amministrativa, come dimostra peraltro la possibilità della continuazione provvisoria del prelievo – prevista dalla stessa norma censurata – «in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti dei terzi e con il buon regime delle acque». L’intreccio tra interessi pubblici e privati, emergente da tale ultima previsione, dimostra che tutto il sistema è finalizzato a mantenere l’equilibrio ambientale, l’equa utilizzazione delle risorse idriche da parte dei cittadini e l’effettività dei piani di salvaguardia delle stesse, predisposti dalle autorità competenti.
Altre scelte legislative sarebbero astrattamente possibili, ma non spetta a questa Corte dare valutazioni di merito, una volta rilevata la non manifesta irragionevolezza di quella che sta alla base della norma censurata.
5. – La non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di depenalizzazione dell’impossessamento abusivo di acqua pubblica a fini non domestici, rende manifesta l’inconferenza del richiamo del rimettente alla sentenza n. 394 del 2006 di questa Corte, in tema di “norme penali di favore”. Tale pronuncia si basa sul presupposto della compresenza nell’ordinamento di una norma penale che contiene una fattispecie più ampia e di una norma che irragionevolmente prevede un trattamento più favorevole per specifiche condotte, altrimenti rientranti nella previsione generale.
Il caso oggetto del presente giudizio riguarda una norma che ha escluso dalla rilevanza penale comportamenti che astrattamente avrebbero potuto essere ricondotti alla previsione generale di cui all’art. 624 del codice penale, secondo una scelta legislativa non riconducibile al fenomeno delle cosiddette norme penali di favore. Infatti, come si è visto al par. 3, non si riscontra una palese irragionevolezza nell’orientamento del legislatore a considerare recessivo il profilo proprietario della tutela delle acque pubbliche rispetto a quello programmatorio e gestionale, maggiormente consono, nella valutazione dello stesso legislatore, alla finalità di regolare un corretto uso, da parte dei cittadini, delle risorse idriche, alle quali comunque hanno titolo ad accedere.
Il riferimento, operato dal rimettente, all’ipotesi di un’appropriazione dell’acqua pubblica a mero scopo di commercializzazione – indipendentemente quindi da un uso industriale, agricolo o comunque produttivo – esula dall’oggetto del giudizio principale e pertanto non assume rilevanza nell’attuale incidente di legittimità costituzionale.
Essendo mirata in definitiva ad indurre un sindacato sulle scelte discrezionali sanzionatorie del legislatore, in una situazione non caratterizzata dalla manifesta irragionevolezza delle relative opzioni, la questione sollevata dal rimettente risulta inammissibile.
6. – Parimenti inammissibile è la questione basata sulla presunta irragionevolezza della depenalizzazione dell’impossessamento abusivo di acqua pubblica, in quanto si doterebbe un bene prezioso per la collettività di una tutela meno intensa rispetto ad altri beni di minore rilevanza nella scala dei valori costituzionali. Il rimettente tuttavia non precisa quali sarebbero tali beni e non indica neppure quali dovrebbero essere i criteri oggettivi per istituire una simile gerarchia di valori, assunta come punto di riferimento astratto per motivare l’asserita violazione, sotto questo profilo, dell’art. 3 Cost. La questione è pertanto inammissibile per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.
7. – Non ha maggior pregio la questione costruita sulla presunta arbitrarietà della depenalizzazione sotto il profilo intertemporale, giacché, ad avviso del rimettente, i comportamenti anteriori all’entrata in vigore della norma depenalizzatrice sarebbero sottoposti al rigore della norma penale, mentre quelli successivi sarebbero assoggettati soltanto alla sanzione amministrativa.
L’affermazione del rimettente prova troppo. Difatti, se il ragionamento potesse avere ingresso nella considerazione del giudice costituzionale, tutte le norme di depenalizzazione sarebbero illegittime, giacché vi è pur sempre un termine temporale della loro entrata in vigore. A ciò si deve aggiungere che l’effetto discriminatorio prospettato dal giudice a quo non potrebbe verificarsi, in ragione dell’art. 2 cod. pen., del quale non si tiene alcun conto nell’ordinanza di rimessione. La questione pertanto difetta palesemente di rilevanza sotto il suddetto profilo ed è di conseguenza inammissibile.
8. – Infine, come già rilevato al par. 4, la legge non distingue tra utilizzazioni industriali, agricole o di altro tipo, ma soltanto tra usi domestici e altri usi. Non è ipotizzabile pertanto, al contrario di quanto asserito dal rimettente, una discriminazione tra gli usi industriali e gli altri usi possibili, che possono essere di vario genere e sono tutti assoggettabili, in caso di trasgressione delle norme amministrative, al medesimo regime sanzionatorio. La questione è quindi inammissibile per erronea ricostruzione del quadro normativo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), che sostituisce l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA