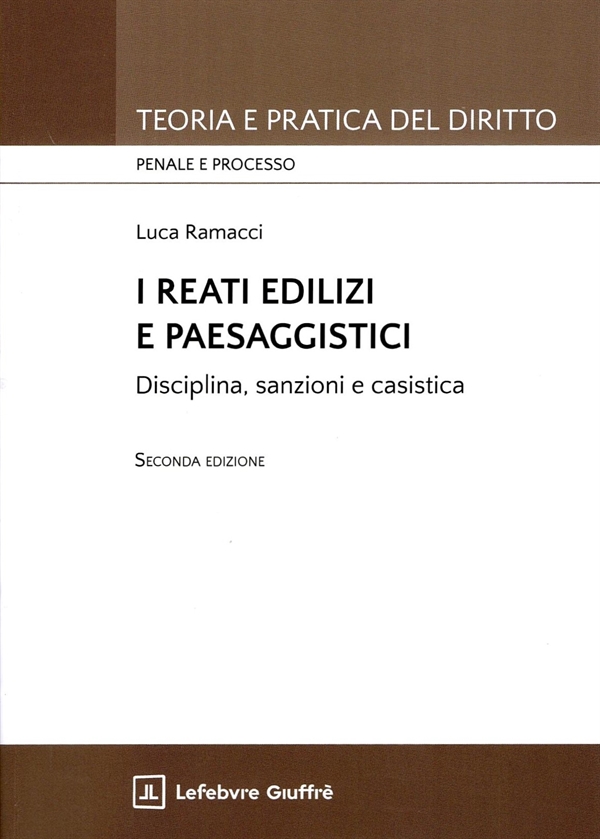La definizione di rifiuto e la sua evoluzione normativa: dal concetto giuridico al regime dell’end of waste
La definizione di rifiuto e la sua evoluzione normativa: dal concetto giuridico al regime dell’end of waste
di Oreste PATRONE
La rigidità delle definizioni: punto di forza e fragilità
La tensione tra precisione e adattabilità normativa è un dilemma antico. Quanto più una definizione giuridica si affina, tanto più rischia di irrigidirsi trasformando le parole in vincoli. Questo irrigidimento, pur garantendo certezza del diritto, tende a comprimere la capacità del sistema normativo di adeguarsi alla complessità del reale. L’emergere di situazioni non disciplinate spinge verso interpretazioni evolutive e prassi correttive, alimentando una casistica di eccezioni che spesso sfida la tenuta del sistema stesso.
La definizione di rifiuto: pietra angolare e nodo ermeneutico
Emblematico, in tal senso, è il concetto di rifiuto, introdotto con il DPR 915/1982 e poi ridefinito dal D.lgs. 22/1997, che ne ha consolidato la struttura recependo la definizione comunitaria. Il concetto si emancipa dalla mera nozione di abbandono e si fonda sulla volontà o sull’obbligo del detentore di disfarsi di un oggetto o una sostanza.
Questa definizione a triplice criterio – materiale, soggettivo e oggettivo – ha contribuito a rendere il concetto di rifiuto un campo semantico stratificato, dove si intrecciano diritto comunitario, prassi amministrativa, interessi industriali e sensibilità ambientali. È proprio nei margini definitori che si accendono i conflitti interpretativi più accesi: il confine tra risorsa e rifiuto, tra materia riutilizzabile e materiale da sottoporre a gestione e smaltimento.
Le prime eccezioni e l’intervento legislativo
Il primo tentativo di derogare alla definizione avviene con la legge n. 443/2001 “Legge Lunardi”, che esclude dalla nozione di rifiuto le terre e rocce da scavo, se riutilizzate secondo un progetto approvato e non contaminate. L’intento era di chiarire i criteri soggettivi impliciti nelle espressioni “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi”. Il legislatore torna sul tema nel 2002, tentando di uniformare l’interpretazione nazionale con quella comunitaria, sostenuta dalla giurisprudenza, come nella sentenza ARCO Chemie Nederland della Corte di Giustizia Europea.
L’evoluzione normativa: dal rifiuto al concetto di end of waste
La disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto trova compiuta definizione con l’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, che recepisce l’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE. Il meccanismo dell’End of Waste [EOW] consente a un oggetto o a una sostanza di non essere più considerato rifiuto, se soddisfa determinati requisiti ambientali, tecnici e di mercato – in origine o a seguito di un processo di recupero.
La gerarchia normativa prevede:
• Regolamenti europei, che prevalgono su tutti [es. rottami ferrosi, vetro];
• Decreti ministeriali nazionali [es. DM 22/2013 per CSS, 188/2020 per carta e cartone o 127/2024 per gli aggregati riciclati]
• Valutazioni caso per caso, residuali ma cruciali.
La “ratio” del meccanismo EOW è duplice:
• Migliorare le prestazioni ambientali dei materiali riciclati;
• Rafforzare la fiducia dei consumatori e ridurre gli oneri amministrativi.
La sfida del caso per caso: tra discrezionalità e lacune tecniche
L’art. 184-ter, comma 3, riconosce alle Regioni il potere di autorizzare, caso per caso, la cessazione della qualifica di rifiuto. Tuttavia, in assenza di criteri tecnici uniformi, tale valutazione si basa su pareri delle ARPA [ISPRA, per gli impianti di competenza statale] che, pur obbligatori e vincolanti, devono essere rigorosamente motivati.
Considerazioni operative e il compito istituzionale decisivo
La gestione della qualificazione e della cessazione della qualifica di rifiuto non è soltanto un esercizio tecnico o burocratico, ma un atto profondamente culturale. Ogni interpretazione e autorizzazione non riguarda solo un flusso materiale, ma incide sulla direzione che la nostra società intende intraprendere.
L’attuale sistema “caso per caso”, pur utile nella gestione transitoria, evidenzia fragilità strutturali e rischi di frammentazione territoriale, oltre a generare incertezza giuridica e tensioni operative. Ne derivano disparità tra regioni, indecisione tra enti competenti e sfiducia tra operatori economici e cittadini.
È necessario che lo Stato, le Regioni e il Sistema SNPA assumano con consapevolezza la portata strategica di queste scelte: razionalizzare, uniformare, motivare. Occorre passare da un approccio di gestione del rischio a una progettualità sistemica, capace di integrare ambiente, economia e innovazione. E questo significa investire nella costruzione di un sapere condiviso, in un corpo tecnico multidisciplinare capace di valutare non solo il “se” ma anche il “come” e il “perché” un materiale può tornare a essere risorsa.
Nel progressivo chiarimento del quadro normativo sull’End of Waste, due pronunce giurisprudenziali hanno segnato tappe fondamentali verso una maggiore coerenza e responsabilità ambientale.
La sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 1229/2018 ha rappresentato un punto di svolta: ha chiarito che, in assenza di criteri europei armonizzati o di decreti ministeriali ad hoc, il riconoscimento "caso per caso" della cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire attraverso provvedimenti regionali, ma solo tramite atti statali. Il Consiglio di Stato ha fondato la propria motivazione sull’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, letto alla luce dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE e dell’art. 117 Cost., riaffermando la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e denunciando il rischio di un sistema autorizzativo frammentato e incoerente.
A consolidare tale orientamento è intervenuta la Corte di Cassazione ha ribadito che la cessazione della qualifica di rifiuto [End of Waste] costituisce un’eccezione alla disciplina ordinaria e richiede una valutazione istruttoria rigorosa, fondata su criteri tecnici documentati e sul parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o ARPA competente, come previsto dall’art. 184-ter del D.lgs. . 152/2006. La sentenza ha chiarito che:
• L’EoW è un processo costitutivo, non dichiarativo: il rifiuto cessa di essere tale solo al termine del trattamento e non retroattivamente.
• L’onere della prova grava sull’operatore, che deve dimostrare con certezza la destinazione del materiale e la conformità ai requisiti ambientali e di sicurezza.
• Le irregolarità nelle operazioni di campionamento non invalidano automaticamente l’accertamento, ma impongono al giudice una valutazione tecnica approfondita.
• In materia di danno ambientale, la lesione del bene giuridico “ambiente” ha natura superindividuale, e il risarcimento è riservato allo Stato, salvo casi specifici di danno patrimoniale o morale a soggetti privati.
Queste due decisioni, lette in chiave sistematica, confermano l’esigenza di un quadro autorizzativo uniforme, trasparente e tecnicamente fondato, capace di coniugare rigore giuridico e responsabilità istituzionale nel rilascio delle autorizzazioni End of Waste.
A chiusura dell’arco critico, questa pronuncia ha consolidato la necessità di un quadro normativo uniforme, superando la lettura più permissiva sostenuta in precedenza da alcune Regioni e dallo stesso Ministero dell’Ambiente.
In tale direzione si colloca l’istituzione del Nucleo End of Waste [NEW], prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, della Legge 9 maggio 2025, n. 69, che modifica l’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il NEW opererà alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il compito di fornire supporto tecnico qualificato alle attività istruttorie finalizzate all’adozione dei decreti End of Waste.
Questa misura rappresenta il primo passo concreto verso una armonizzazione nazionale dei criteri EoW, con l’obiettivo di superare le incertezze interpretative del sistema “caso per caso” e di promuovere maggiore coerenza, tracciabilità e qualità ambientale nelle autorizzazioni.
Infine, va detto senza retorica: il rifiuto è lo specchio di ciò che una società non riconosce più come utile. Recuperarlo, ridefinirlo e reintegrarlo non è solo una pratica ambientale, ma un gesto etico, un segno di civiltà. In questo gesto si manifesta una visione della democrazia ecologica: una forma di governo delle risorse fondata non sull’esclusione, ma sull’inclusione intelligente di ciò che sembrava scarto. L’economia circolare, dunque, non è un algoritmo produttivo, ma una grammatica di senso. E noi, nel nostro ruolo istituzionale, ne siamo i custodi.