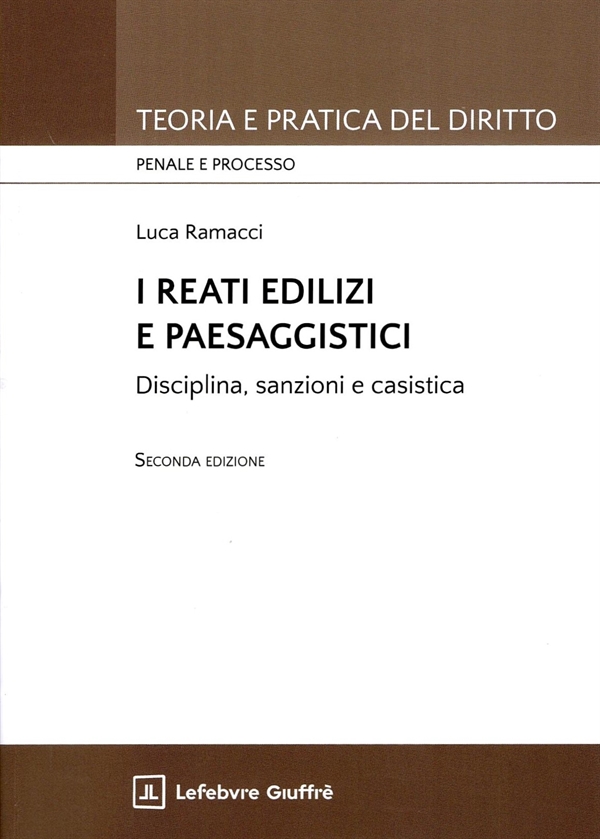La stagione
dell’industrializzazione per poli di sviluppo dopo cinquant’anni volge al
termine. Si consumano nelle grandi aree industriali del Mezzogiorno le ultime
battute di quel ciclo, ed in questo clima l’intervento delle bonifiche assume
oltre che il significato di un
adempimento necessario anche quello
di un conto, da saldare, a consuntivo.
Priolo
Augusta e Siracusa nel contesto nazionale sono il tipico esempio di questo
processo a termine e sono divenuti, tra quelli di analoga natura, i luoghi
simbolo del recupero ambientale. E’ chiaro, quindi, che
in quell’area si misurerà l’efficacia della normativa che regola la
bonifica dei siti inquinati; sarà una delle finestre
dalla quale affacciarsi per seguire e capire se questa occasione di radicale
recupero ambientale saprà cogliere, senza sprechi, le opportunità offerte
dalla legge, ovvero se resterà un’altra occasione mancata.
Sono
dieci gli stabilimenti industriali principali interessati nel polo petrolchimico
di Augusta Priolo Siracusa che hanno redatto i piani di caratterizzazione
e di bonifica previsti dall’art. 17 del D.Leg.vo 22/97, per una
superficie complessiva di oltre 1500 ettari.
Un
territorio, insieme a Gela, che oggi soffre insieme di surplus di previsioni
dell’emergenza e di deficit di interventi concreti.
Oltre ad essere considerato dalla L. 426 del 9 dicembre 1998 sito di
bonifica di interesse nazionale, quello stesso territorio è stato già oggetto
di dichiarazione di area ad alto rischio di crisi ambientale, è interessato
dalle misure previste dall’ordinanza
di commissariamento della Regione Sicilia nel settore rifiuti del gennaio 1999,
ed è stato oggetto di progetti di bonifica previsti dalla legge regionale n°40
del 21 aprile 1995. Un
territorio che nella conferenza di
servizio, di marzo scorso, mirata alla identificazione dei siti potenzialmente
inquinati, oltre alle aree a terra
nei Comuni di Priolo, Melillli, Augusta e Siracusa è stato
anche allargato ad una vasta area marina che comprende integralmente i
porti di Augusta e Siracusa.
La
vastità dell’intervento lascia spazi ampi di discrezionalità, lascia aperte
brecce a rischio di scelte che potrebbero rivelarsi inutili, quando non
addirittura dannose, lascia ampie maglie per le incursioni ecospeculative
private ed alle furbizie di Stato; la bonifica si sovrappone ad altre misure
eccezionali in corso di attuazione, rivelatesi inutili quando non diseducative
per le istituzioni locali incentivate da quei provvedimenti ad omettere
iniziative di intervento ordinario.
Si
è passato dall’intervento straordinario, con le sue retoriche dello sviluppo
quantitativo e dell’uso illimitato ed incontrollato delle risorse naturali,
alle “grida” di segno opposto delle dichiarazioni di emergenza per le
risorse idriche, con la cascata negli ultimi vent’anni di progetti, opere
pubbliche ed interventi finanziari che
sino ad oggi hanno prodotto soltanto grandi incompiute di cemento; della
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di dieci anni fa,
ed alla redazione di un piano di risanamento ambientale, che da oltre cinque
anni stenta a muovere i primi passi attuativi, sino alle richieste di questi
giorni di commissariamento; la legge regionale del 1995 sulla bonifica dei siti
destinati a discariche d’emergenza ai sensi dell’art.12 DPR 915/82 ha
prodotto esclusivamente incarichi professionali e strumenti di pianificazione
disattesi; si è sovrapposta infine, a quelle dichiarazioni, la ordinanza di
commissariamento della Regione Sicilia nel settore rifiuti del gennaio 1999, che
prometteva un’altra svolta di recupero ambientale , emanata nelle stesse
settimane in cui veniva pubblicata la L.426/98 che considerava le stesse aree
oggetto di bonifica di interesse nazionale.
Se
pensiamo che dal ’90 ad oggi ci sono voluti ben cinque anni solo per
predisporre il piano di risanamento (approvato il 17 gennaio 1995) ed altri
cinque sono trascorsi nel vano tentativo di attuarlo; se si pensa che non si è
riusciti, nonostante la ridondanza delle dichiarazioni, a porre mano
all’attuazione del sistema di pianificazione ordinaria (la legge sui suoli,
quella sui rischi di incidenti rilevanti, quella sull’inquinamento
atmosferico, la normativa ordinaria sui rifiuti, la normativa a difesa delle
acque e quella sulle risorse idriche) è chiaro che si ha il timore che anche
per questo strumento di risanamento complesso e che abbisogna di uno sforzo
collettivo di istituzioni pubbliche ed operatori, si consumino risorse, carta e
tempo invano sul piano inclinato delle proroghe, delle assenze concrete della
parte pubblica unite alla pressione dilatoria delle parti private interessate.
Nell’esperienza
recente dell’area industriale di Priolo Augusta Siracusa nel contesto degli
interventi d’emergenza , contesto sostanzialmente analogo a quello che lo
scenario delle bonifiche ridisegna, si è distinta anche l’assenza del
controllo successivo agli interventi, ed in molti casi la inconsistenza delle
scelte di intervento in relazione alla complessità e gravità della situazione.
Alcuni progetti, che verranno tra poco resi esecutivi, riguarderanno interventi
di mero belletto, fasce a verde attorno agli svincoli autostradali,
piantumazione di alberi nella zone limitrofe agli stabilimenti industriali,
fascia a verde lungo l’ex statale 114 che attraversa la zona industriale, il
recupero delle Saline di Priolo.
Non
era certamente questa operazione di incipriamento che ci si aspettava dalla
dichiarazione di area a rischio di crisi ambientale , se è vero che il
legislatore di quindici anni fa aveva promesso che il piano di risanamento
avrebbe dovuto servire ad individuare le
misure urgenti atte a rimuovere le situazioni a rischio e per conseguire il
ripristino ambientale.
A tutte le richiamate
dichiarazioni d’emergenza ambientale, di area ad elevato rischio di crisi, di
bonifica di interesse nazionale, non ha corrisposto neppure un’adeguata
iniziativa di rafforzamento delle strutture ordinarie di controllo ambientale.
Così, per esempio, il Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia, il
migliore di Sicilia per impegno e qualità degli operatori, unico organo
decentrato con finalità di prevenzione ambientale e di tutela della salute
pubblica, con compiti di controllo tecnico in materia di tutela delle acque, del
suolo, dell’aria, nonché del controllo del rischio industriale,
dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico, da anni non viene potenziato
per le crescenti responsabilità di prevenzione e repressione degli
inquinamenti.
Sino ad oggi la concreta risultante di quelle dichiarazioni è stato l’appesantimento della struttura burocratica, l’aggravamento dei procedimenti , oggi difficilmente governabili, che prevale sullo sviluppo dei processi produttivi e si sovrappone alle ordinarie misure di programmazione dell’economia e del territorio. Inoltre le successive misure eccezionali hanno giustificato la distribuzione di incarichi di progettazione, di studi e di analisi autoreferenziali, privi di concreta capacità di indirizzo ed intervento.
La
normativa dell’emergenza ambientale, indirizzata sia alle istituzioni
pubbliche che all’imprenditoria privata, è stata inoltre una grande occasione
di alibi per la tradizionale inerzia dell’amministrazione regionale e di
quelle locali, che hanno vissuto la pianificazione in corso in un clima di
attesa passiva, quando non addirittura pretensiva di interventi assolutamente
privi di coerenza con la natura eccezionale degli strumenti.
Oggi per Priolo Augusta e
Siracusa vale il riconoscimento dello stesso Ministero per l’Ambiente secondo
cui “ per le aree inquinate si è intervenuti con la dichiarazione di aree ad
elevato rischio di crisi ambientale e con la conseguente predisposizione dei
piani di risanamento. Tali strumenti restano validi anche se la loro operatività
si è rilevata inadeguata”.
E’ chiaro che nel quadro
descritto la politica delle proroghe rischia di frustrare un processo di
recupero non più procrastinabile, e di compromettere la stessa credibilità
delle istituzioni pubbliche impegnate. Essa non rende un buon servizio alle
tensioni, pur astrattamente presenti, di inversione di tendenza; tradisce, anzi,
l’antico vizio del nostro legislatore in materia ambientale di porre leggi di
principio di grande respiro, e di praticare con il diritto derivato, le deroghe
e le proroghe lo svuotamento dei principi assoluti espressi, lasciando che
prevalga, come ha prevalso negli ultimi venticinque anni la
malamministrazione ambientale.
Continuare ad arricchire il
sistema fitto delle proroghe che si sono succedute dalla Merli al Ronchi, non
costituisce una risposta soddisfacente non soltanto per quanti pretendono a buon
conto l’intervento sollecito secondo il principio comunitario “chi inquina
paga”, ma, a nostro avviso, neppure per quanti hanno centrato le proprie
economie in quell’area; l’istituto della proroga è istituto che avvelena
pianificazioni e progetti di sviluppo e che di fatto frustra le iniziative
dell’imprenditoria più sana e responsabile, a favore di quell’altra
cronicamente adusa alle furbizie e agli attendismi tattici.
L’avvio del Ronchi e delle
procedure di bonifica non lascia sperare la resa promessa, solo se pensiamo che
per essere emanato lo stesso D.M. 417/99 è andato di gran lunga oltre quel
termine assegnato dall’art.17 del decreto Ronchi, termine che cadeva, guarda
caso nello stesso mese di giugno di tre anni fa, nel 1997, e che la proroga di
questi giorni potrebbe spostare l’inizio di ogni intervento
al Gennaio 2001.
E’
chiaro che il ritardo di ben quattro anni pesa sulle ragioni del recupero
ambientale e rischia di iscriversi, anche per questo strumento, nella lista nera
delle misure d’emergenza inefficacemente sperimentate, con un effetto diretto
per quelle aree come Priolo Augusta Siracusa che corrono il rischio di vedere
spegnersi, per le ragioni crude del mercato, le economie che hanno procurato
l’occasione della bonifica senza a quelle trovare risposte compensatorie di
riconversione .



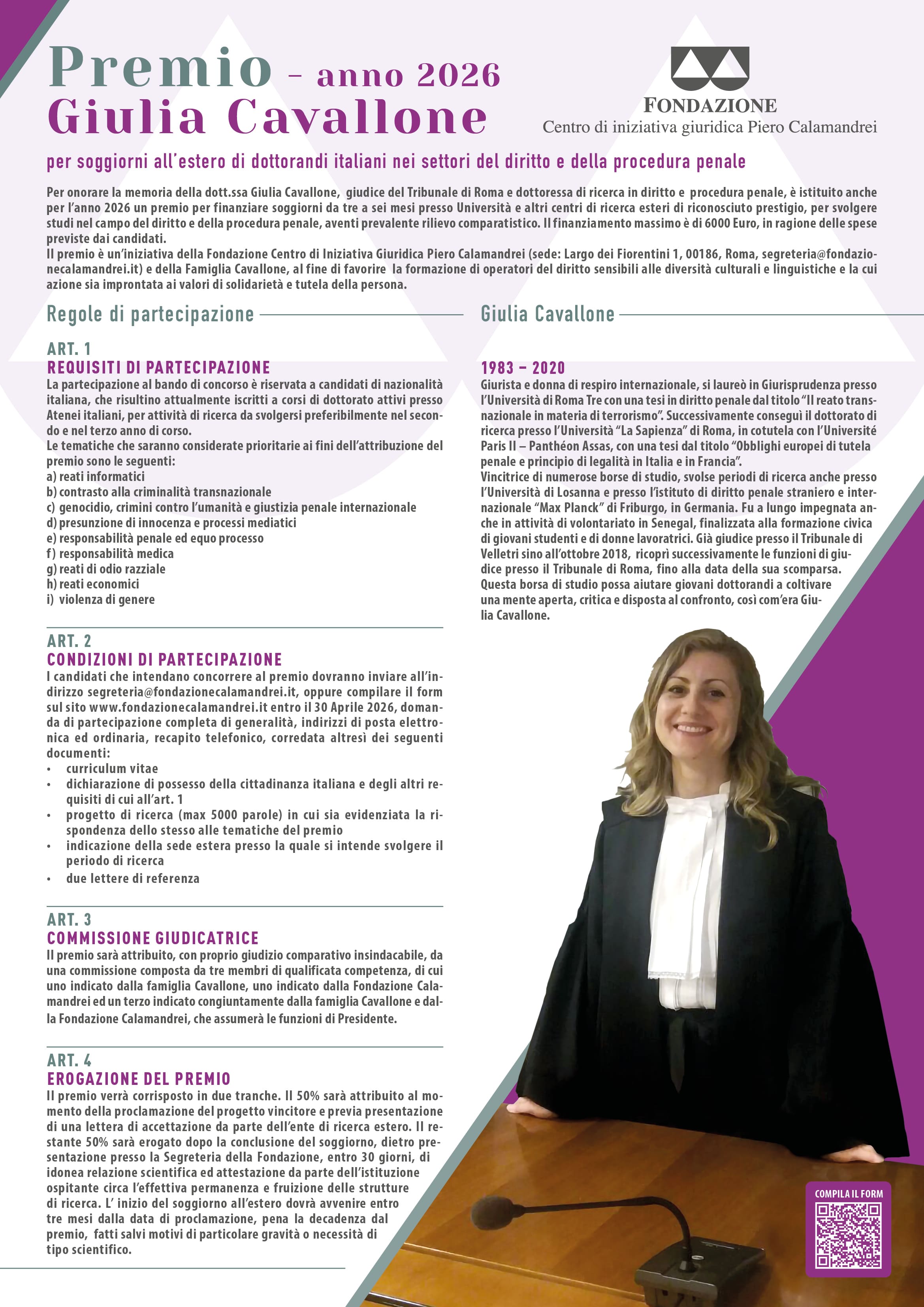 Scarica la locandina
Scarica la locandina