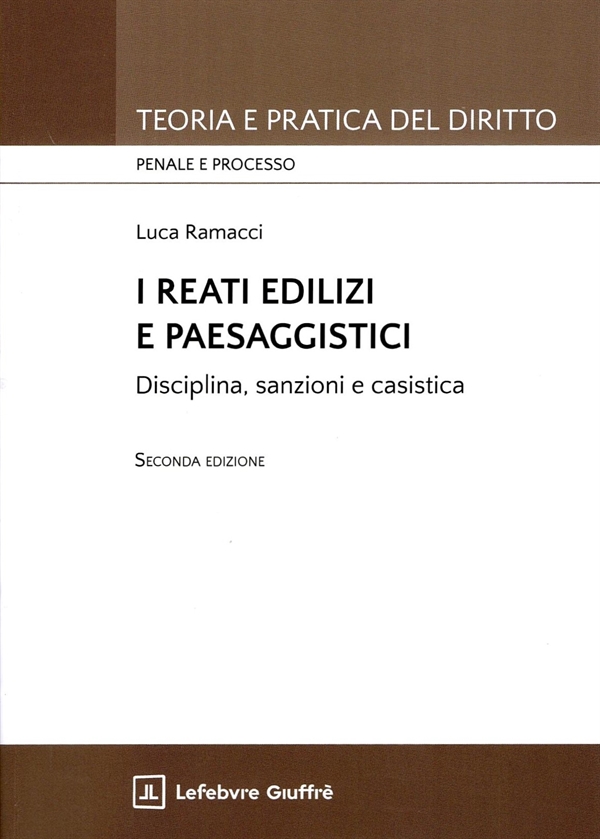Ufficio Studi Giustizia Amministrativa
Ufficio Studi Giustizia Amministrativa
La pianificazione standardizzata e il «caso Milano»: riflessioni dopo un’audizione parlamentare
di Pier Luigi PORTALURI
documento pubblicato dall'Ufficio Studi Giustizia Amministrativa nel sito giustizia-amministrativa.it
La pianificazione standardizzata e il «caso Milano»: riflessioni dopo un’audizione parlamentare
Pier Luigi Portaluri
Ordinario di Diritto amministrativo
nel Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università del Salento –
Componente del Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie
per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP)
Sommario: 1. Un caso, un metodo e quattro chiavi di lettura. – 2. Il comma 1 della p.d.l. 1987. Sogni nascosti (quindi pericolosi). – 3. Il comma 2. Eccesso di discrezionalità applicativa e rischio di inattuazione per burocrazia difensiva. – 4. Il comma 3. Conformità o mera compatibilità degli interventi? Verso un vieto condono discrezionale. – 5. Il cuore della vicenda: la sgradita inderogabilità degli standard. – 6. La lett. b) del comma 3. La deroga alle distanze e la pianificazione attuativa. – 7. Il comma 4. Nuovi perimetri (e nuovi rischi d’incostituzionalità) della regolazione in materia di ristrutturazione edilizia. – 8. Il comma 5: il provvedimento demolitivo o ripristinatorio. – 9. Il comma 6. Ancora sulla ristrutturazione. – 10. Il comma 7 e la clausola di stile sui diritti dei terzi. – 11. Il comma 8 e gli intricati rapporti della p.d.l. col codice Urbani. – 12. Marcel Déat e la pianificazione standardizzata: per una via d’uscita giusta, effettiva e costituzionale.
1. Un caso, un metodo e quattro chiavi di lettura. – La Camera dei Deputati sta esaminando una p.d.l. – la n. 1987/’24 (Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana) – che intende dare una risposta organica alle problematiche emerse nei mesi scorsi circa le modalità di gestione di specifiche, importanti trasformazioni territoriali nel Comune di Milano (e non solo): queste righe contengono le mie riflessioni dopo essere stato audito a Montecitorio dall’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
Il disegno racchiuso in quella p.d.l. è però molto più ampio, poiché esso guarda anche al futuro – e a tutto il territorio italiano – in una prospettiva di vigenza certamente non di breve periodo.
La normazione consiste in un solo articolo, composto da nove commi.
I temi affrontati – pur nella brevità del testo – sono assolutamente cruciali, concernendo in apicibus i due pilastri sui quali fonda il trilite del nostro diritto urbanistico: il principio di pianificazione e quello di standardizzazione.
Ritengo quindi preferibile parlare della p.d.l. mediante un approccio strettamente esegetico: cioè analizzando i commi nella loro successione numerica, pur cogliendone ovviamente i nessi semantico-precettivi.
Ci sono quattro criteri di avvicinamento interpretativo alla p.d.l. n. 1987/’24 (Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana): quattro precomprensioni (che peraltro aspirano – fallibilmente – alla neutralità). Tipi, a loro volta, divisi in due gruppi.
Primo gruppo. Leggere le norme: a) come rivolte al passato; b) come rivolte al futuro.
Secondo gruppo. Leggere le norme: a) come se concernessero solo il caso Milano; b) come norme che “ricadono” su tutto il territorio italiano.
Poiché questi quattro criteri si intersecano continuamente, ho ritenuto preferibile procedere seguendo l’ordine dei commi che compongono l’unico articolo della p.d.l., segnalando in corso d’analisi la rilevanza di uno o più di quei criteri.
2. Il comma 1 della p.d.l. 1987. Sogni nascosti (quindi pericolosi). – Possiamo quindi partire dal comma 1. Per comodità di lettura, lo riportiamo integralmente qui di seguito.
«1.In vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all’articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.».
Non so, ovviamente, se questo specifico effetto di senso sia stato voluto dall’ottimismo dell’estensore. Sembra tuttavia – o quanto meno può sembrare – che vi siano non uno, ma due “termini” (metto fra virgolette per ragioni evidenti, derivanti dall’evanescenza di quelle previsioni sinestetico-temporali) che regolano la tempistica delle attività di cui il comma parla.
Il primo “termine” discende dall’incipit del comma: «in vista» (onde la speranzosa, se volontaria, sinestesia). Qualcosa, dunque, che si scorge lontanissimo, tanto da essere forse inattingibile. Che si tratti di una visione non meno desïata che sottratta a ogni chelazione, lo si comprende con certezza non appena si prosegue nella lettura: la veduta riguarda addirittura qualcosa di non troppo diverso dal sol dell’avvenire, cioè «un riordino organico della disciplina di settore».
Ecco che quei quattro criteri di lettura ci vengono utili. Non c’è dubbio che il comma: a) riguardi il futuro (e che futuro!); b) concerna l’intero territorio. I fatti accaduti a Milano, se mai, sono solo una piccola occasio per mirare a traguardi di grande ambizione: arrivare cioè a terminare il ponte più lungo del mondo, iniziato nel lontano 1967 (con l’eponima legge n. 765), ma non più proseguito, né quindi mai terminato.
Superiamo, ancora, un’altra trascurabile incertezza: cosa s’intenda per «disciplina di settore». Quale settore? È semplicemente quello – così angusto, «so eng» – dei rapporti fra livelli di pianificazione? Penso invece che si tratti – come ho appena detto – del disegno molto ambizioso di donare all’Italia una nuova legge urbanistica dopo quella che fra mille difficoltà Gorla riuscì nel 1942 a strappare a un distratto, ma comunque renitente Mussolini.
In sintesi, il primo sintagma («In vista di un riordino organico della disciplina di settore») è – a causa del suo orizzontale temporale che coincide con l’infinito – affatto privo di qualunque significato precettivo (se si esclude un vago sentore di ottimistica parenesi). E ciò, anche perché esso è svincolato da una previsione normativa; è lì – sembrerebbe – solo per tranquillizzare il lettore o il cittadino: quasi a dire che la normazione disegnata dalle parole successive ha sullo sfondo questo paesaggio, tanto agognato quanto illusorio.
Andiamo avanti. Incontriamo subito una seconda indicazione temporale: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Questa volta il termine è definito con precisione. E si riferisce a un non meglio definito atto o procedimento di coordinamento – da adottare «previa intesa in sede di Conferenza unificata» – fra «il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane», ordinato a individuare:
a) «i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione»,
b) «gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia».
Privo di una qualificazione espressa come perentorio, con annessa sanzione in caso d’inosservanza (ma non si vede qual mai potrebbe essere), anche questo secondo momento di regolazione quoad tempus resta esiliato in un limbo d’irrilevanza giuridica.
O sembrerebbe tale, cioè irrilevante. Invece quel termine gioca un ruolo fondamentale proprio perché ordinatorio. Intendiamoci bene.
Devo fare qui una precisazione. Dalle mie considerazioni precedenti si comprende che ho letto l’inizio del comma («In vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge[…]») come se identificasse due termini diversi, riferiti a due attività o atti diversi. Il primo è un (non) termine onirico/ottativo («in vista di»), e sembra appunto riferirsi al grande sogno dell’urbanistica italiana, cioè all’avvento della nuova legge organica. Il secondo è invece un termine realistico/ordinatorio («entro sei mesi») esi riferisce – sempre nell’opinabile mia lettura – a qualcosa di diverso: cioè al più modesto obiettivo dell’atto di coordinamento in tema di pianificazione attuativa e di ristrutturazione edilizia.
La sostanziale ineffettività dei due termini farebbe ritenere inutile il distinguo che ho appena articolato. Ma non è così.
Riferito a un qualunque atto giuridico, un termine ordinatorio è di regola irrilevante: la sua violazione non genera infatti effetti giuridici specifici, consentendo che l’atto sia posto in essere anche dopo la scadenza.
Tutto cambia, però, nel caso in cui vi sia una norma che limita la durata di un determinato istituto o regime giuridico sino al compimento di quell’atto sottoposto a un termine ordinatorio. Il risultato è chiaro: quell’istituto o regime giuridico avrà una durata tendenzialmente sine die. Allo stesso modo, anzi a fortiori, se l’utilizzabilità di quell’istituto o regime giuridico è sottoposta a un termine ottativo («in vista di»).
È questo, in realtà, lo schema su cui è costruita la p.d.l. Ovviamente ci tornerò commentando i commi successivi al primo.
Tocca ora al quid faciendum, all’oggetto cioè della previsione. Semplicemente – il punto ormai è un topos fra i commentatori – quel quid non c’è, o meglio è giuridicamente impossibile. Poiché le norme in esame concernono il governo del territorio, la competenza regolativa (ovviamente intrasferibile) spetterebbe anzitutto – in sede concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. – solo al Parlamento (per la definizione dei principî fondamentali) e alle Regioni. Ma la definizione qualificatoria degli interventi edilizi rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Non è facile comprendere, pertanto, quale spazio possa avere qui un atto di coordinamento, e quale ruolo possano giocare Regioni, Province e Comunità montane.
Ancora. Il comma ha un inciso: «nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale». Tralasciamo la scelta lessicale incentrata sulla nazione invece che sullo Stato. Cosa sono di preciso questi «vincoli» nel cui «ambito» – si noti bene – la normazione de qua deve restare?
La risposta deve partire da un presupposto: non cercare nell’inciso in commento una precisione terminologica troppo elevata. Lo abbiamo appena fatto con il sintagma «normativa nazionale»; lo rifacciamo – per coerenza di metodo – col lemma «vincoli». La p.d.l. non si riferisce certo ai vincoli urbanistici, pena l’immediata perdita di senso dell’inciso. Allargandone l’area semantica, possiamo arrivare al risultato interpretativo secondo cui questi misteriosi vincoli altro non sarebbero – versando in materia a potestà ripartita – che i principi fondamentali della materia «governo del territorio». Se così fosse, il comma 1 prevedrebbe, in sostanza, che un qualche soggetto pubblico (non si sa bene chi, ma non quelli incaricati dalla norma, atteso il loro palese difetto di competenza: lo abbiamo appena visto) dovrebbe individuare «i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione» e «gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia». Ma dovrebbe fare tutto ciò – ecco il punto – senza assolutamente permettersi di modificare i principi fondamentali vigenti con riguardo ai due profili appena citati. Purtroppo per la p.d.l., sta di fatto che questi principi fondamentali sono a maglie così strette da non permettere neppure una legislazione per così dire interstiziale, cioè di loro completamento in adminiculis .
Si tratta, infatti:
– per quanto riguarda «i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione», dell’art. 41-quinquies, comma 6, l. n. 1150/’42 e dell’art. 8, d.m. 1444/’68; siamo addirittura al cospetto del primo Lep di cui si sia dotato l’ordinamento italiano, come ribadito dal Clep proprio su espressa mia richiesta, formulata all’interno del relativo sottogruppo n. 6 (chiamato appunto a identificare i Lep nella materia «governo del territorio»).
– per ciò che concerne poi «gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia», dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/’01: il cui contenuto, come noto, non trova pace testuale proprio nel tentativo di pervenire a una perimetrazione definitoria sempre più precisa.
Non v’è dunque nulla da regolare, perché nell’«ambito» in questione non vi sono spazi vuoti.
A meno che – il dubbio è forse malizioso – la ratio della norma sia un’altra: non quella (ontologicamente impossibile) di dettagliare i principi fondamentali nei due settori della pianificazione attuativa e della ristrutturazione edilizia, ma di cambiarli. Se è così, lo capiremo dall’analisi dei commi successivi. Anticipo le conclusioni: la risposta è affermativa, poiché l’obbiettivo della p.d.l., come desumibile dall’analisi complessiva di tutti i commi di cui è composta, è quello di modificare i principi fondamentali desumibili sino a oggi. E ciò, anche se – visto come è scritta la norma – non è possibile modificare i principi fondamentali rimanendo, contraddittoriamente, nel loro ambito.
Questo comma primo finisce come è iniziato: oniricamente, fra Leopardi e Foscolo. Agli interminati spazi che – come dice in apertura il comma – ci separano dalla nuova legge organica (il «riordino organico della disciplina di settore») corrisponde, in chiusura, il catalogo delle magnifiche sorti e progressive perseguende dai suddetti coordinanti. E il comma non pecca certo di poca ambizione, nel disegnarle: «attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.».
Chiusa l’analisi testuale del comma, proviamo a distillarne il senso.
Il compito non è arduo, in realtà.
Raccogliamole, quelle gocce:
-
si conferma l’attesa messianica della nuova legge urbanistica; qui la rilevanza normativa è ovviamente nulla;
-
si stabilisce che si proceda a un atto di coordinamento, ma entro un termine brevissimo (sei mesi) e comunque ordinatorio;
-
qui occorre fare attenzione: la rilevanza normativa è nulla quanto al raggiungimento effettivo dell’obbiettivo (riordino della disciplina di settore e coordinamento entro il termine ordinatorio di sei mesi); ma, al contrario, è notevolissima se all’ effettivo avvento della nuova legge organica o al compimento dell’atto di coordinamento – non soggetti in pratica ad alcun termine, quindi differibili ad infinitum – la normazione collega la durata di un istituto o regime giuridico;
-
l’atto di coordinamento è impossibile soggettivamente per incompetenza assoluta delle figurae pubbliche che dovrebbero farlo;
-
l’atto di coordinamento è impossibile oggettivamente perché la normazione su cui esso deve “incidere” precisandone i contenuti è già molto dettagliata;
-
si può quindi ipotizzare che scopo reale dell’atto di coordinamento sia non precisare, ma modificare quei contenuti.
3. Il comma 2 della p.d.l. 1987. Eccesso di discrezionalità applicativa e rischio di inattuazione per burocrazia difensiva. – Passiamo al comma 2. Lo riporto, sempre per comodità di lettura.
« 2. Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, di cui all’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all’articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, fatti salvi quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, nei seguenti casi:
a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati;
b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. ».
Iniziamo l’analisi testuale.
Anzitutto, è importante il dato di “sbarramento” temporale indicato in apertura: «Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo».
Il comma concerne quindi sia interventi (già) realizzati, sia (soltanto) assentiti.
La normazione racchiusa nel comma, e che esamineremo, regola entrambe le categorie di interventi (cioè quelli già realizzati e quelli soltanto assentiti) «fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo».
Richiamate le osservazioni relative al comma 1, è necessario identificare la data sino alla quale la regolazione del comma 2 resterà applicabile. Questione purtroppo semplice, credo.
Dal punto di vista strettamente letterale la disposizione in esame, sul punto, è poco chiara: lo “sbarramento” temporale si riferisce all’avvento della nuova legge urbanistica o – con laicità più sobria– all’atto di coordinamento?
Confrontiamo in modo ravvicinato cosa dicono sul punto i due commi. Comma 1: «In vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge[…]». Comma 2: «Sino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1».
Il comma 2 potrebbe riferirsi alternativamente a entrambi i “momenti” del comma 1 (alla legge organica o all’atto di coordinamento), poiché ne mischia le parole.
Ritengo sinceramente che la scarsa precisione con cui è scritto il comma (e la p.d.l. in generale) non meriti uno sforzo esegetico particolare, anche perché il risultato non cambierebbe, in concreto, di molto. Che questo “sbarramento” si produca con l’arrivo della nuova legge organica o dell’atto di coordinamento, l’effetto non cambia: i due eventi sono comunque incertissimi an et quando, certa essendo solo la grande distanza che ci separa dallo “sbarramento”.
Alle corte. Qui – a seconda delle scelte esegetiche – o lo “sbarramento” (la nuova legge urbanistica) non arriverà mai ovvero fra molto, troppo tempo; o arriverà quando si farà l’atto di coordinamento, che però – come ho detto – è impossibile ratione subiecti atque obiecti: e così ricadiamo nel primo caso.
Ne deriva che non esiste nessuno “sbarramento” temporale; e che – conseguenza ultima e fondamentale – l’esaminanda normazione racchiusa nel comma 2, nel regolare gli interventi già realizzati e quelli soltanto assentiti, si applicherà sostanzialmente ad infinitum.
Siamo in somma di fronte a una regolazione ordinaria, stabile e a regime, sebbene qualificata come straordinaria, eccezionale e temporanea.
È venuto il momento di esaminare questa regolazione.
Riguarda gli interventi – con indice superiore a 3 mc/mq o altezza superiore a 25 metri – che i Comuni hanno assentito o che sono già stati realizzati, in via diretta, cioè in assenza del necessario piano attuativo : violando quindi l’art. 41-quinquies, comma 6, l. urb. e l’art. 8, d.m. n. 1444/’68 .
Il comma in esame qualifica costitutivamente questi interventi come «conformi alla disciplina urbanistica» alle condizioni che esaminerò qui di seguito.
La ratio è dichiarata nella relazione alla p.d.l.: sovrapporre una fonte di diritto legislativo all’attuale diritto giurisprudenziale, che non è univoco circa la possibilità di procedere in via diretta ove l’area interessata dall’intervento sia già urbanizzata (come dimostrano i casi milanesi).
Il baricentro della p.d.l. sta dunque nell’analisi dei casi (disciplinati nello stesso comma 2) in cui è possibile beneficiare di questa trasformazione alchemica e postuma di conformità, e in presenza di quali condizioni (regolate nel comma 3).
Cominciamo con l’analisi dei casi, che sono in tutto tre.
-
«edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati».
Il perimetro applicativo della norma è molto incerto. Cosa vuol dire precisamente il sintagma «ambiti edificati e urbanizzati»? Chi decide – assumendosene la responsabilità pesantissima – e in base a quali criteri che questo o quell’ambito ha caratteristiche siffatte? L’estrema vaghezza di questa disposizione provoca un effetto paradossale: attribuisce sì una grande discrezionalità all’organo dell’applicazione (un ufficio tecnico comunale); ma proprio l’eccessività di quel potere – e la mancanza di una “guida” interpretativa sempre di rango primario – potrebbe condurre ad atteggiamenti burocraticamente difensivistici, che vanificherebbero la larghezza improvvida delle maglie con cui essa è stata scritta.
-
«sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata».
Mentre la lett. a) parla – come abbiamo appena visto – di interventi in imprecisati «ambiti edificati e urbanizzati», la lett. b) regola le trasformazioni in «ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata». La situazione è – se possibile – ancora peggiore; e maggiore è il rischio che in questo modo si addossa sugli organi dell’applicazione: qui i concetti imprecisi sono addirittura aumentati rispetto alla lett. a), passando da due («edificati»e «urbanizzati») a tre («urbana»,«definita»e«urbanizzata»). Richiamo quindi le considerazioni già fatte sopra, sottolineando le perplessità maggioriche la disposizione desta.
-
«interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni».
Il caso è identico a quello sub b) (entrambi si riferiscono a interventi in «ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata») quanto al perimetro applicativo. Le perplessità sono dunque le stesse.
Quanto alla tipologia degli interventi presi in considerazione dal comma, i tre «casi» coprono – ovviamente – la totalità delle ipotesi configurabili: a) «edificazione di nuovi immobili»; b) «sostituzione di edifici esistenti»; c) «interventi su edifici esistenti».
In sintesi, tutti e tre i «casi» non sono tipizzabili per eccessiva indeterminatezza delle relative previsioni. Il disegno a maglie larghe è stato voluto dall’estensore della p.d.l., proprio per comprendere all’interno dei tre «casi» il maggior numero possibile di fattispecie concrete: siano esse già assentite, o già assentite e realizzate, o assentite in futuro senza orizzonti temporali prevedibili (ma di certo non ravvicinati). Proprio questa strategia regolativa “omnicomprensiva”, però, rischia di ritorcersi contro la stessa ratio della previsione, poiché scarica sull’organo dell’applicazione l’intera responsabilità della tipizzazione: onde il probabile verificarsi di atteggiamenti difensivi, già largamente in atto nel «caso Milano», che di questa esperienza di normazione è l’occasio proxima.
4. Il comma 3. Conformità o mera compatibilità degli interventi? Verso un vieto condono discrezionale. – Vediamo adesso se il comma 3, che ci accingiamo ad analizzare, diminuisce il “tasso” di discrezionalità circolante nei tre «casi» che alimentano l’ecosistema della p.d.l., o se invece prosegue lungo lo stesso canone. Ecco il testo.
«3 . La conformità alla disciplina urbanistica nei casi di cui al comma 2 è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario ».
Come si vede, i tre «casi» alternativi regolati (a maglie larghissime, lo ripeto) nel comma 2 sono sottoposti a due «condizioni» di applicabilità.
Partiamo dalla prima, di cui alla lett. a):
«a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali».
Faccio subito due rilievi, che corrispondono – è evidente – ad altrettanti concetti giuridicamente indeterminati: «adeguatezza» e «sulla base». Possiamo tuttavia esaminarli congiuntamente, visto che nella struttura linguistico-performativa della disposizione costituiscono un unico sintagma: « adeguatezza […] sulla base».
Incontriamo subito una palese contradictio in terminis. Questo comma 3 – come il comma 2 – usa il concetto tecnico di conformità: cioè di stretta sovrapponibilità a un determinato parametro di riferimento, a sua volta idoneo – per la sua almeno tendenziale oggettività – a generare una valutazione il più possibile priva di margini di discrezionalità o addirittura di arbitrio. Ma il modello concretamente utilizzato dai commi 2 e 3 non è affatto quello del giudizio di conformità, bensì quello di mera compatibilità.
Non richiedendo infatti – al di là delle parole impiegate – una precisa “conformità”, ma solo una assai più blanda « adeguatezza […] sulla base», la disposizione non impegna affatto l’organo dell’applicazione a una verifica – come appena detto – di stretta sovrapponibilità, ma solo di larga compatibilità del manufatto assentito (o già realizzato) rispetto a un parametro astratto. Credo sia qui sufficiente, pertanto, richiamare le considerazioni che ho fatto circa l’amplissima discrezionalità che connota i tre «casi» del comma 2 con i consequenziali rischi di burocrazia difensiva.
La «condizione» in esame, inoltre, contiene un terzo concetto indeterminato: «dotazioni». Non è chiaro a cosa la disposizione intenda riferirsi. Possiamo sì, genericamente, intuire che si tratti della c.d. città pubblica, cioè dell’insieme dei servizi per la residenza nelle sue plurime concretizzazioni (opere di urbanizzazione primarie e secondarie). Ma quella parola, da sé, non restituisce nessun significato preciso che possa fungere da guida applicativa all’operatore: in tal modo ulteriormente caricato di responsabilità, e dunque ancor più desideroso di fuggirla (o di fuggire lui stesso, come non casualmente pare stia accadendo a Milano).
Ha una sua ragion d’essere strategica, questa sin troppo evidente contradictio fra giudizio di conformità (letterale) e vaga compatibilità (sostanziale)? Forse è la stessa che connota tutta la normazione dei commi 1-3: perseguendo l’obiettivo principale di far uscire gli interventi già realizzati dallo stato illegittimo in cui oggi versano, essa discorre di conformità per far – diciamo così – risuonare nel modello normativo il senso di una assentibilità oggettiva – sia pur accertata post factum – degli interventi che ne beneficeranno. Detto in sintesi: si presenta come accertamento di conformità ( ad instar del modello ex art. 36, d.P.R. n. 380/’01) ciò che, in realtà, mi appare un condono discrezionale. Strada, quest’ultima, sbarrata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Esaminiamo adesso il parametro sulla cui «base» la norma prescrive che si faccia questa evanescente verifica di «adeguatezza» delle «dotazioni territoriali»: sono la «legislazione regionale»e «gli strumenti urbanistici comunali».
Come pure si vede chiaramente, la disposizione utilizza come parametro non la normazione statale, ma solo «la «legislazione regionale»e «gli strumenti urbanistici comunali». Il motivo parrebbe chiaro. Gli interventi in questione sono per definizione non conformi al livello regolativo statale (cioè all’art. 41-quinquies, comma 6, l. urb. e l’art. 8, d.m. n. 1444/’68), tanto che la p.d.l. ha proprio la funzione di farli divenire conformi (al ricorrere delle «condizioni» che sto esaminando). In sintesi, la legittimazione di questi manufatti avviene prendendo in considerazione (nel senso latissimo già detto) soltanto i livelli regolativi “inferiori”: quello delle leggi regionali e quello degli strumenti comunali. Il che significa, detto diversamente, che i due livelli regolativi regionale e comunale contengono – o comunque possono contenere – norme derogatorie rispetto al livello statale.
5. Il cuore della vicenda: la sgradita inderogabilità degli standard. – Giunti a questo punto preciso, si entra direttamente in una questione ben nota: la derogabilità del d.m. 1444/’68 da parte delle leggi regionali (e, in via discendente, dagli strumenti comunali): per essere più espliciti, l’inaccettabile frammentazione regionalista degli standard.
Riavvolgiamo il nastro. Standard è stendardo, vessillo; dunque simbolo. Nel nostro caso, simbolo di civiltà, lemma nobilissimo che ha lo stesso etimo di città: è l’unico corpus normativo ante litteram sui LEP di cui l’Italia – come detto – sia riuscita a dotarsi; peraltro conquistandolo con grande fatica, e con ancora maggiore difendendolo da spinte abolizioniste o comunque riduzioniste non assenti nel Comitato per l’individuazione dei LEP (il CLEP: quale componente di quel Comitato e del relativo sottogruppo adibito all’individuazione dei livelli essenziali nel governo del territorio, mi permetto di imputarmene una sia pur minuscola parte di merito difensivo). Anche il testo di riforma che il Gruppo di lavoro ministeriale presieduto da Costanza Pera ha elaborato nel luglio 2019 non ha purtroppo avuto molto seguito, pur essendo gli standard – dice giustamente la relazione d’accompagnamento – «una garanzia cruciale per la messa in opera di diritti fondamentali dei cittadini».
Gli standard non furono – come non sono adesso – una semplice e algida giuridificazione dell’idea di città mediante l’uso di indici numerici. Furono invece – e sono ancora – molto di più. Tutti sanno, infatti, che per conquistare quella regolazione bisognerà attendere – cosa tipicamente italiana – le disgrazie di Firenze e di Agrigento. Si arrivò così alla (peraltro ambiguissima: ricordiamoci sempre il disastroso anno di moratoria) legge ponte n. 765/’67 e – per essa – ai nostri preziosi standard sessantotteschi. Ma non possiamo dimenticare il contesto specifico nel quale nacquero, perché esso ha ancora molto da insegnarci, con i suoi tanti caveas. Uno di essi ci viene da Carlo Odorisio, che rappresentava l’ANCE all’interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove si svolse in quell’anno la discussione sui contenuti dell’articolato: «la finalità della “legge ponte” fu quella di far compiere al Paese un vero salto di qualità nella gestione urbanistica attraverso una grande promozione dei p.r.g., ma in un clima di sostanziale sfiducia nei confronti degli enti locali.[…]È facile quindi comprendere il significato che ebbe allora il decreto sugli standard e anche i modi della sua formulazione: uno strumento semplice, con delle regole generalizzate che potessero garantire almeno alcuni elementi di base per una corretta redazione degli strumenti urbanistici, nella convinzione che non ci si potesse fidare più di tanto degli enti locali». Gli standard del 1969, in somma, sono un patrimonio tecnico-culturale dell’Italia migliore, dove hanno dialogato in modo fecondo ed equilibrato la logica della tutela e lo spirito del profitto.
Anche la scientia iuris ha fatto pienamente il suo dovere, proteggendo quello scarno, semplice articolato e – con esso – le speranze di una vita più dignitosa a favore delle classi più deboli : le quali confidano di necessità non negli spazi privati, ma nei servizi offerti dalla città pubblica. Tutte le alte Corti italiane si sono infatti inventate – à la Paolo Grossi – la natura legislativa del d.m. n. 1444/’68 proprio al fine di proteggerlo dagli attacchi che da più parti gli sono stati mossi. Il motivo è nobile: una normazione di rango assolutamente primario nel sistema socio-economico italiano richiedeva altrettale collocazione anche nel sistema delle fonti; che però è poco disponibile – almeno stando alle regole che lo disciplinano – ad accogliere un decreto ministeriale sul gradino più alto dell’ordinamento in senso formale (in disparte ovviamente le norme costituzionali).
Vi ha anzitutto provveduto la Consulta (fra le tante, la sent. 24 febbraio 2017, n. 41) che ha attribuito al d.m. del 1968 «efficacia precettiva e inderogabile» in quanto richiamato dall’art. 41- quinquies della legge ponte. Secondo la Cassazione, poi (Cass., II, 27 marzo 2001, n. 4113), la normazione regolamentare in esame «ha efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato il decreto che la contiene su delega della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150»; e ancora: « l’accertata efficacia legislativa del decreto ministeriale obbliga i Comuni a redigere e revisionare gli strumenti urbanistici senza discostarsi dalle regole inderogabili da esso fissate, perché l’autonomia normativa loro conferita dall’art. 33 della menzionata legge nella materia edilizia e, in particolare, in quella delle distanze tra fabbricati, incontra un limite insuperabile nell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale una norma regolamentare locale non può apportare modifiche a norme di rango superiore. E lo stesso art. 33, nell’attribuire ai Comuni il potere regolamentare, stabilisce che esso deve essere esercitato “in armonia con le disposizioni della presente legge”, il che comporta, da parte di tali Enti, anche l'osservanza dell’art. 9 del decreto ministeriale del 1968 il quale, per quel che si è detto, trae la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies della medesima legge ».
Possiamo adesso vedere più da vicino i fronti dell’attacco che le Regioni hanno mosso avverso il decreto n. 1444/’68.
La prima offensiva ha mirato alle distanze minime fra gli immobili: profilo – come vedremo analizzando il comma 3, lett. b), della p.d.l. – che per noi ha un rilievo particolare.
La Consulta ha saputo resistere molto bene, elaborando la nota ed elegante tesi della doppia valenza: le norme sulle distanze che regolano rapporti interprivati concernono l’ordinamento civile e quindi ricadono nella competenza esclusiva statale; se si esce, invece, dalle relazioni puntuali interdominicali e si attinge il livello pianificatorio (ancorché le figurae in concreto scelte non siano i classici piani di lottizzazione o piani particolareggiati, ma siano invece atipiche), si versa nel campo del governo del territorio, onde la competenza concorrente fra Stato e Regioni, le quali possono derogare alle distanze minime stabilite dalle norme statali. In quest’ultimo caso, la compresenza regolativa dei due soggetti pubblici pone il problema di individuare il criterio onde scrutinare la legittimità o meno di una specifica scelta regionale derogatoria. La Consulta ha individuato il «punto di equilibrio» nell’art. 9, ultimo comma, d.m. n. 1444/’68 (secondo cui «Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.»). È ancora C. cost. n. 41/’17, cit., a parlare: «la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968)». Ribadendo la vigenza del principio di pianificazione anche in tema di distanze (tranne che nei rapporti meramente privatistici fra immobili finitimi), la Corte ha dunque reso un cattivo servizio agli interessi che vorrebbero trasformare il territorio senza subire vincoli di piano, e dunque senza troppi obblighi di reperimento di standard.
Prima di proseguire, però, devo sottolineare ancora una volta un punto che si rivelerà centrale: sin qui l’aggressione (sventata) al decreto n. 1444/’68 aveva avuto come obbiettivo soltanto le norme, ivi racchiuse, in tema di distanze . Nel 2013 l’attacco ha riguardato la materia degli standard con riguardo alle quantità minime di spazi pubblici da assicurare in sede di pianificazione comunale. La norma che ha veicolato l’attacco è – come noto – l’art. 2-bis, d.P.R. n. 380/’01 (introdotto dalla l. n. 98/’13, che ha convertito il d.l. n. 69/’13, c.d. decreto “del fare”). Ecco il testo:
«Art. 2-bis. (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. ».
Il senso della disposizione è abbastanza chiaro. L’articolo mira non a uno, ma a due risultati.
Il primo. Facendo – ovviamente – salva la competenza statale nella regolazione delle distanze ove si tratti di meri rapporti interdominicali, esso non fa che recepire e legificare la giurisprudenza costituzionale che abbiamo ricordato più sopra ( i.e. la sentenza n. 41/’17 etc. ). Sin qui, nulla di particolarmente rilevante. Anzi, potremmo persino esprimere un apprezzamento positivo nei confronti di una norma che mette fine alla necessità di quella Wertjurisprudenzprovvidamente contra legem che aveva elevato il d.m. n. 1444/’68 a norma di rango primario-legislativo.
Ma si noti: l’art. 2- bis non “consolida” tutto il d.m. citato, ma soltanto le norme sulle distanze(come lette dalla Consulta). Quanto invece alla parte restante del d.m. (di gran lunga la più rilevante), l’art. 2- bis non solo non la protegge da interventi regionali derogatori, ma quelle deroghe espressamente consente (è questo il secondo dei due risultati cui accennavo). In altre parole, la disposizione in esame non garantisce affatto al d.m. un più elevato rango formale, ma lo abbandona invece a sé stesso proprio dove esso contiene le previsioni più qualificanti: quelle che per quarantacinque anni di storia italiana ne hanno fatto il segno di una speranza per un dignitoso Existenzminimum .
Superata in questo modo la barriera protettiva giurisprudenziale che – sia pur con comprensibili forzature teoretiche – aveva legificato il d.m. n. 1444/’68, le raffiche regionaliste (per usare una colorita e preveggente espressione di Concetto Marchesi in sede costituente) sono partite subito; la grande maggioranza delle Regioni ha regolato gli standard ponendosi in modalità do it by yourself o – se si preferisce un francesismo – à la carte.
Un dossierANCE del 2015 censiva, infatti, sette regioni che si erano avvalse dell’art. 2- bis e avevano quindi prodotto normazioni in deroga.
Lo stesso dossier, aggiornato al 2022, rilevava che il numero era salito a tredici. Numero – avvisava onestamente lo stesso dossier – che «non ha tenuto conto delle disposizioni regionali attuative dell’art. 2-bislegate all’applicazione dei Piani casa a carattere straordinario di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009»: non posso soffermarmi qui su quella esperienza urbanistica così negativa, la quale ha purtroppo dato un importante contributo in peius al grave processo di depianificazione che ancora affligge l’Italia; dico solo che anche quella normazione sul piano casa – figlia dichiarata dell’art. 2-bis, dunque intrisa di derogatorietà ( id est di eversività rispetto ai due fondamentali principî di pianificazione e di standardizzazione delle trasformazioni edilizie) – nacque sì come straordinaria, ma subito tese (e tende) protervamente a eternizzarsi (tra le tante, cito la l.r. Puglia n. 36/’23).
A riprova, poi, di quanto sia sempre in agguato il pericoloso piercing effect , ossia la crepa iniziale che poi fa crollare l’intera diga, è interessante soffermarsi un attimo sulla lettura dell’art. 2- bis offerta proprio dall’ANCE nel dossier 2022 appena ricordato.L’associazione dei costruttori aveva ritenuto che l’art. 2- bis peccasse di riduttivismo, poiché «[…] fin dalla sua entrata in vigore, ha fatto sorgere molti dubbi interpretativi perché la rubrica parla di deroghe in materia di distanza tra fabbricati, mentre il testo contiene un riferimento generico a “disposizioni derogatorie al DM 1444/68”. La norma inoltre lega le deroghe alla “definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”, senza un riferimento espresso alle fattispecie, potenzialmente rilevantissime, di intervento in diretta esecuzione del piano urbanistico generale. Le Regioni hanno inizialmente emanato norme ampie che consentivano deroghe sia alle distanze, che agli altri standard e limiti edilizi, e riguardavano sia interventi ricompresi in piani attuativi, sia interventi puntuali ossia su singoli edifici ». Purtroppo, però, la Consulta – prosegue rammaricato il dossier – ne ha censurate più d’una, proprio applicando la teoria della doppia valenza.
Tredici Regioni nel 2022, dice dunque il coevo dossier ANCE, hanno usato il grimaldello dell’art. 2- bis cit. per legiferare consentendo ai Comuni di derogare agli standard. Quel dossier, però, è stato ancora aggiornato pochi mesi fa, cioè il 10 aprile 2024. La situazione, adesso, è che – dalle sette del 2015 e dalle tredici del 2022 – le Regioni “deroganti” sono divenute ben diciassette: solo Molise, Sardegna e Valle d’Aosta non hanno – almeno sino a oggi – “approfittato” dell’art. 2-bis.
Come nel dossier 2022, anche in quello del 2024 si leggono considerazioni interessanti sulla norma appena citata, a cominciare dall’incipit: «Uno dei principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto delle disposizioni sugli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o per attività di interesse generale) ed edilizi (limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici) contenute nel DM 1444/1968. Gli interventi di “sostituzione edilizia” si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria, rende difficile il rispetto di limiti di densità, distanza o di altezza, così come il reperimento di aree da destinare a standard urbanistici.».
Sono verità innegabili: gli standard impediscono o comunque ostacolano, e senza alcun dubbio, «una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione». La questione vera nasce proprio qui, e ha forma di bivio: dobbiamo essere contrari a che gli standard si ergano come ultima e insuperabile barriera a una nuova densificazione edilizia senza servizi per la residenza? Oppure essere assai lieti di questa difesa estrema? Come ho già detto, il nostro d.m. contiene livelli essenziali delle prestazioni: come tali, inderogabili dalle Regioni. Ecco perché ritengo certamente giusto prendere atto della vetustà che affligge il d.m.: ma – attenzione! – non per depotenziarlo o (peggio) abrogarlo sic et simpliciter, ma per sostituirlo (senza spazi temporali vuoti di tutela) con un altro modello, più aggiornato.
Riconosco con piacere che – rispetto al dossier 2022 – il dossier 2024 parrebbe esprimere una posizione di ANCE assai più ragionevole; ascoltiamone quindi la chiusura: «Oggi, a seguito di numerose pronunce della giurisprudenza sia costituzionale (sentenze n. 178/2016, 231/2016, 41/2017, 217/2020) sia amministrativa (Consiglio di Stato, ord. 1949/2022, ord. 1431/2019) è prevalente una lettura restrittiva dell’art. 2-bis come finalizzato a consentire previsioni derogatorie al DM 1444/1968 solo se recepite in piani urbanistici attuativi funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio e non riguardanti anche interventi relativi a singoli edifici. L’orientamento restrittivo della giurisprudenza, le esigenze territoriali nascenti dai nuovi bisogni sociali ed economici e da ultimo anche la prospettiva della riforma costituzionale sull’autonomia regionale differenziata (art. 116 Cost.) confermano, a giudizio dell’Ance, l’urgenza di andare oltre la previsione di deroghe regionali, definendo una nuova disciplina degli standard urbanistici ed edilizi che, anche nell’ottica della riduzione del consumo di suolo, preveda regole specifiche per la rigenerazione urbana».
Sottolineo particolarmente questi concetti, che condivido pienamente: cioè «l’urgenza di andare oltre la previsione di deroghe regionali, definendo una nuova disciplina degli standard urbanistici ed edilizi che, anche nell’ottica della riduzione del consumo di suolo, preveda regole specifiche per la rigenerazione urbana».
Si noti: ANCE richiama – fra le altre – proprio una pronuncia che riguarda la Lombardia, e cioè l’art. 103, comma 1-bis, l.r. n. 12/’05 (rubricata «Legge per il governo del territorio»): «Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.».
Si tratta dell’ordinanza n. 1949/’22, resa dalla Sezione quarta del Consiglio di Stato, che – nel sollevare questione di legittimità costituzionale dei citati art. 2-bis, d.P.R. n. 380/’01 e art. 103, comma 1-bis, l.r. Lombardia n. 12/’05 – ha perfettamente illustrato la “pericolosità” di questo sistema normativo derogatorio. Sia pur non coronato da successo (con sentenza n. 85/’23 la Consulta l’ha infatti dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza), l’atto di promovimento merita il richiamo di alcuni suoi passi per la puntualità delle sue argomentazioni: «[…] la nuova disposizione statale introdotta nel 2013, intervenendo in materia di competenza concorrente senza porre alcun confine di principio al potere di deroga attribuito a tutte le regioni rispetto alle preesistenti norme statali, senza assolvere alla funzione propria attribuita dalla Costituzione allo Stato di individuare i principi, così rendendo certamente possibili legislazioni regionali molto diverse tra di loro, contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, andrebbe esplorato anche un altro possibile profilo di legittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, secondo comma Cost., attinente alle materie di competenza esclusiva dello Stato. Si tratta di valori costituzionali che […]sono oramai strettamente correlati alla materia del “governo del territorio”, quali la materia attinente alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”[117, secondo comma, lett. m)].[…]Può dunque ritenersi, posto che nella materia del governo del territorio le leggi regionali debbano rispettare le norme di principio della legislazione statale, che il nono comma dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942 esprima l’esigenza che le dotazioni di spazi pubblici, infrastrutture, servizi etc. rispondano a criteri di definizione omogenei su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esservi discrasie anche vistose tra Regione e Regione, in virtù dei diversi rapporti e parametri liberamente individuabili dalle diverse legislazioni regionali.[…] In definitiva, pur in un quadro costituzionale e legislativo caratterizzato dai principi di sussidiarietà verticale e di prossimità territoriale, in ragione dei quali la regolazione dell’assetto del territorio è rimessa quanto più possibile ai livelli di governo più vicini alle comunità di riferimento, deve ritenersi che la determinazione delle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse generale resti riservata al legislatore statale, in quanto ragionevolmente riconducibile all’ambito delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali; in tale prospettiva, al legislatore statale spetta non soltanto individuare i principi fondamentali della materia, sibbene fissare i livelli minimi delle predette prestazioni, rispetto ai quali le normative regionali potrebbero intervenire esclusivamente in senso “rafforzativo” ».
È questo, in definitiva, il quadro storico e normativo (aggiungo: assiologico) che si deve aver presente se si vuole comprendere la portata reale del parametro – cioè la «legislazione regionale»e «gli strumenti urbanistici comunali» – sulla cui «base» la lett. a) del comma 3 in esame stabilisce che l’Amministrazione comunale verifica l’«adeguatezza» delle «dotazioni territoriali» al fine di accertare «[l]a conformità alla disciplina urbanistica» del singolo intervento realizzato, assentito o da assentire (conformità tuttavia – lo ripeto – che è solo letterale, essendo invece sufficiente una mera e larga compatibilità).
Ne discende, ancora, un dubbio che investe la conformità a Costituzione del modello disegnato dai commi 2 e 3 della p.d.l.
In generale, ci si può domandare se quel modello rispetti i limiti che la Consulta riferisce all’esercizio della potestà legislativa: cioè – fra i tanti – la ragionevolezza e la proporzionalità.
In particolare, poi, credo necessario ricordare qui la giurisprudenza della Corte sulla derogabilità degli standard: la sentenza n. 142/’24, per esempio, ha pochi mesi fa affermato che «l’art. 2-bist.u. edilizia consente alle leggi regionali di prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968, ma esclusivamente “nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” e dunque “a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici (sentenza n. 217 del 2020)”». Secondo quella sentenza – si noti – è irrilevante la portata eccezionale ( i.e. straordinaria, temporanea) oppure stabile ( i.e. ordinaria, a regime) della normazione in deroga: «tali ristretti margini di derogabilità degli indici imposti dagli standard valgono in termini equivalenti tanto per la normativa eccezionale quanto, e a maggior ragione, per la normativa stabile.». In breve. La derogabilità degli standard deve comunque far salvo il principio di pianificazione, sebbene declinabile qui in modo “attenuato”: anche mediante utilizzo, cioè, del solo livello attuativo.
Due sono quindi i profili di rischio. Il primo, indiretto: poiché i commi 2 e 3 della p.d.l. fondano sull’art. 2-bis, la disposizione – nuovamente portata all’attenzione della Consulta, questa volta in una controversia dove essa sarà ritenuta rilevante (a differenza di quella decisa da C. cost. n. 85/’23, cit.) – potrebbe non superare il vaglio di quel giudice. Ne discenderebbe l’incostituzionalità derivata dei commi 2 e 3 della p.d.l. in esame. Il secondo rischio è invece diretto: penso a una sentenza della Consulta che – scrutinando la normazione della p.d.l. mediante i canoni espressi dalla sentenza n. 142/’24 cit. – la ritenga manifestamente eversiva del principio – pur se “attenuato”, come ho detto sopra – di pianificazione: perché mancano, cioè, gli strumenti di dettaglio.
6. La lett. b) del comma 3. La deroga alle distanze e la pianificazione attuativa. – Non ho ancora esaminato la lett. b) del comma 3, in base al quale la “conformità” alla disciplina urbanistica richiede anche il«rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario».
Per valutare la costituzionalità della disposizione credo sia comodo riportare il passo che ho citato più sopra – tratto da C. cost. n. 41/’17, cit. – onde usarlo come parametro di scrutinio: «la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968)».
Analizzo, per cominciare, il contenuto della lett. b), scomponendolo nelle sue parti costitutive.
Anzitutto, la disposizione concerne solo gli interventi di nuova costruzione. Ne deriva – a contrario – che tutte le demoricostruzioni sfuggirebbero a qualunque regola che stabilisca limiti distanziali: affido al lettore il commento sulla ragionevolezza (che è il principale criterio di vaglio circa la costituzionalità di una legge) di questa disposizione implicita.
Veniamo agli interventi di nuova costruzione. La lett. b) in esame impone il rispetto di una «distanza minima tra fabbricati»: non precisa però quale essa sia, per cui si può ritenere che si tratti dei tre metri previsti dal codice civile. Sin qui siamo nell’ovvietà. Ma la sostanza della disposizione è altrove: quella distanza minima – non meglio specificata – è derogabile se riguarda:
-
fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi;
-
fabbricati inseriti all’interno di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Poiché in entrambi i casi gli interventi sono collegati a una pianificazione di dettaglio (tipica o atipica che sia: sono le ipotesi appena viste rispettivamente sub 1 e sub 2), mi pare che la disposizione sia coerente con la giurisprudenza costituzionale (v. sempre C. cost. n. 41/’17, cit.).
Occorre però una puntualizzazione sulla portata temporale della parola «inseriti».
Nulla quaestio se essa è riferita a strumenti intermedi futuri : nel contesto, cioè, di un piano attuativo che – proprio in quanto formato ex novo – sia idoneo a evidenziare «una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario» (uso ancora una volta l’insegnamento di C. cost. n. 41/’17).
Molto più problematica, invece, è l’ipotesi della deroga distanziale chiesta per un intervento ricadente all’interno di un piano attuativo già esistente . Se non proprio preclusa per definizione, l’assentibilità del manufatto è soggetta a uno strettissimo e severo scrutinio, da motivare con particolare dovizia di indicazioni tecniche circa la sostenibilità di una trasformazione edilizia che comunque va ad alterare gli “equilibrî” interni ai «rapporti spazio-dimensionali e architettonici» (sempre C. cost. n. 41/’17) già puntualmente definiti da quel preesistente piano attuativo con riferimento a un assetto distanziale differente.
7. Il comma 4. Nuovi perimetri (e nuovi rischi d’incostituzionalità) della regolazione in materia di ristrutturazione edilizia. – Il comma 4 e Siamo così arrivati al comma 4, che affronta un altro tradizionale punctum crucis: il concetto di ristrutturazione edilizia.
Il testo:
«4. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei casi previsti dalla legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ».
Poiché la disposizione precisa di essere applicabile «fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo», si può subito osservare – per le considerazioni già fatte sopra – che essa è in realtà una regolazione per nulla provvisoria, ma invece usque ad infinitum, cioè sostanzialmente stabile o comunque di lunghissima durata.
Vediamone l’orografia.
Anzitutto – rivolgendosi anche al passato – la disposizione è anche una vera e propria sanatoria, della cui dubbia compatibilità con la giurisprudenza costituzionale ho già detto.
In secondo luogo, non è chiaro il concetto di «medesimo lotto di intervento»: è – secondo una lettura che mi convince – quello preso planivolumetricamente in considerazione per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione dei manufatti preesistenti e demoliti? Oppure, all’opposto, si intende l’area interessata dai nuovi interventi demoricostruttivi, la quale potrebbe essere più estesa e quindi tale da “somministrare” la cubatura maggiore, necessaria per legittimare ex post operazioni edilizi siffatte? Temo che il sintagma – letto nel sistema della disposizione – debba essere interpretato nel secondo senso. Mi induce a questa conclusione l’inciso – peraltro non molto chiaro, anche a causa del suo vocabolario tecnicamente poco nitido – «purché rispettino[…]il vincolo volumetrico previst[o] dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ». Poiché la disposizione – come detto – avrebbe durata indefinita, il modello demoricostruttivo ivi disegnato, nel suo riferimento al «vincolo volumetrico», servirebbe a “orientare” le future leggi regionali, e i prossimi piani comunali, affinché siano in qualche modo serventi all’operazione.
Terzo punto. Qualificando come ristrutturazione anche la realizzazione di «organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari», la disposizione intende risolvere l’ormai esploso contrasto giurisprudenziale – il quale taglia trasversalmente anche le due giurisdizioni, come dirò subito – sul regime delle demoricostruzioni che mutino la destinazione d’uso precedente (le «caratteristiche funzionali») e che siano comunque totalmente “infedeli” perché prescindono dal principio di continuità del nuovo rispetto al preesistente (« anche integralmente differenti »). Con una palese operazione di Wertjurisprudenz, infatti, la Cassazione penale ha creativamente introdotto (violando il fondamentale principio del nullum crimen, dunque giudicando contra legem ) quei due ulteriori requisiti intendendoli come costitutivi della figura demoricostruttiva (cfr. Cass. pen. n. 1669/’23 e n. 18044/’24); il giudice amministrativo territoriale s’è diviso: dalla parte della Cassazione c’è Tar Milano n. 2353/’24; contra, invece, si è schierato Tar Lecce n. 373/’24, il cui orientamento sarebbe dunque legificato dalla p.d.l.
L’ultimo punto è stato già trattato sopra. La proposizione «ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei casi previsti dalla legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali» crea spazi di discrezionalità non solo incontrollabili, ma anche capaci di ritorcersi sulla stessa possibilità di utilizzare in concreto la disposizione, in quanto probabile oggetto di burocrazia difensiva disapplicativa.
8. Il comma 5. Il provvedimento demolitivo o ripristinatorio. – Intorno al comma 5 («Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.»), segnalo la scarsa chiarezza del concetto di definitività. Probabilmente il proponente ha inteso riferirsi al diverso concetto di inoppugnabilità.
9. Il comma 6. Ancora sulla ristrutturazione. – Non mi è molto chiara, poi, la ratio del comma 6: «Resta ferma in ogni caso l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d), 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare un singolo organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un singolo organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.». È probabile che la p.d.l. abbia avvertito la necessità – inesistente, in realtà – di “avvisare” gli organi dell’applicazione circa la vigenza perdurante della disciplina per così dire “di base” in tema di ristrutturazione edilizia, come racchiusa nell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/’01: il comma 4, infatti, non fa che allargare il concetto di ristrutturazione edilizia.
10. Il comma 7 e la clausola di stile sui diritti dei terzi. – Possiamo tralasciare sia il comma 7 («L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.»), sia il comma 9 («Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»): la prima contiene una disposizione ovvia, la seconda di mero stile.
11. Il comma 8 e gli intricati rapporti della p.d.l. col codice Urbani. – Qualche parola merita, invece, il comma 8 («Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»). Non per la sua portata, che è evidente, ma per cercare di capire il perché della sua presenza.
Il precedente comma 4, in chiusura, dice: «Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». Sesto periodo che, a sua volta, stabilisce: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria». In sintesi, il comma 4 della p.d.l. conferma la vigenza dei limiti alla ristrutturazione nelle aree vincolate, come regolati dall’art. 3, comma 1, lett. d). Ma quest’ultima disposizione, a sua volta, è nuovamente tenuta ferma – come ho detto sopra – dal comma 6 della p.d.l. S’arriva poi al comma 8 che tiene ferma tutta la disciplina del d.lgs. n. 42/’04: preoccupazione abbastanza inutile, visto che quella normazione è autoprotetta ex art. 183, comma 6 («Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.»).
Un groviglio di cui non comprendo la ragion d’essere.
12.- Marcel Déat e la pianificazione standardizzata: per una via d’uscita giusta, effettiva e costituzionale. – Chiara invece è quella che anima l’intera p.d.l., prescindendo dalle smentite d’ufficio: legittimare il caso Milano.
Ma è questo il percorso giusto? Uso l’aggettivo in due sensi.
Il primo. Qui non si deve assolutamente ragionare come un novello Marcel Déat: al contrario, la nostra Danzica – cioè la pianificazione standardizzata – servanda est. Far morire quella conquista – tanto faticosa, quanto fondamentale – della nostra civiltà urbanistica per salvare una situazione – tanto contingente, quanto evitabile – mi sembra eccessivo. Ingiusto, appunto.
Secondo senso dell’aggettivo «giusto»: il percorso di legittimazione disegnato dalla p.d.l. raggiunge l’obiettivo che si prefigge?
Temo di no, per tutte le criticità che ho sin qui evidenziato: il modello generale della p.d.l. rischia di restare inapplicato a causa della burocrazia difensiva; o – se attuato – di esser travolto dalla Consulta, adìta da qualche giudice su prevedibilissima richiesta di qualche operoso p.m.
La via d’uscita non sembra quindi essere, almeno a mio avviso, quella che si traccia nella p.d.l., almeno nella sua stesura attuale.
Ipotizzo qui un’alternativa: se legge-provvedimento ha da essere, che sia cucita addosso a Milano. Evitiamo (è un’esortazione) l’attuale finzione di aver dettato nella p.d.l. una disciplina generale, col deprecabile risultato di mettere a repentaglio in tutta Italia il nostro sistema pianificatorio, già logoro e slabbrato di suo. Proviamo (altra esortazione), invece, a censire in modo più ravvicinato le casistiche milanesi: distinguendo – faccio solo un esempio – la fattispecie del condominio costruito nel cortile al posto del capannone abbandonato in plateale violazione delle distanze, da una parte; il palazzo di molti piani, dall’altra.
Lì mi parrebbe esserci una densificazione così “affollata” che sfugge – almeno di regola – a recuperi di sorta.
Qui, una pretermissione degli standard e della pianificazione attuativa che potrebbe forse essere giuridicizzata mediante un approccio tecnicamente molto dettagliato: predisponendo cioè, come allegato alla p.d.l., una tabella delle dotazioni territoriali minime tale da azzerare o almeno ridurre in modo molto importante il potere discrezionale degli uffici tecnici, così da “rasserenarli” nell’adozione dei consequenziali atti di permitting abilitativo.
Un cammino di crinale, lo so bene: però meno esposto a rischi rovinosi di ineffettività – per inapplicazione da burocrazia difensiva, o per annullamento costituzionale che sia – rispetto a quello dell’attuale p.d.l.
Un punto resti ben fermo: questo modello non deve valere per il futuro. Molto peggio, se sine die.



 Scarica la locandina
Scarica la locandina