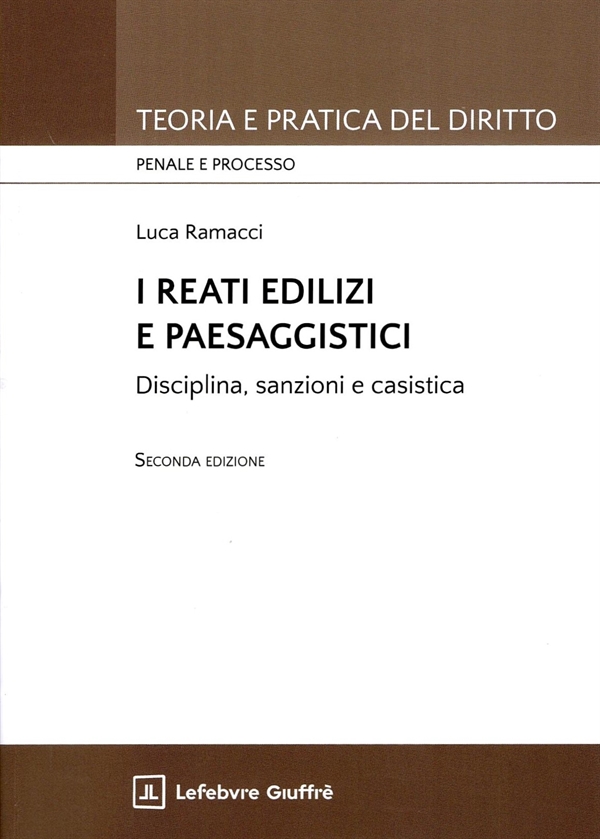Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 10 settembre 2025
Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 10 settembre 2025
« Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Attività connesse alla bioenergia – Biomassa forestale – Fabbricazione di prodotti chimici di base organici – Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Articolo 10 del regolamento 2020/852 – Attività di transizione – Soglia quantitativa – Elementi scientifici concludenti – Ciclo di vita – Principio di precauzione – Principio consistente nel non arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali – Articolo 17 del regolamento 2020/852 – Economia circolare – Acque e risorse marine – Inquinamento »
Nella causa T-579/22,
ClientEarth AISBL, con sede in Ixelles (Belgio), rappresentata da T. Johnston, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. von Rintelen, C. Auvret, G. Gattinara, R. Lindenthal e B. De Meester, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin e B. Fodda, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto da M. J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva, U. Öberg, P. Zilgalvis e E. Tichy-Fisslberger, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all'udienza del 21 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ClientEarth AISBL, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione Ares (2022) 4942150 della Commissione europea, del 6 luglio 2022, con la quale quest'ultima ha respinto la richiesta di riesame interno del suo regolamento delegato (UE) 2021/2139, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento agli stessi e se tale attività economica non arrechi un pregiudizio significativo ad alcuno degli altri obiettivi ambientali (GU 2021, L 442, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delegato»), per quanto riguarda taluni aspetti relativi alle attività economiche connesse alle bioenergie, alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base e alla fabbricazione di materie plastiche di base (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 La ricorrente è un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, che ha come obiettivo, in particolare, la tutela dell'ambiente.
3 Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione sulla base, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per la promozione di investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»).
4 Per aiutarla a elaborare criteri di valutazione tecnica per determinare se un'attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale, la Commissione ha istituito già nel 2018 un gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile. Per quanto riguarda il regolamento delegato, tale gruppo di esperti ha elaborato le sue raccomandazioni riguardanti, in particolare, i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività economiche che contribuirebbero sostanzialmente al conseguimento dei due obiettivi ambientali stabiliti all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento sulla tassonomia. La relazione finale del gruppo è stata pubblicata nel marzo 2020, accompagnata da un allegato tecnico.
5 Il progetto di regolamento delegato è stato accompagnato, da un lato, dal documento SWD (2021) 2800 final della Commissione, del 4 giugno 2021, contenente la motivazione di detto progetto e, dall'altro, dal documento SWD (2021) 152 final della Commissione, del 4 giugno 2021, preparato dalla direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, in collaborazione, in particolare, con la direzione generale Azione per il clima, contenente la relazione sulla valutazione d'impatto, corredata di undici allegati (in prosieguo: la «valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato»).
6 Il 3 febbraio 2022, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento delegato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). Essa contestava, in sostanza, la legittimità del regolamento delegato per quanto riguarda, in primo luogo, l'interpretazione e l'applicazione di taluni requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, in secondo luogo, talune attività economiche connesse alle bioenergie, in terzo luogo, la fabbricazione di prodotti chimici organici di base e, in quarto luogo, la fabbricazione di materie plastiche di base.
7 Con lettera del 6 luglio 2022, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, con la quale ha respinto la richiesta di riesame interno.
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
9 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
10 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su errori di diritto relativi ai requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico stabiliti all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, il secondo, su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda le attività connesse alle bioenergie, il terzo, su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici di base e, il quarto, su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base.
Considerazioni preliminari sul regolamento sulla tassonomia e sul regolamento delegato
11 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento sulla tassonomia stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Secondo il suo considerando 3, tale regolamento costituisce un passo fondamentale per orientare i flussi finanziari verso attività sostenibili al fine di pervenire a un'Unione europea neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.
12 A tal fine, il regolamento sulla tassonomia istituisce, come risulta dai suoi considerando 6 e 12, un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (denominato «tassonomia» o «tassinomia»), al fine di armonizzare a livello dell'Unione i criteri per determinare se un'attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale, il che offre agli investitori e agli altri operatori economici una comprensione comune delle attività economiche sostenibili sul piano ambientale.
13 Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia, «[a]i fini della determinazione del grado di sostenibilità ambientale di un investimento, un'attività economica è considerata sostenibile dal punto di vista ambientale se:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
c) (…); e
«d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, [e] dell'articolo 11, paragrafo 3».
14 I sei obiettivi ambientali elencati all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia sono i seguenti:
«a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un’economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi».
15 L’articolo 4 del regolamento sulla tassonomia prevede che gli Stati membri e l’Unione applicano i criteri stabiliti all’articolo 3 per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o per gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.
16 L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia stabilisce le condizioni alle quali un'attività economica è considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
17 La «mitigazione dei cambiamenti climatici» è definita all'articolo 2, punto 5, del regolamento sulla tassonomia come «il processo che consiste nel contenere l'aumento della temperatura media del pianeta ben al di sotto dei 2º C e nel proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5º C rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall'accordo di Parigi [sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015]».
18 L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia prevede le condizioni applicabili alle attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio realizzabili sul piano tecnologico ed economico, vale a dire le attività cosiddette "di transizione", ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), ii), di tale regolamento.
19 L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia prevede che la Commissione adotti un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento al fine di:
«a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e
b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi»
20 L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia stabilisce che un'attività economica è considerata un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici quando tale attività:
«a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi».
21 L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia prevede che la Commissione adotti un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento al fine di:
«a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e
b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi».
22 L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia così recita:
«Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:
i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione».
23 L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento:
«a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore;
e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
f) si basano su elementi scientifici concludenti e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 [TFUE];
g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, in particolare:
i) se si tratta di un’attività abilitante di cui all’articolo 16; o
ii) se si tratta di un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un’economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità (…)».
24 Il regolamento delegato è stato adottato sulla base, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia (v. punto 3 supra).
25 L'articolo 1 del regolamento delegato prevede che i criteri di vaglio tecnico per determinare le condizioni in cui un'attività economica può essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per determinare se tali attività arrechino un danno significativo a uno degli altri obiettivi ambientali sono stabiliti nell'allegato I di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento delegato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa ritenere che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrechi pregiudizio significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali sono stabiliti nell'allegato II del medesimo regolamento.
26 Gli allegati I e II del regolamento delegato precisano i criteri di vaglio tecnico per ciascuna attività economica oggetto di tale regolamento, in particolare al punto 3.14 per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base e al punto 3.17 per la fabbricazione di materie plastiche di base.
Considerazioni preliminari sulla richiesta di riesame interno e sulla portata del controllo del Tribunale
27 In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, qualsiasi organizzazione non governativa (ONG) che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento medesimo può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione dell’Unione che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale.
28 È inerente al sistema del riesame interno che chi richiede il riesame presenti motivi concreti e precisi idonei a rimettere in discussione le valutazioni sulle quali l'atto amministrativo è fondato (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 68). Pertanto, un siffatto soggetto che richiede il riesame è tenuto ad indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alla valutazione effettuata dall'istituzione o dall'organo dell'Unione nell'atto considerato (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C-82/17 P, EU:C:2019:719, punto 69, e del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione, C-458/19 P, EU:C:2021:802, punto 60).
29 La domanda di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire, conformemente all’articolo 12 del regolamento Aarhus, in combinato disposto con l’articolo 10 di tale regolamento, il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C 82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38).
30 In linea di principio, la portata del controllo giurisdizionale di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non differisce dalla portata del controllo giurisdizionale dell'atto amministrativo che è stato oggetto di detta domanda se tale atto dovesse essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T-177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punti 76 e 81).
31 Secondo la giurisprudenza, quando un'istituzione dell'Unione è chiamata ad effettuare valutazioni complesse, come quelle sottese all'elaborazione di criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se un'attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale, essa dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata). In tal caso, il controllo giurisdizionale che il giudice dell'Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di una decisione quale la decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, bensì a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da alcuno sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza citata).
32 A tal riguardo, secondo giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56, e giurisprudenza citata). Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57, e giurisprudenza citata.
33 Al fine di dimostrare che un'istituzione ha commesso un errore manifesto nella valutazione di fatti complessi tale da giustificare l'annullamento dell'atto da essa adottato, gli elementi di prova a sostegno di tale affermazione devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate in tale atto (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2018, Lubrizol France/Consiglio, C-223/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:442, punto 39, e del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C-148/19 P, EU:C:2020:354, punto 74).
34 È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente.
Sul primo motivo, vertente su errori di diritto per quanto riguarda i requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico stabiliti all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia
35 La ricorrente sostiene formalmente che «la Commissione non era competente ad adottare il regolamento delegato, in quanto [essa] ha ignorato elementi essenziali del regolamento [sulla tassonomia]». Tuttavia, come risulta dal ricorso e dalla sua risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, i suoi argomenti vertono non su un vizio di incompetenza propriamente detto, bensì su errori di diritto commessi dalla Commissione nell'interpretazione dei requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia.
36 Occorre quindi interpretare il presente motivo come vertente su errori di diritto per quanto riguarda i requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico stabiliti all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia.
37 II presente motivo si articola in quattro parti, relative:
– la prima, alla nozione di «prove scientifiche irrefutabili» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia;
– la seconda, alla ponderazione dei requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento;
– la terza, all'erronea presunzione che la normativa dell'Unione in vigore soddisfi i requisiti relativi alla tassonomia; nonché
– la quarta, all'obbligo di tener conto del ciclo di vita per quanto riguarda le attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base e di fabbricazione delle materie plastiche di base.
Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla nozione di «prove scientifiche irrefutabili» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia nonché all'applicazione del principio di precauzione
38 La ricorrente sostiene che, ai punti 1 e 2.1, lettere a) e b), dell'allegato II della decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha interpretato erroneamente la nozione di «prove scientifiche irrefutabili», di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, come corrispondente agli «elementi scientifici che consentono di trarre una conclusione», anziché farla corrispondere ai «migliori elementi disponibili» o agli «elementi scientifici più recenti e affidabili», ciò che ridurrebbe il requisito di tale criterio, in secondo luogo, essa ha omesso di riconoscere il rischio di «preclusione» delle attività che alla fine non contribuirebbero sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico, in terzo luogo, essa ha erroneamente sostenuto, da un lato, di essere legittimata ad ignorare i migliori elementi scientifici e più recenti in quanto il regolamento delegato era continuamente aggiornato e, dall'altro, di poter ritenere che la sua interpretazione richiedesse una «certezza epistemica» e, in quarto luogo, essa ha applicato erroneamente il principio di precauzione.
39 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
40 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico «si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 [TFUE]».
41 Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto, al punto 1 dell'allegato II della decisione impugnata, che la ricorrente non avesse sollevato una questione sulla portata della nozione di «prove scientifiche irrefutabili» quale motivo autonomo a sostegno della richiesta di riesame interno, ma unicamente come osservazione preliminare. Inoltre, essa ha ritenuto, in sostanza, che il significato letterale dell'espressione «prove scientifiche irrefutabili» facesse riferimento agli elementi scientifici che non erano «refutabili», vale a dire agli elementi scientifici che «consent[ivano] di trarre conclusioni». Inoltre, essa ha considerato che l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente sembrava richiedere prove scientifiche che erano indubbiamente accettate da tutta la comunità scientifica, il che sarebbe contrario alla natura stessa delle conoscenze scientifiche.
42 Nei limiti in cui, con la presente parte, la ricorrente critica l'interpretazione della Commissione sulla nozione di «prove scientifiche irrefutabili» e, in particolare, fa valere che la Commissione non ha preso in considerazione i «migliori elementi disponibili» o gli «elementi scientifici più recenti e affidabili», essa non spiega in che modo tale interpretazione comporterebbe un'illegittimità della decisione impugnata. Essa non menziona alcun elemento scientifico sul quale tale decisione si sarebbe basata, che avrebbe consentito di trarre una conclusione senza essere recente o affidabile. Inoltre, essa non individua alcun elemento scientifico «più recente» o «più affidabile» che sarebbe stato ignorato in detta decisione. Infine, essa non spiega perché ritiene che, nel caso di specie, gli «elementi scientifici che consentono di trarre una conclusione» non corrispondano ai «migliori elementi disponibili» o agli «elementi scientifici più recenti e affidabili».
43 Ne consegue che, anche supponendola fondata, la censura della ricorrente vertente su un errore di diritto nell'interpretazione dei termini «prove scientifiche irrefutabili» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia non è tale da condurre all'annullamento della decisione impugnata.
44 Neppure gli altri argomenti della ricorrente possono essere accolti. In primo luogo, il suo argomento secondo cui l'interpretazione dell'espressione «prove scientifiche irrefutabili», adottata dalla Commissione, conduce ad un rischio di «preclusione» e «di attivi non deteriorati» non è in alcun modo suffragata, in quanto la ricorrente si limita ad affermare, in modo molto generico, un rischio ipotetico che deriverebbe da una siffatta interpretazione.
45 In secondo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha ritenuto di poter ignorare i migliori elementi scientifici e i più recenti in quanto il regolamento delegato sarebbe regolarmente aggiornato si basa su una lettura erronea della decisione impugnata. Infatti, dal punto 1 dell'allegato II di tale decisione risulta che la Commissione invoca l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia unicamente per sostenere che un'interpretazione troppo restrittiva del requisito di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento rimetterebbe in discussione gli obiettivi di tale regolamento e, in particolare, priverebbe di qualsiasi effetto utile l'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, in quanto quest'ultima disposizione obbliga la Commissione a riesaminare regolarmente i criteri di vaglio tecnico in funzione del progresso scientifico e tecnologico.
46 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al principio di precauzione, occorre ricordare che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico siano fondati su elementi scientifici concludenti e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE. Inoltre, come risulta dal considerando 40 di detto regolamento, tale principio si applica «nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza».
47 Orbene, la ricorrente non spiega in che modo l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia adottata nella decisione impugnata violi il principio di precauzione. Infatti, essa sostiene unicamente, senza presentare il minimo elemento preciso al riguardo, che nel caso in cui non esistano prove scientifiche irrefutabili, alla Commissione sarebbe impedito di classificare una determinata attività ai sensi di detto regolamento.
48 In quarto luogo, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che la presa in considerazione di elementi scientifici che consentono di trarre una conclusione è incompatibile con la valutazione della loro qualità o attualità, essa non fornisce alcun esempio di elemento scientifico inaffidabile o non attuale utilizzato dalla Commissione.
49 Occorre pertanto respingere la prima parte del primo motivo.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla ponderazione dei requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia
50 La ricorrente fa valere che, ai punti 1 e 2.1, lettera a), i), e b), i), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nella sua interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, in quanto ha ritenuto che i diversi requisiti ivi previsti dovessero essere ponderati al fine di raggiungere un giusto equilibrio. A suo avviso, ciascuno di tali requisiti è tuttavia giuridicamente vincolante e la Commissione è tenuta a rispettarli tutti.
51 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
52 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia, la Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui, rispettivamente, al paragrafo 3 di detto articolo 10 e al paragrafo 3 di detto articolo 11 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 19 di detto regolamento, vale a dire quelle menzionate al precedente punto 23.
53 Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l'esigenza di prove scientifiche irrefutabili, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, dovesse essere bilanciata con gli altri criteri stabiliti in detto articolo, in particolare con il principio di precauzione (punto 1 dell'allegato II). Inoltre, per quanto riguarda le attività economiche connesse alle bioenergie, essa ha ritenuto in tale decisione che l'applicazione simultanea e cumulativa di tutti i requisiti di cui al suddetto articolo 19, paragrafo 1, al momento della fissazione dei criteri di vaglio tecnico le consentisse di calibrare il livello del contributo sostanziale di una determinata attività economica alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla luce, in particolare, delle prove scientifiche irrefutabili disponibili, della coerenza con la normativa dell'Unione e della fattibilità tecnologica e commerciale [punto 2.1, lettera b), di detto allegato].
54 Occorre anzitutto constatare che la ricorrente critica il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione si sia ritenuta legittimata a ponderare i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, ma non deduce alcun argomento concreto che faccia valere che una siffatta ponderazione avrebbe condotto a un risultato incompatibile con uno dei criteri stabiliti in tale disposizione.
55 Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, il cui testo è stato ricordato al precedente punto 23, enuncia una serie di requisiti che riguardano al contempo il contenuto dei criteri di vaglio tecnico [v., in particolare, il paragrafo 1, lettere a) e b)] e la forma che questi ultimi dovranno assumere [v., in particolare, il paragrafo 1, lettera c)]. Inoltre, tali criteri di vaglio tecnico devono tener conto di diversi fattori che perseguono obiettivi diversi, vale a dire, in particolare, obiettivi ambientali, scientifici, economici, finanziari e di fattibilità [v., in particolare, il suo paragrafo 1, lettere da g) a i) e k)]. Nello stesso senso, occorre constatare che i costi e i benefici potenziali dell'applicazione dei criteri di vaglio tecnico, nonché la facilità del loro utilizzo, fanno anch'essi parte degli elementi che la piattaforma sulla finanza sostenibile deve prendere in considerazione al momento di consigliare la Commissione su tali criteri di vaglio tecnico [v. articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e g), di tale regolamento].
56 Inoltre, la circostanza che la fissazione dei criteri di vaglio tecnico dipenda da una ponderazione di diversi interessi e obiettivi è ancora alla base dei considerando da 44 a 46 del regolamento sulla tassonomia, i quali indicano che la Commissione deve tener conto «delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi-benefici», delle «pertinenti disposizioni legislative del diritto dell'Unione» o di un qualsiasi «impatto negativo sui mercati finanziari».
57 Pertanto, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, spetta alla Commissione prendere in considerazione tutti i requisiti previsti dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, trovando, se del caso, l'equilibrio appropriato o una concordanza pratica tra di esse, tenuto conto della loro diversità di obiettivi e di natura e del fatto che essi non sono necessariamente convergenti tra loro.
58 Pertanto, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa all'erronea presunzione secondo cui la normativa dell'Unione in vigore soddisfa i requisiti relativi alla tassonomia
59 La ricorrente sostiene che, al punto 2.1, lettera b), i), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore di diritto basandosi unicamente sulla normativa dell'Unione in vigore, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82; in prosieguo: la «direttiva RED II»), e il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla considerazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 e la decisione (UE) n. 529/2013 (GU 2018, L 156, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento LULUCF»). Essa sostiene che detta normativa svolge funzioni diverse da quelle del regolamento sulla tassonomia e si basa su elementi scientifici obsoleti che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento. L'inadeguatezza di tale normativa sarebbe stata riconosciuta dalla Commissione stessa, in quanto essa avrebbe proposto diverse modifiche di tale normativa.
60 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
61 Nel caso di specie, occorre constatare che, al punto 2.1, lettera b), i), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione indica che, per stabilire i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alle bioenergie, essa ha preso in considerazione le disposizioni della direttiva RED II e del regolamento LULUCF. Secondo la Commissione, tali testi contenevano norme sulla sostenibilità delle bioenergie e sulla contabilizzazione del carbonio che includevano tutte le emissioni delle bioenergie e che miravano a garantire che tali emissioni fossero prese in considerazione a livello nazionale. In tal senso, il considerando 30 del regolamento delegato indicava che «i criteri di vaglio tecnico per la produzione di calore, raffreddamento ed elettricità a partire dalla bioenergia e per la produzione di biocarburanti e di biogas nel settore dei trasporti dovrebbero essere coerenti con il quadro generale di sostenibilità per tali settori stabilito dalla direttiva [RED II]».
62 In primo luogo, occorre osservare che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la Commissione tenga conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell'Unione in vigore». Tale obbligo è altresì menzionato ai considerando 43 e 44 di tale regolamento. Pertanto, quando la Commissione procede all'analisi degli elementi sui quali deve fondarsi l'adozione dei criteri di vaglio tecnico, essa deve tener conto di ogni pertinente strumento legislativo dell'Unione in vigore, come espressamente previsto all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e conformemente al suo compito di vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione, previsto all'articolo 17, paragrafo 1, TUE.
63 Pertanto, non si può contestare alla Commissione di aver tenuto conto della normativa dell'Unione in vigore al momento della fissazione dei criteri di vaglio tecnico. La Commissione afferma quindi giustamente, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione le disposizioni della direttiva RED II e del regolamento LULUCF.
64 In secondo luogo, l'argomento della ricorrente diretto a dimostrare che i criteri stabiliti nella direttiva RED II e nel regolamento LULUCF sono obsoleti e non sono sufficienti a soddisfare i requisiti del regolamento sulla tassonomia non può essere accolto.
65 In primo luogo, l'argomento della ricorrente relativo ad un'asserita anzianità della direttiva RED II e del regolamento LULUCF deve essere respinto. Da un lato, la data di adozione della normativa non è di per sé idonea a dimostrare una non conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento sulla tassonomia. Dall'altro lato, come fa valere la Commissione, i riferimenti ad altri strumenti legislativi nei criteri di vaglio tecnico devono essere interpretati nel senso che fanno riferimento alla loro versione in vigore più recente.
66 In secondo luogo, dall'articolo 1 della direttiva RED II risulta che quest'ultima definisce un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Essa stabilisce, in particolare, norme relative al sostegno finanziario a favore dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale elettricità e all'uso di energia da fonti rinnovabili in determinati settori. Essa definisce inoltre criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare per i combustibili da biomassa. Inoltre, dall’articolo 1 del regolamento LULUCF risulta che esso stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico approvato il 12 dicembre 2015 e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Detto regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.
67 Inoltre, occorre constatare che il regolamento sulla tassonomia rinvia espressamente alla direttiva RED II e indirettamente al regolamento LULUCF. In tal senso, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia prevede che si considera che un'attività economica contribuisca in misura sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, in particolare producendo, trasportando, immagazzinando, distribuendo o utilizzando energie rinnovabili ai sensi di detta direttiva. Inoltre, dal considerando 32 del regolamento sulla tassonomia risulta che l'espressione «gestione sostenibile delle foreste» deve essere intesa nel senso che tiene conto, in particolare, di tale direttiva e del regolamento LULUCF.
68 Inoltre, occorre rilevare che, per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire dalla biomassa forestale, i criteri LULUCF previsti all'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II e il regolamento LULUCF sono intrinsecamente connessi, poiché la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF è effettuata sulla base di tale regolamento.
69 Pertanto, la direttiva RED II e il regolamento LULUCF non possono essere considerati non pertinenti ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alle bioenergie.
70 In terzo luogo, non risulta dalla decisione impugnata che i criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato per le attività relative alla bioenergia si basino esclusivamente sui requisiti stabiliti, tra l'altro, dalla direttiva RED II. Al contrario, come sostiene la Commissione, tali criteri di vaglio tecnico prevedono requisiti diversi da quelli attualmente previsti dalla normativa in vigore, come dimostrano gli esempi riportati al punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II di tale decisione, non contestati su questo preciso punto dalla ricorrente, riguardanti, in particolare, l'introduzione di una soglia più elevata per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovuta all'uso della biomassa.
71 In quarto luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le proposte della Commissione per la revisione della direttiva RED II e del regolamento LULUCF non possono equivalere ad un riconoscimento da parte di quest'ultima dell'inadeguatezza delle loro disposizioni, nelle loro versioni in vigore alla data della decisione impugnata, ai fini di una presa in considerazione nella fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alle bioenergie.
72 Si deve pertanto respingere la terza parte del primo motivo.
Sulla quarta parte del primo motivo, relativa all'obbligo di tener conto del ciclo di vita per quanto riguarda le attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base e di fabbricazione delle materie plastiche di base
73 La ricorrente sostiene che, al punto 2.1, lettera a), i) e ii), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione ha violato il requisito di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico stabiliti per le attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base e di fabbricazione delle materie plastiche di base. La Commissione avrebbe adempiuto il suo obbligo di prendere in considerazione il ciclo di vita constatando che era difficile farlo e ritenendo che il ciclo di vita potesse essere successivamente preso in considerazione al momento delle modifiche di detti criteri. Tuttavia, detto articolo 19, paragrafo 1, lettera g), prevedrebbe un obbligo «di risultato», secondo il quale i criteri di vaglio tecnico non possono essere adottati senza incorporare i requisiti relativi al ciclo di vita. Tale obbligo di tener conto degli elementi del ciclo di vita spetterebbe alla Commissione e non agli operatori. Inoltre, i criteri di vaglio tecnico non possono essere resi legittimi a posteriori mediante modifiche che incorporano considerazioni legate al ciclo di vita.
74 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
75 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico «tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi». Tale constatazione risulta altresì dal considerando 34 del medesimo regolamento.
76 Inoltre, il considerando 40 del regolamento sulla tassonomia prevede che «all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, [la Commissione] dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili, siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente». Inoltre, il considerando 47 del medesimo regolamento indica che «[i] criteri di vaglio tecnico potrebbero richiedere un'analisi del ciclo di vita quando ciò sia sufficientemente pratico e necessario».
77 Nel caso di specie, al punto 2.1, lettera a), i), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione ha rinviato alla valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato, ha ritenuto che l'obbligo di tener conto del ciclo di vita fosse un obbligo di mezzi e ha ritenuto di soddisfare tale obbligo prendendo in considerazione l'analisi del ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra in generale e delle emissioni delle attività di fabbricazione in particolare, compresa la fabbricazione di prodotti chimici organici di base.
78 A tal riguardo, dalla valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato, parzialmente trascritta nella decisione impugnata, risulta che la Commissione ha ritenuto che, nonostante una riflessione approfondita, l'integrazione universale delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri di vaglio tecnico si rivelasse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili.
79 In particolare, per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, la valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato indicava che, data la mancanza di dati sufficienti per definire criteri di vaglio tecnico per l'intero ciclo di vita, sarebbe opportuno prendere in considerazione le emissioni dirette di gas a effetto serra risultanti dal processo di fabbricazione. A tal fine, la Commissione ha ritenuto che si debbano prendere in considerazione le industrie più efficienti del settore, utilizzando parametri di riferimento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra previsti dalla legislazione dell'Unione. A suo avviso, tale approccio consentiva di garantire che i criteri di vaglio tecnico fossero facili da utilizzare, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia.
80 Per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base, non essendo coperta da parametri di riferimento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione ha ritenuto che la definizione dei criteri per il vaglio tecnico si basasse su pareri di esperti, su un'analisi del ciclo di vita e su un'analisi documentale delle industrie più efficienti in tali settori. In particolare, era previsto che le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante l'intero ciclo di vita della fabbricazione di materie plastiche che utilizzano materie prime rinnovabili dovessero essere inferiori a quelle delle materie plastiche di base equivalenti fabbricate a partire da combustibili e materie prime fossili.
81 Per quanto riguarda sia la fabbricazione di prodotti chimici organici di base sia la fabbricazione di materie plastiche di base, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante l'intero ciclo di vita dovrebbero essere calcolate secondo le raccomandazioni della Commissione o delle norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) applicabili ed essere verificate da un terzo indipendente.
82 Inoltre, la Commissione ha ritenuto che avrebbe aggiornato i criteri di vaglio tecnico sulla base dei progressi tecnologici e scientifici al fine di integrare nuovi elementi legati al ciclo di vita delle attività. A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia, tale aggiornamento dovrebbe aver luogo ogni tre anni per quanto riguarda le attività di transizione, quali la fabbricazione di prodotti chimici organici di base e di materie plastiche di base.
83 Inoltre, la Commissione ha ritenuto, al punto 2.1, lettera a), ii), dell'allegato II della decisione impugnata, che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia le concedesse un certo margine di discrezionalità al fine di tener conto del ciclo di vita unitamente agli altri requisiti stabiliti da detto articolo 19, paragrafo 1. Tale potere discrezionale non la obbligava a fissare, nei criteri di vaglio tecnico, una soglia di emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita per tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento delegato. Conformemente al considerando 47 di detto regolamento, l'analisi del ciclo di vita doveva essere effettuata ove ciò fosse sufficientemente fattibile e necessario. Per quanto riguarda le attività di fabbricazione, la valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato mostrava che non esistevano soluzioni sostenibili e utilizzabili diverse da quella adottata, che tengano conto delle industrie più efficienti per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra risultanti dal processo di fabbricazione.
84 In primo luogo, risulta certamente dai precedenti punti da 78 a 83 che la Commissione ha sostenuto, nella decisione impugnata, che l'integrazione universale delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri di vaglio tecnico si rivelava difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili. Tuttavia, da tale decisione risulta altresì che, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico relativi alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base, la Commissione ha preso in considerazione le emissioni dirette di gas a effetto serra per il processo di fabbricazione e, in particolare, i parametri di riferimento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, conformemente alla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32). Inoltre, per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base, i criteri di vaglio tecnico si sono basati su pareri di esperti nonché su un'analisi del ciclo di vita e un'analisi documentale delle industrie più efficienti in tali settori.
85 In secondo luogo, occorre rilevare che, come sostenuto dalla Commissione, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con i considerando 34, 40 e 47 del regolamento sulla tassonomia (v. punti 75 e 76 supra), non richiede di prevedere criteri di vaglio tecnico vertenti specificamente sul ciclo di vita né obbliga la Commissione ad effettuare un'analisi del ciclo di vita in tutti i casi di specie. Ciò che è richiesto è che, al momento dell'adozione dei criteri di vaglio tecnico, la Commissione tenga conto del ciclo di vita, in particolare delle analisi di detto ciclo già esistenti.
86 Pertanto, nel caso di specie, non è dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto nella sua interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, esposta ai precedenti punti da 77 a 83.
87 In terzo luogo, occorre osservare che gli argomenti della ricorrente non sono idonei a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda le sue valutazioni quali menzionate ai precedenti punti da 77 a 83. Infatti, la ricorrente si limita a sostenere, in maniera generale, che la Commissione non ha dovutamente adempiuto il suo obbligo di prendere in considerazione il ciclo di vita, ma non indica alcun elemento concreto che consenta di rimettere in discussione la plausibilità delle valutazioni della Commissione.
88 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del primo motivo e, di conseguenza, detto motivo.
Sul secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda le attività connesse alle bioenergie
89 Il presente motivo si suddivide in due parti, la prima vertente su un errore manifesto di valutazione relativo al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la seconda, dedotta in subordine, vertente su un'applicazione erronea del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda il principio di utilizzo a cascata della biomassa forestale.
Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
90 La ricorrente sostiene, in sostanza, che, al punto 3.1 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la combustione della biomassa forestale contribuisce sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico e non causa un danno significativo agli obiettivi ambientali.
91 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
92 Occorre esaminare in successione i diversi argomenti dedotti dalla ricorrente. In primo luogo, quest'ultima sostiene che la Commissione ha erroneamente adottato una decisione «politica» al fine di ponderare i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento sulla tassonomia. Essa aggiunge che la Commissione ha indebitamente fondato i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alle bioenergie sulla direttiva RED II e sul regolamento LULUCF.
93 Occorre constatare che tale argomento della ricorrente coincide in gran parte con gli argomenti sviluppati nell'ambito della seconda e della terza parte del primo motivo.
94 Orbene, da un lato, nei limiti in cui la ricorrente contesta che la Commissione possa ponderare i diversi requisiti enunciati all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico, essa non deduce alcun argomento concreto che consenta di dimostrare che la Commissione ha applicato erroneamente tale bilanciamento. Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 55 a 57, spetta alla Commissione, in sede di fissazione dei criteri di vaglio tecnico, prendere in considerazione tutti i requisiti previsti da tale disposizione, trovando, se del caso, l'equilibrio appropriato o una concordanza pratica tra tali esigenze, tenuto conto della loro diversità di obiettivi e di natura e del fatto che esse non sono necessariamente convergenti tra loro.
95 Dall'altro lato, occorre osservare che, come è stato concluso ai precedenti punti 63 e 69, i criteri di vaglio tecnico non possono essere stabiliti dalla Commissione senza tener conto della normativa dell'Unione in vigore e, in particolare, della direttiva RED II e del regolamento LULUCF.
96 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 67, il regolamento sulla tassonomia rinvia espressamente alla direttiva RED II e indirettamente al regolamento LULUCF. In tal senso, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia prevede che si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, in particolare producendo, trasportando, immagazzinando, distribuendo o utilizzando energie rinnovabili ai sensi di detta direttiva. Inoltre, dal considerando 32 del medesimo regolamento risulta che l'espressione «gestione sostenibile delle foreste» deve essere intesa nel senso che tiene conto, in particolare, di tale direttiva e del regolamento LULUCF.
97 In particolare, dal precedente punto 68 risulta che i criteri LULUCF previsti all'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II e il regolamento LULUCF sono intrinsecamente connessi, poiché la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF è effettuata sulla base di tale regolamento.
98 Inoltre, dalla valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato risulta che il regolamento LULUCF prevede la stima più completa delle emissioni di biomassa, attribuendo direttamente e immediatamente tutte le variazioni dello stock di carbonio delle foreste (compreso, ad esempio, al suolo) alle emissioni dell'anno di raccolta, compensate dal sequestro nel sistema forestale.
99 Peraltro, come constatato al precedente punto 70, dagli esempi concreti addotti al punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata risulta che i criteri di vaglio tecnico stabiliti per le attività connesse alle bioenergie prevedono requisiti diversi da quelli attualmente previsti nella normativa in vigore, riguardanti, in particolare, l'introduzione di una soglia più elevata di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o il divieto di utilizzare colture destinate all'alimentazione umana o animale per la fabbricazione di biogas o biocarburanti.
100 Ne consegue che non si può addebitare alla Commissione di aver preso in considerazione la direttiva RED II e il regolamento LULUCF al momento della fissazione dei criteri di vaglio tecnico. L'argomento vago della ricorrente secondo cui il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile ha constatato che tale normativa non rispettava pienamente i requisiti del regolamento sulla tassonomia non è tale da rimettere in discussione tale conclusione, tanto più che è dimostrato che i criteri di vaglio tecnico di cui trattasi nel caso di specie prevedono requisiti diversi da quelli attualmente previsti da detta normativa.
101 In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver trattato in modo uniforme tutte le materie prime di origine forestale senza seguire le raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile che raccomandavano di limitare l'elenco della biomassa, del biogas e dei biocarburanti sostenibili alle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX della direttiva RED II.
102 A tal riguardo, la Commissione ha indicato al punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata che, certamente, essa non aveva seguito dette raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile. Tuttavia, da un lato, tali raccomandazioni non terrebbero conto del fatto che le materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva RED II, pur presentando un forte potenziale di decarbonizzazione, non sarebbero ancora competitive sul piano commerciale. Dall'altro, esse raccomanderebbero un sistema di certificazione che avrebbe comportato un aumento degli oneri amministrativi e dei costi per i proprietari di foreste, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo espresso al considerando 47 del regolamento sulla tassonomia, secondo il quale la Commissione dovrebbe stabilire criteri di vaglio tecnico che garantiscano una sufficiente certezza del diritto e che siano facilmente applicabili e verificabili nei limiti dei costi ragionevoli di adeguamento alla normativa, evitando in tal modo inutili oneri amministrativi.
103 In tali circostanze, la Commissione ha concluso, al punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata, che la definizione dei criteri di vaglio tecnico aveva richiesto una ponderazione in occasione della quale era stato altresì preso in considerazione il rischio di difficoltà di attuazione, per quanto riguarda, in particolare, la facilità d'uso per gli operatori che avevano familiarità con i parametri della direttiva RED II, e la potenziale perdita di interesse del mercato che potrebbe derivarne se le attività economiche considerate sostenibili nell'ambito di tale direttiva perdessero tale etichetta nell'ambito della tassonomia europea.
104 Le valutazioni della Commissione, di cui ai punti 102 e 103 supra, non sono messe in discussione dall’argomentazione della ricorrente, tenuto conto, in particolare, delle ragioni addotte dalla Commissione per non seguire le raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile per quanto riguarda le materie prime elencate nell’allegato IX, parte A, della direttiva RED II. Infatti, non è dimostrato che tali motivi, vale a dire il fatto che dette materie prime non erano ancora competitive sul piano commerciale e che dette raccomandazioni prevedevano un sistema di certificazione che avrebbe comportato un aumento degli oneri amministrativi e dei costi per i proprietari forestali, siano viziati da un errore manifesto di valutazione tale da metterne in discussione la plausibilità, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 32 supra.
105 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore basandosi su divergenze di opinione tra le parti interessate al fine di escludere, a torto, elementi scientifici prodotti dinanzi ad essa. A suo avviso, la Commissione ha ignorato, in particolare, elementi scientifici esposti nella richiesta di riesame interno, i quali dimostrano che la combustione di biomassa forestale aumenterebbe le emissioni di gas a effetto serra, avrebbe come conseguenza un prolungamento del tempo di recupero del carbonio, causerebbe un danno alla biodiversità e non consentirebbe di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, tanto più che il quadro giuridico esistente non tiene conto dei costi in termini di carbonio della biomassa forestale importata.
106 Occorre constatare che tali argomenti della ricorrente non sono sufficientemente dimostrati. In primo luogo, dal punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata risulta che la Commissione ha risposto agli argomenti esposti dalla ricorrente nella richiesta di riesame interno, compresi quelli riguardanti elementi scientifici. Tali risposte sono peraltro riassunte nel ricorso. Non è quindi affatto dimostrato che, in detta decisione, la Commissione abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi scientifici esposti dalla ricorrente.
107 In secondo luogo, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che gli elementi scientifici esposti dalla ricorrente non erano gli unici elementi esistenti. Infatti, al punto 3.1.1, lettera b), dell'allegato II di detta decisione, la Commissione menziona diversi altri elementi da essa presi in considerazione, ossia le raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile, la valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato, la valutazione d'impatto che accompagna la direttiva RED II, le linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e gli studi scientifici sviluppati nell'ambito del suo Centro comune di ricerca (JRC).
108 In terzo luogo e in ogni caso, occorre osservare che la ricorrente si limita a riprodurre, nel ricorso, gli argomenti da essa dedotti nella fase della richiesta di riesame interno e le risposte della Commissione a detti argomenti, senza tuttavia indicare un qualsivoglia elemento concreto che consenta di rimettere in discussione la plausibilità di tali risposte. La mera circostanza che, nell'ambito della valutazione di tali elementi di carattere scientifico e complesso, la Commissione avesse privilegiato taluni elementi a scapito di quelli dedotti dalla ricorrente non consente di concludere che la Commissione abbia erroneamente escluso questi ultimi o di rimettere in discussione una siffatta valutazione, per la quale essa dispone di un ampio potere discrezionale, come ricordato al precedente punto 31.
109 Peraltro, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alla mancata presa in considerazione del legname importato, occorre constatare che, certamente, il regolamento LULUCF non si applica a tale tipo di legname. Tuttavia, le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II si applicano sia al legname proveniente dall'Unione sia al legname importato, come sostiene la Commissione. Infatti, dal paragrafo 6 di tale articolo risulta che i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili devono tener conto, in particolare, della questione se il paese in cui è stata sfruttata la biomassa forestale disponga di una normativa a livello nazionale o subnazionale applicabile nella zona di sfruttamento nonché di sistemi di monitoraggio. Inoltre, ai sensi del paragrafo 7, lettera a), punti i) e iii), di detto articolo, si deve altresì tener conto della questione se il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica di origine della biomassa forestale sia parte dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e disponga di una legislazione applicabile alla zona di sfruttamento, al fine di conservare e rafforzare gli stock e i pozzi di assorbimento, e che attesti che le emissioni del settore LULUCF dichiarate non superano gli assorbimenti [paragrafo 7, lettera a), i) e iii)].
110 Ne consegue che erroneamente la ricorrente sostiene che il legno importato non è stato considerato ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse alle bioenergie.
111 Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su un'applicazione erronea del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda il principio di utilizzo a cascata della biomassa forestale
112 La ricorrente fa valere che il punto 3.1.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata è viziato da un errore manifesto di valutazione. A suo avviso, la Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi fossero elementi scientifici sufficienti per stabilire criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda l'utilizzo della biomassa forestale nelle attività connesse alle bioenergie. Tuttavia, gli elementi scientifici sarebbero ampiamente sufficienti e il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile avrebbe raccomandato di stabilire tali criteri al fine di tenere conto del principio dell'utilizzo a cascata della biomassa, principio anch'esso riconosciuto nella proposta di direttiva che modifica la direttiva RED II. In subordine, la ricorrente sostiene che, qualora gli elementi scientifici risultassero insufficienti, il principio di precauzione richiederebbe che la combustione di biomassa forestale non fosse inclusa nella tassonomia. Peraltro, la ricorrente sostiene che la Commissione si è erroneamente basata sulla prospettiva di una normativa futura per giustificare il fatto di non agire, attualmente, conformemente ai requisiti del regolamento sulla tassonomia.
113 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
114 Anzitutto, occorre osservare che, al punto 3.1.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha fatto valere che la relazione che disciplinava il principio di utilizzo a cascata della biomassa era estremamente complessa e che elementi scientifici sufficienti erano essenziali per definire criteri appropriati al fine di garantire la corretta applicazione di tale principio. Tale complessità era riconosciuta nel documento della Commissione del 2018 intitolato «Guidance on cascading use of biomass with selected good practice esamples on woody biomass» (Guida all'uso a cascata della biomassa con una selezione di esempi di buone pratiche sulla biomassa legnosa) e nella relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente n. 8/2018, intitolata «The circular economy and the bioeconomy» (L'economia circolare e la bioeconomia).
115 In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che, in tale contesto, le fosse possibile ricorrere ad un approccio per fasi e procedere in funzione dell'esperienza acquisita, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia.
116 In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la direttiva RED II contenesse già disposizioni relative alla gerarchia dei rifiuti e all'economia circolare, che gli operatori dovevano rispettare. In particolare, il considerando 21 di detta direttiva prevedeva che gli Stati membri «[dovrebbero] tenere debitamente conto dei principi dell'economia circolare». L'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva disponeva che «[g] li Stati membri provvedono affinché nell’elaborazione delle politiche nazionali (...) e dei regimi di sostegno sia tenuta in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE al fine di evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati delle materie prime». L'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva RED II prevedeva che la Commissione riesaminasse l'elenco delle materie prime, compresa la biomassa, e fondasse la sua analisi sui principi dell'economia circolare.
117 In quarto luogo, la Commissione ha indicato che la proposta di direttiva che modifica la direttiva RED II prevedeva, in particolare, che gli Stati membri adottassero misure per garantire che l'energia da biomassa fosse prodotta in modo da tener conto della gerarchia dei rifiuti e del principio dell'utilizzo a cascata. Inoltre, tale proposta di direttiva imponeva alla Commissione di adottare un atto delegato sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata della biomassa.
118 Tale approccio graduale esposto dalla Commissione nella decisione impugnata risulta altresì dal considerando 31 del regolamento delegato, secondo il quale «è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alla bioenergia onde tenere conto delle evidenze empiriche più recenti (…) prendendo in considerazione anche il diritto dell'Unione pertinente, segnatamente la direttiva [RED II] e sue future revisioni».
119 Occorre poi osservare che il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile ha raccomandato alla Commissione di includere criteri relativi alle attività connesse alla bioenergia per quanto riguarda la transizione verso un'economia circolare.
120 Infine, occorre rilevare che il principio dell'utilizzo a cascata mira all'uso efficiente delle risorse, dando la priorità all'utilizzo dei materiali dei prodotti in funzione del loro valore aggiunto economico e ambientale più elevato in un determinato ordine di priorità.
121 La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi fossero elementi scientifici sufficienti per stabilire criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare al fine di prendere in considerazione il principio dell'utilizzo a cascata della biomassa forestale.
122 Tuttavia, la ricorrente non deduce argomenti concreti che consentano di contraddire la conclusione della Commissione sull'insufficienza di elementi scientifici. Per contro, si deve constatare che dagli studi menzionati nella parte della decisione impugnata riportata al precedente punto 114 risulta che la questione della relazione tra il principio di utilizzo a cascata e la biomassa era complessa. Inoltre, la circostanza che la ricorrente giunga ad una conclusione sulla sufficienza di elementi scientifici diversa da quella della Commissione non è sufficiente a dimostrare che la detta decisione sia viziata da un errore manifesto di valutazione al riguardo.
123 Inoltre, occorre respingere l'argomento della ricorrente relativo al principio di precauzione. Infatti, la semplice invocazione di detto principio non può essere sufficiente a rimettere in discussione la plausibilità delle valutazioni della Commissione, menzionate ai precedenti punti da 114 a 117, che l'hanno indotta a includere, nel regolamento delegato, l'utilizzo della biomassa forestale nelle attività connesse alle bioenergie, ritenendo che le fosse possibile ricorrere a un approccio per fasi e procedere in funzione dell'esperienza acquisita.
124 Quanto all'argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione si è basata sulla prospettiva di una normativa futura per giustificare il fatto di non agire, attualmente, conformemente ai requisiti del regolamento sulla tassonomia, esso si basa su una lettura erronea della decisione impugnata. Infatti, dal punto 3.1.2, lettera b), dell'allegato II di tale decisione, nella parte menzionata al precedente punto 114, risulta che la Commissione ha invocato l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia al fine di far valere che essa poteva ricorrere a un approccio per tappe e procedere in funzione dell'esperienza acquisita, poiché era tenuta a riesaminare regolarmente i criteri di vaglio tecnico e, se del caso, a modificare gli atti delegati adottati in funzione del progresso scientifico e tecnologico, conformemente a detto articolo 19, paragrafo 5.
125 A ciò si aggiunge che la Commissione ha invocato la proposta di direttiva che modifica la direttiva RED II al fine di sottolineare gli impegni futuri che essa aveva già assunto al riguardo, tenuto conto delle circostanze prese in considerazione alla data della decisione impugnata, relative alla complessità del rapporto tra il principio di utilizzo a cascata e la biomassa e all'assenza di elementi scientifici sufficienti per definire criteri adeguati al fine di garantire la corretta applicazione del principio di utilizzo a cascata.
126 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non ha invocato l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia per giustificare una qualsivoglia inerzia.
127 Peraltro, occorre constatare che la ricorrente non precisa le disposizioni giuridiche sulle quali fonda la sua argomentazione. Tuttavia, nella parte in cui gli argomenti della ricorrente possono essere interpretati come vertenti su una violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, essi devono essere respinti.
128 Da un lato, è vero che dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, risulta che la Commissione deve stabilire criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se l'attività economica interessata arrechi un pregiudizio significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze enunciate ai precedenti punti da 114 a 120, l'approccio per tappe adottato dalla Commissione per quanto riguarda, in particolare, la presa in considerazione del principio di utilizzo a cascata della biomassa forestale non può, di per sé e senza ulteriori precisazioni, corrispondere a una violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni summenzionate. Orbene, l'argomento della ricorrente non è idoneo a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nella sua analisi del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda le attività connesse alle bioenergie. Dall'altro lato, la ricorrente non precisa neppure quali attività concrete sarebbero oggetto della sua argomentazione.
129 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo e, di conseguenza, detto motivo.
Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici di base
130 Il presente motivo si suddivide in quattro parti, vertenti su errori manifesti di valutazione relativi:
– la prima, alla classificazione della fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione;
– la seconda, ai criteri per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'obiettivo della transizione verso un'economia circolare;
– la terza, ai criteri per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'obiettivo di un uso sostenibile e di protezione delle risorse acquatiche e marine; nonché
– la quarta, ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare danno significativo all'obiettivo della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento.
131 In via preliminare, occorre rilevare che, anzitutto, dalla decisione impugnata, letta in combinato disposto con il punto 3.14 dell'allegato I del regolamento delegato, risulta che l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base prevista da tale regolamento delegato comprende sette tipi di prodotti chimici, vale a dire i prodotti chimici di elevato valore, i composti aromatici, il cloruro di vinile, lo stirene, l'ossido di etilene, il glicole monoetilenico e l'acido adipico.
132 Inoltre, dal punto 3.14 dell'allegato I del regolamento delegato risulta che un'attività economica rientrante in tale punto costituisce un'attività di transizione come quella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, qualora soddisfi i criteri di vaglio tecnico enunciati in tale punto, vale a dire criteri relativi, da un lato, al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, dall'altro, al principio consistente nel non causare danni significativi, compresi i criteri stabiliti nelle appendici da A a D di tale allegato I.
133 Infine, dal fascicolo, nonché dalle risposte delle parti a quesiti posti loro dal Tribunale in udienza, risulta che taluni prodotti chimici organici di base derivanti dall'attività di cui al punto 3.14 dell'allegato II del regolamento delegato sono successivamente utilizzati in varie altre attività, alle quali sono talvolta essenziali, come la fabbricazione del nylon, di prodotti per la casa, di plastica o di prodotti farmaceutici.
Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto alla classificazione della fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione
134 La ricorrente sostiene che, al punto 3.2.1 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, ritenendo che la fabbricazione di prodotti chimici organici di base potesse essere classificata come un'attività di transizione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento. Da un lato, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell'impatto del ciclo di vita dei prodotti e, dall'altro, non avrebbe basato la classificazione di tale attività come attività di transizione su elementi scientifici concludenti. Gli elementi scientifici esposti nella richiesta di riesame interno rivelerebbero l'assenza di qualsiasi fondamento adeguato per concludere che i criteri di vaglio tecnico applicabili alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base fornirebbero un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non causerebbero un danno significativo. Peraltro, la Commissione non potrebbe basarsi sul principio di precauzione per diluire l'obbligo di vigilare affinché i criteri di vaglio tecnico tengano conto del ciclo di vita completo del prodotto. Nel caso di specie, il principio di precauzione richiederebbe di non includere tale attività nella tassonomia.
135 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
136 In via preliminare, occorre constatare che, come osservato ai precedenti punti 16 e 18, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia prevede le condizioni alle quali si ritiene che un'attività economica apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede tali condizioni per le attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio praticabili sul piano tecnologico ed economico, vale a dire per le attività cosiddette «di transizione», ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), ii), di tale regolamento.
137 Ai sensi del considerando 41 del regolamento sulla tassonomia, «la transizione [in corso verso un’economia climaticamente neutra] richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili», e «[s]i dovrebbe considerare che tali attività economiche di transizione contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di gas a effetto serra sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell’industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi». Inoltre, «[i] criteri di vaglio tecnico di tali attività economiche di transizione dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari».
138 L'articolo 19, paragrafo 5, primo e ultimo comma, del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico stabiliti per le attività di transizione debbano essere riveduti almeno ogni tre anni, in funzione dei progressi scientifici e tecnologici.
139 Come osservato ai precedenti punti 75, 76 e 85, risulta, in sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con i considerando 34, 40 e 47 del regolamento sulla tassonomia, che i criteri di vaglio tecnico devono tener conto del ciclo di vita dei prodotti e servizi forniti dall'attività economica di cui trattasi, prendendo in considerazione sia l'impatto ambientale dell'attività economica stessa sia l'impatto ambientale di tali prodotti e servizi. Tuttavia, tale disposizione non richiede la fissazione di criteri di vaglio tecnico riguardanti specificamente il ciclo di vita, né obbliga la Commissione ad effettuare un'analisi del ciclo di vita in tutti i casi di specie. Ciò che si richiede è che all'atto dell'adozione dei criteri di vaglio tecnico il ciclo di vita sia preso in considerazione dalla Commissione, tenendo conto, in particolare, delle analisi del ciclo di vita esistenti.
140 Anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto dell'impatto del ciclo di vita dei prodotti. Tale argomento è simile a quello dedotto a sostegno della quarta parte del primo motivo e deve quindi essere respinto per le stesse ragioni menzionate ai precedenti punti da 77 a 86.
141 Infatti, come constatato al precedente punto 84, la Commissione ha sostenuto, nella decisione impugnata, che l'integrazione universale delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri di vaglio tecnico si rivelava difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili. Tuttavia, da detta decisione risulta altresì che, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico relativi alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base, la Commissione ha preso in considerazione le emissioni dirette di gas a effetto serra per il processo di fabbricazione e, in particolare, i parametri di riferimento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
142 Inoltre, come rilevato al precedente punto 85, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con i considerando 34, 40 e 47 del regolamento sulla tassonomia, non impone di prevedere criteri di vaglio tecnico riguardanti specificamente il ciclo di vita, né obbliga la Commissione ad effettuare un'analisi del ciclo di vita in tutti i casi di specie. Ciò che si richiede è che all'atto dell'adozione dei criteri di vaglio tecnico il ciclo di vita sia preso in considerazione dalla Commissione, tenendo conto, in particolare, delle analisi del ciclo di vita esistenti.
143 Orbene, nella presente parte del terzo motivo, così come nella quarta parte del primo motivo (v. punto 87 supra), la ricorrente si limita a sostenere, in maniera generale, che la Commissione non si sarebbe debitamente conformata al suo obbligo di prendere in considerazione il ciclo di vita, ma non indica alcun elemento concreto che consenta di rimettere in discussione la plausibilità delle valutazioni della Commissione, menzionate ai punti 141 e 142 supra.
144 Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha basato la classificazione dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione su elementi scientifici concludenti.
145 Tuttavia, tale argomento non è fondato, come sostiene la Commissione. Infatti, la ricorrente si limita ad affermare che la classificazione della fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione sarebbe in contrasto con gli elementi scientifici disponibili, «non solo per quanto riguarda gli impatti del ciclo di vita, ma più in generale [anche]», senza tuttavia precisare gli elementi scientifici ai quali essa fa riferimento né le disposizioni asseritamente violate dalla decisione impugnata. Inoltre, il semplice rinvio, senza ulteriori precisazioni, agli elementi esposti nella richiesta di riesame interno non può essere sufficiente a rimediare a tale insufficienza di allegazione.
146 Infine, la ricorrente sostiene che il principio di precauzione impone di non includere l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base nella tassonomia. Tuttavia, essa non spiega in che modo la classificazione della fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione contrasti con tale principio.
147 Peraltro, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la ricorrente non ha presentato alcun argomento che dimostri che essa aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale decidendo di classificare la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come attività di transizione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
148 Si deve pertanto respingere la terza parte del terzo motivo.
Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare
149 La ricorrente sostiene, in sostanza, che, per le ragioni già esposte nell'ambito della prima parte del terzo motivo, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione al punto 3.2.2, lettera a), dell'allegato II della decisione impugnata, omettendo di prendere in considerazione gli impatti del ciclo di vita dei prodotti chimici organici di base e, pertanto, omettendo di proporre criteri relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare.
150 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
151 Occorre anzitutto constatare che, nell'ambito della presente parte, la ricorrente si limita a rinviare agli argomenti da essa dedotti nell'ambito della prima parte di tale motivo. Detti argomenti devono essere respinti per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti da 40 a 148.
152 La circostanza che la presente parte sembri vertente su una violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, mentre la prima parte del terzo motivo verte su una violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, nulla toglie a tale conclusione. Infatti, la ricorrente non deduce alcun argomento circostanziato che consenta di dimostrare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nella sua analisi del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base.
153 Pertanto, la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.
Sulla terza parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di utilizzo sostenibile e di protezione delle risorse acquatiche e marine
154 La ricorrente sostiene che, al punto 3.2.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'obbligo di stabilire criteri relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione avrebbero preso in considerazione unicamente i corpi idrici di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque»). Tuttavia, l'appendice B dell'allegato I del regolamento delegato non farebbe alcun riferimento all'ambiente marino e alla direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU 2008, L 164, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino»). La ricorrente aggiunge che, nella richiesta di riesame interno, essa ha tuttavia esposto un insieme di elementi scientifici che dimostrano che i prodotti chimici organici di base erano utilizzati nella produzione di materie plastiche e che queste ultime presentavano un rischio considerevole per gli ecosistemi marini, in particolare a causa dell'inquinamento provocato dalle microplastiche e dalle nanoplastiche.
155 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
156 In via preliminare, occorre osservare che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia prevede che l'atto delegato adottato dalla Commissione stabilisca, per ciascun obiettivo ambientale pertinente, criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se l'attività economica interessata arrechi un danno significativo a uno o più di tali obiettivi (v. punto 19 supra).
157 L'articolo 9, lettera c), del regolamento sulla tassonomia prevede come obiettivo ambientale «l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine» (v. punto 14 supra).
158 L'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), i) e ii), del regolamento sulla tassonomia prevede che, ai fini dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di fatto ricavati dall'analisi del ciclo di vita esistenti, tale attività economica è considerata causa di un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine, qualora tale attività pregiudichi il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o il buono stato ecologico delle acque marine (v. supra, punti 13 e 22).
159 Inoltre, ai sensi del suo articolo 1, primo comma, la direttiva quadro sulle acque mira a istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.
160 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva quadro sulla «strategia per l'ambiente marino» istituisce un quadro che consente agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020. Tale direttiva impone a ciascuno Stato membro, in particolare, di elaborare, per ciascuna regione o sotto-regione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino applicabile alle sue acque marine, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e al suo considerando 11. A tal fine, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri devono definire, per le acque marine di ciascuna regione o sotto-regione interessata, un insieme di caratteristiche corrispondenti a un buono stato ecologico, basato sui descrittori qualitativi elencati nell'allegato I. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva, gli Stati membri devono definire, per ciascuna regione o sotto-regione marina, una serie esaustiva di obiettivi ambientali e di indicatori associati per le loro acque marine al fine di orientare gli sforzi per raggiungere un buono stato ecologico dell'ambiente marino.
161 Nel caso di specie, dal punto 3.2.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata risulta che, per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico, la Commissione ha ritenuto che il regolamento sulla tassonomia operasse a livello di attività economiche e che, per quanto riguardava l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base, l'appendice B dell'allegato I del regolamento delegato prevedesse criteri sufficienti per soddisfare il principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine. Tali criteri si riferivano ai piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 13 e dell'allegato VII della direttiva quadro in materia di acque. Tali piani di gestione si applicavano anche alle acque costiere e di transizione, vale a dire le acque situate a un miglio terrestre per la maggior parte degli elementi di qualità che definivano il buono stato delle acque e quelle situate a 12 miglia terrestri per lo stato chimico. Inoltre, gli allegati II e VIII di detta direttiva quadro imponevano agli Stati membri di includere le plastiche e le microplastiche nella categoria degli inquinanti «materiali in sospensione» nell'acqua. Secondo la Commissione, gli impatti a valle dell'attività di cui trattasi erano complessi e connessi a numerose attività economiche, tenuto conto degli usi molto vari dei prodotti chimici organici di base. Per quanto riguarda l'impatto potenziale a valle dell'inquinamento da microplastiche e nanoplastiche, esso sarebbe meglio coperto da attività più specifiche a valle, comprese le attività connesse alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, che potrebbero essere prese in considerazione nella tassonomia man mano che viene sviluppata.
162 Per quanto riguarda la direttiva quadro «strategia per l'ambiente marino», la Commissione ha ritenuto, al punto 3.2.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata, che tale direttiva quadro non fissasse la concentrazione massima di taluni contaminanti, compresi i prodotti chimici organici di base. Gli Stati membri erano i responsabili della definizione delle concentrazioni massime nell'ambito della cooperazione regionale o subregionale, come risultava dall'articolo 9 e dai descrittori qualitativi previsti ai punti 8 e 9 dell'allegato I di tale direttiva quadro, utilizzati per definire il buono stato ecologico.
163 La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto non ha preso in considerazione l'ambiente marino e la direttiva quadro «strategia per l'ambiente marino» nei criteri di vaglio tecnico stabiliti per l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base, mentre elementi scientifici dimostravano che tali prodotti chimici erano utilizzati nella produzione di materie plastiche e che questi ultimi presentavano un rischio considerevole per gli ecosistemi marini a causa dell'inquinamento provocato dalle microplastiche e dalle nanoplastiche.
164 L'argomentazione della ricorrente sembra derivare da un'interpretazione di talune disposizioni del regolamento sulla tassonomia, non precisate, secondo la quale, nel fissare i criteri di vaglio tecnico ai fini dell'applicazione del principio consistente nel non causare un danno notevole, la Commissione deve tener conto dell'impatto sulle risorse acquatiche e marine non solo dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base, ma anche delle attività economiche intervenute a valle di quest'ultima e, in particolare, della fabbricazione di plastiche.
165 A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal precedente punto 133, i prodotti chimici organici di base sono successivamente utilizzati in varie altre attività, compresa la fabbricazione di plastiche. Tuttavia, l'attività economica di cui trattasi al punto 3.2.2, lettera b), dell'allegato II della decisione impugnata non era la fabbricazione di plastiche, bensì la fabbricazione di prodotti chimici organici di base.
166 Orbene, dalle disposizioni del regolamento sulla tassonomia non risulta che i criteri di vaglio tecnico fissati alla luce del principio consistente nel non arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali e, in particolare, all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse acquatiche e marine debbano prendere in considerazione le attività economiche situate a valle dell'attività oggetto di detti criteri.
167 Infatti, il regolamento sulla tassonomia mira a stabilire un sistema di classificazione unificata delle attività economiche considerate sostenibili sul piano ambientale (v. punto 12 supra). Tale classificazione o tassonomia riguarda quindi determinate attività economiche.
168 Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi fattuali ricavati dalle analisi esistenti del ciclo di vita, prendendo in considerazione sia l'impatto ambientale dell'attività economica stessa sia l'impatto ambientale dei prodotti e servizi che essa fornisce, esaminando in particolare la produzione, l'utilizzo e la fine del ciclo di vita di tali prodotti e servizi.
169 Inoltre, dal combinato disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia risulta che la fissazione dei criteri di vaglio tecnico, da parte della Commissione, anche al fine di determinare se un'attività economica arrechi un pregiudizio significativo all'obiettivo di utilizzo sostenibile e di protezione delle risorse acquatiche e marine, deve avvenire in relazione a una determinata attività economica nonché ai prodotti o ai servizi forniti da tale attività.
170 Pertanto, la fissazione, da parte della Commissione, dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività possa essere considerata sostenibile riguarda, caso per caso, un'attività economica concreta e non riguarda quindi direttamente prodotti o servizi derivanti da altre attività a valle dell'attività economica di cui trattasi.
171 Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente nella parte in cui vertono sull'assenza di criteri di vaglio tecnico vertenti sull'impatto ambientale della fabbricazione di plastiche o di altre attività a valle della fabbricazione di prodotti chimici organici di base, che è l'unica attività in questione nell'ambito del presente motivo.
172 Di conseguenza, occorre respingere anche l'argomento della ricorrente relativo al fatto che i criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione non hanno preso in considerazione la direttiva quadro «strategia per l'ambiente marino». Infatti, la ricorrente ha invocato tale direttiva quadro a sostegno del suo argomento vertente sull'impatto ambientale non dell'attività di cui trattasi nell'ambito del presente motivo, bensì dell'attività a valle della fabbricazione di plastiche e delle microplastiche e nanoplastiche fornite da tale attività.
173 Si deve pertanto respingere la terza parte del terzo motivo.
Sulla quarta parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento
174 La ricorrente sostiene che, al punto 3.2.2, lettera d), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione classificando l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base come un'attività di transizione, ove essa è destinata esclusivamente ad usi essenziali per la società. La Commissione ammetterebbe che almeno quattro sostanze comprese tra tali prodotti sarebbero state classificate come sostanze estremamente problematiche che causerebbero un danno significativo all'ambiente e che essa non avrebbe disposto di elementi sufficienti per sapere quali sarebbero i loro usi essenziali per la società. Contrariamente a quanto farebbe valere la Commissione, il pregiudizio causato dall'uso di tali sostanze non può essere compensato da un processo di fabbricazione a minore intensità di carbonio.
175 Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione si è erroneamente basata su disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento CLP»), e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento REACH»). Infatti, tali disposizioni non sarebbero pertinenti, in quanto definirebbero le condizioni per un'utilizzazione legale di tali sostanze, ma non fisserebbero i criteri che consentono di classificare un'attività come sostenibile sul piano ambientale.
176 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
177 In via preliminare, dal combinato disposto dell'articolo 9, lettera e), dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia risulta che l'atto delegato adottato dalla Commissione deve stabilire criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se l'attività economica in parola arrechi un danno significativo all'obiettivo della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento.
178 Dal punto 3.2.2, lettera d), dell'allegato II della decisione impugnata risulta che, anzitutto, la Commissione ha ritenuto che la censura della ricorrente derivasse da un'interpretazione non realistica della tassonomia, per quanto riguarda l'obbligo per la Commissione di garantire una facile verifica dell'uso a valle dei prodotti chimici organici di base. Secondo detta decisione, si trattava di prodotti chimici ad elevato volume di produzione che erano prodotti chimici «di base», vale a dire necessari alla fabbricazione di numerosi altri prodotti chimici utilizzati nella società.
179 Inoltre, la Commissione ha menzionato che i prodotti chimici organici di base includevano sostanze pericolose, ossia sostanze che erano oggetto di una classificazione e di un'etichettatura armonizzate ai sensi del regolamento CLP, sostanze che potevano essere identificate come sostanze estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH e sostanze il cui uso poteva rientrare nelle restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso previste all'allegato XVII di quest'ultimo regolamento (in prosieguo, congiuntamente: le «sostanze pericolose»). Tuttavia, essa ha precisato che la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, di cui al punto 3.14 dell'allegato I del regolamento delegato, doveva rispettare le condizioni di cui all'appendice C di tale allegato, da cui risultava che detta fabbricazione non poteva comportare la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze pericolose, come quelle summenzionate, a meno che non fosse stato dimostrato che il loro uso era essenziale per la società. Il concetto di «uso essenziale» per la società derivava dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Strategia per la sostenibilità delle sostanze chimiche», del 14 ottobre 2020 [COM (2020) 667 final] (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione sulla strategia per la sostenibilità delle sostanze chimiche»).
180 Pertanto, dalla decisione impugnata, letta in combinato disposto con il regolamento delegato, risulta che l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base è classificata come attività di transizione, ai fini del regolamento sulla tassonomia, solo se essa si svolge secondo un processo a minore intensità di carbonio, vale a dire quando le emissioni di gas a effetto serra dovute al suo processo di produzione sono inferiori alle soglie fissate al punto 3.14 dell'allegato I di detto regolamento.
181 Inoltre, come menzionato nella decisione impugnata, l'appendice C dell'allegato I del regolamento delegato prevede che la classificazione come attività di transizione non si applica alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base, poiché si tratta della fabbricazione di sostanze (o miscele che li contengono) che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH, vale a dire, in particolare, sostanze (o miscele che le contengono) che possono essere classificate ai sensi del regolamento CLP, per taluni pericoli e categorie di pericolo, «a meno che non sia stato dimostrato che il loro uso è essenziale per la società».
182 Da quanto precede risulta che la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando contesta alla Commissione di non aver addotto elementi sufficienti sull'uso a valle delle sostanze pericolose e sui loro usi che sono essenziali per la società.
183 Infatti, da un lato, l'argomento della ricorrente non tiene conto della comunicazione della Commissione sulla strategia per la sostenibilità nel settore dei prodotti chimici, menzionata nella decisione impugnata (v. punto 179 supra). Orbene, come rilevato dalla Commissione in udienza, senza essere contraddetta al riguardo dalla ricorrente, da tale comunicazione discende che le sostanze pericolose il cui uso è essenziale sono quelle che sono importanti per la sicurezza e la salute umana o che sono critiche per il funzionamento della società.
184 La comunicazione della Commissione sulla strategia per la sostenibilità nel settore delle sostanze chimiche rinvia alla convenzione di Vienna per la protezione Fello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, di cui l'Unione è divenuta parte con la decisione n. 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU 1988, L 297, pag. 8). Gli obblighi derivanti da detta convenzione e da detto protocollo sono attualmente attuati nell'ordinamento giuridico dell'Unione dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [GU 2009, L 286, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento n. 1005/2009 (GU 2017, L 84, pag. 3)]. Il regolamento n. 1005/2009 contiene varie disposizioni riguardanti, in particolare, «usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi» delle «sostanze controllate», elencate nel suo allegato I.
185 In tali circostanze, non è dimostrato che la Commissione non disponesse di elementi sulle sostanze pericolose il cui uso è essenziale per la società.
186 Dall'altro lato, la ricorrente sostiene erroneamente che i regolamenti REACH e CLP, ai quali rinvia la decisione impugnata, non sono pertinenti al riguardo.
187 Occorre ricordare che il regolamento REACH, che fornisce il quadro normativo per la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze chimiche, «si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non hanno effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente» (articolo 1, paragrafo 3). Pertanto, tale regolamento stabilisce i doveri e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle delle sostanze (v. considerando 16) per quanto riguarda, in sostanza, la registrazione delle sostanze (titolo II), la condivisione dei dati (titolo III) e l'obbligo d'informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo IV).
188 Inoltre, il regolamento CLP, che stabilisce le prescrizioni armonizzate in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose, impone ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle obblighi consistenti, in particolare, nella classificazione, nell'etichettatura e nell'imballaggio (articolo 4), nell'identificazione e nell'esame delle informazioni disponibili sulle sostanze (articoli 5 e 6), nella valutazione di tali informazioni e, se del caso, nell'autoclassificazione delle sostanze, applicando i criteri di classificazione per ciascuna classe di pericolo (articoli 5, 9 e 13), nonché nella presentazione di proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate (articolo 37, paragrafi 1 e 2).
189 Pertanto, dagli obblighi giuridici in materia di sicurezza chimica, previsti in particolare nei regolamenti REACH e CLP, risulta che gli usi a valle dei prodotti chimici organici di base sono regolamentati e che i fabbricanti di tali prodotti, nonché altri attori nella catena di approvvigionamento, sono soggetti a una serie di obblighi in materia, in particolare, di registrazione, di informazione e di scambio di dati.
190 Orbene, la ricorrente non spiega in alcun modo perché il contesto normativo menzionato nella decisione impugnata, e ricordato ai punti 184 e da 187 a 189 supra, nonché gli obblighi che ne derivano sarebbero insufficienti a fornire elementi sugli usi a valle delle sostanze pericolose.
191 Peraltro, occorre respingere l'affermazione della ricorrente secondo cui il danno causato dall'uso delle sostanze pericolose non può essere compensato dal fatto che tali sostanze potrebbero essere fabbricate secondo un processo a minore intensità di carbonio. Tale affermazione, peraltro vaga, non è idonea a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
192 Da quanto precede risulta che non è dimostrato che, al punto 3.2.2, lettera d), dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento, per quanto riguarda l'attività di fabbricazione di sostanze chimiche organiche di base.
193 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del terzo motivo e, di conseguenza, detto motivo.
Sul quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base
194 Il presente motivo si suddivide in tre parti, vertenti su errori manifesti di valutazione relativi:
– la prima, all'assenza di una soglia quantitativa;
– la seconda, all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare; nonché
– la terza, all'obiettivo dell'uso sostenibile e della protezione delle risorse acquatiche e marine.
195 In via preliminare, occorre rilevare, anzitutto, che dalla decisione impugnata, letta in combinato disposto con il punto 3.17 dell'allegato I del regolamento delegato, risulta che l'attività di fabbricazione di materie plastiche di base prevista da tale regolamento comprende la «[f]abbricazione di resine sintetiche, di materie plastiche e di elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, nonché [la] miscela di resine su comando e [la] fabbricazione di resine sintetiche standard».
196 Inoltre, dal punto 3.17 dell'allegato I del regolamento delegato risulta che un'attività economica rientrante in tale punto costituisce un'attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, qualora soddisfi i criteri di vaglio tecnico enunciati in tale punto, vale a dire criteri relativi, da un lato, al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, dall'altro, all'applicazione del principio consistente nel non causare un danno significativo.
197 Infine, dal punto 3.17 dell'allegato I del regolamento delegato risulta che, oltre ai criteri di vaglio tecnico ivi previsti, l'attività di fabbricazione di materie plastiche di base deve rispettare i criteri stabiliti nelle appendici da A a D dell'allegato I di detto regolamento.
Sulla prima parte del quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all'assenza di una soglia quantitativa
198 La ricorrente fa valere che, al punto 3.3 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione, dato che i criteri di vaglio tecnico relativi alla fabbricazione di materie plastiche di base sono privi di qualsiasi soglia quantitativa per quanto riguarda la proporzione di materie prime rinnovabili, necessaria affinché tale fabbricazione possa essere classificata come attività che contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò comporterebbe un rischio di «ecologismo di facciata», poiché un prodotto potrebbe essere qualificato come bioplastico, mentre conterrebbe solo una piccola parte di materia plastica «di origine biologica». A titolo di esempio, la ricorrente suggerisce che avrebbe potuto essere precisata la percentuale di plastica rinnovabile necessaria per classificare l'attività come sostenibile. Inoltre, la Commissione avrebbe ammesso, in detta decisione, che i criteri di vaglio tecnico non sarebbero fondati su studi o perizie, limitandosi a menzionare la possibilità di una futura revisione di tali criteri. Orbene, né le successive modifiche del quadro normativo invocate in tale decisione né la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 30 novembre 2022 [COM (2022) 682 final] (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione sulle plastiche») possono ovviare a tali carenze nella fissazione dei criteri di vaglio tecnico.
199 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
200 In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver previsto soglie quantitative per quanto riguarda la quantità di materie prime rinnovabili utilizzate nella fabbricazione di materie plastiche di base. Ciò creerebbe un rischio di ecologismo di facciata che consente che le plastiche con una porzione molto ridotta di plastica di origine biologica possano essere qualificate come bioplastiche.
201 A tal riguardo, dal punto 3.3 dell'allegato II della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 3.17, lettere da a) a c), del regolamento delegato, risulta che si può ritenere che la fabbricazione di materie plastiche di base apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, qualora soddisfi uno dei tre criteri di vaglio tecnico seguenti: in primo luogo, «la materia plastica di base è interamente fabbricata mediante riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica»; in secondo luogo, «se il riciclaggio meccanico non è tecnicamente fattibile o economicamente fattibile, il materiale plastico di base è interamente prodotto mediante riciclaggio chimico di rifiuti di plastica»; in terzo luogo, essa è «ottenuta interamente o parzialmente da materie prime rinnovabili». Inoltre, nell'ambito del secondo e del terzo criterio, sono fissate soglie per le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita, ove tali emissioni devono essere calcolate sulla base della raccomandazione e delle norme ISO individuate e verificate da un terzo indipendente.
202 Ne consegue che, per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base, la Commissione ha stabilito, da un lato, un criterio qualitativo che obbliga all'utilizzo di materie prime rinnovabili in quantità non determinata e, dall'altro, un criterio quantitativo che impone che le emissioni di gas a effetto serra non superino le soglie stabilite.
203 Inoltre, al punto 3.3 dell’allegato II della decisione impugnata, la Commissione fa valere, in sostanza, che la fissazione di una soglia quantitativa connessa alla proporzione di materie prime rinnovabili e di una soglia assoluta per le emissioni di gas a effetto serra sull'intero ciclo di vita delle materie plastiche è stata resa difficile, se non impossibile, da fattori quali l'assenza di dati sufficienti per valutare i potenziali effetti sul ciclo di vita delle plastiche provenienti da diverse materie prime.
204 L'argomento della ricorrente non è tale da mettere in dubbio la plausibilità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 32, delle scelte della Commissione riguardanti i criteri di vaglio tecnico stabiliti per l'attività di fabbricazione di materie plastiche di base.
205 È vero che la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto fissare un criterio quantitativo che stabilisse una proporzione minima di materie prime rinnovabili per la fabbricazione di materie plastiche di base. Tuttavia, l'inclusione di criteri quantitativi o soglie nei criteri di vaglio tecnico non è obbligatoria in tutte le situazioni.
206 Infatti, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia prevede che tali criteri «sono quantitativi e per quanto possibile comprendono valori limite, altrimenti sono qualitativi» (v. punto 23 supra). Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), di detto regolamento prevede che i criteri di vaglio tecnico «sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità».
207 Pertanto, la scelta della Commissione di fissare un criterio qualitativo senza fissare una soglia quantitativa per quanto riguarda l'uso di materie prime rinnovabili non è, di per sé, contraria all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, l'ipotesi generale avanzata dalla ricorrente, secondo la quale l'esistenza di un criterio puramente qualitativo comporterebbe il rischio di un «ecologismo di facciata», non è sufficiente a mettere in dubbio la plausibilità di tale valutazione, né le ragioni invocate dalla Commissione, fondate sull'assenza di elementi sufficienti che consentano di fissare una siffatta soglia e di fissarla in modo tale che sarebbe di facile utilizzo e verifica, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), di detto regolamento.
208 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ammette nella decisione impugnata che i criteri di vaglio tecnico non sono fondati su studi o perizie. Inoltre, né le successive modifiche del quadro normativo né la comunicazione della Commissione sulle plastiche, invocate in detta decisione, possono ovviare a tali carenze.
209 Occorre anzitutto osservare che tale argomento non è affatto suffragato e sembra fondato su una lettura erronea della decisione impugnata. In ogni caso, esso non è confermato dagli elementi del fascicolo.
210 Occorre constatare che la Commissione non ammette, nella decisione impugnata, che i criteri di vaglio tecnico non siano fondati su elementi scientifici. Per contro, il punto 3.3 dell'allegato II di detta decisione rinvia al punto 2.1, lettera a), i), del medesimo allegato e quindi alla valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento delegato (v. punto 5 supra) e agli studi ivi menzionati. Inoltre, nel corso di tale decisione, nonché nei considerando del regolamento delegato, sono menzionati vari studi e pareri di esperti.
211 Orbene, la ricorrente non deduce alcun errore manifesto di valutazione riguardo agli studi o ai pareri menzionati nella decisione impugnata e non indica neppure che la Commissione abbia ignorato un qualsiasi studio pertinente ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico relativi all'attività di fabbricazione di materie plastiche di base.
212 Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo all'assenza di elementi scientifici non è dimostrato.
213 Di conseguenza, occorre respingere anche l'argomento della ricorrente relativo ad un'asserita insufficiente presa in considerazione delle successive modifiche del contesto normativo e della comunicazione della Commissione sulle plastiche, in quanto tale argomento si basa su un'asserita mancanza di elementi scientifici.
214 Peraltro, la ricorrente non spiega come la menzione, fatta nella decisione impugnata, del progetto della comunicazione della Commissione sulle plastiche possa comportare l'illegittimità di tale decisione.
215 Inoltre, per quanto riguarda la menzione, fatta nella decisione impugnata, di future revisioni dei criteri di vaglio tecnico, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, primo e ultimo comma, del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico stabiliti per le attività di transizione devono essere riveduti almeno ogni tre anni, in funzione dei progressi scientifici e tecnologici.
216 Dato che la fabbricazione di materie plastiche di base è classificata come attività di transizione (v. punti 26, 195 e 196 supra), non si può contestare alla Commissione di aver ricordato, nella decisione impugnata, il suo obbligo di riesame periodico dei criteri di vaglio tecnico. La natura di transizione o provvisoria della classificazione dell'attività come sostenibile dal punto di vista ambientale è alla base di tale obbligo, in quanto si tratta di un'attività per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio realizzabili dal punto di vista tecnologico ed economico, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
217 Pertanto, occorre respingere la prima parte del quarto motivo.
Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione quanto all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare
218 La ricorrente fa valere che, al punto 3.3.1 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto il regolamento delegato non contiene criteri relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare nel settore delle materie plastiche di base. Da un lato, la Commissione non avrebbe seguito la raccomandazione del gruppo di esperti sulla finanza sostenibile di considerare la fabbricazione di plastiche di base come di transizione solo nella misura in cui essa soddisfi criteri supplementari secondo i quali almeno il 90 % delle materie plastiche non sarebbe stato utilizzato in prodotti di consumo monouso o sarebbe derivato da materie plastiche riciclate. Se non fosse stato possibile seguire tale raccomandazione, la Commissione non avrebbe dovuto classificare tale attività come attività di transizione, tanto più che, alla data di detta decisione, essa lavorava su studi in tale settore. Le plastiche di origine biologica sarebbero principalmente oggetto di un uso unico e la loro produzione contribuirebbe ad un aumento della produzione di materie plastiche. Pertanto, in assenza di qualsiasi requisito legato alla transizione verso un'economia circolare, la produzione di materie plastiche non apporterebbe un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dall'altro lato, la Commissione non avrebbe preso in considerazione tecnologie che svolgono un ruolo importante nella determinazione dei livelli di riciclaggio, quali gli identificatori o l'ubicazione e il monitoraggio, né le alternative che avrebbero potuto essere adottate sulla base di elementi scientifici, in particolare quelli addotti a titolo di esempio dalla ricorrente.
219 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
220 In via preliminare, occorre ricordare che dal combinato disposto dell'articolo 9, lettera d), dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia risulta che l'atto delegato adottato dalla Commissione deve stabilire criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se l'attività economica interessata arrechi un danno significativo all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare.
221 Nel caso di specie, al punto 3.3.1 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto considerato che gli effetti a valle delle plastiche di origine biologica erano molto complessi, multiformi e connessi a numerose attività economiche a causa dei molteplici usi di tali plastiche. In sede di elaborazione dei criteri di vaglio tecnico applicabili alla fabbricazione di materie plastiche di base, la Commissione aveva fatto in modo, per quanto possibile, di tener conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e di quello dei prodotti e servizi forniti da tale attività durante tutto il loro ciclo di vita, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia.
222 La Commissione ha poi ritenuto che l'integrazione universale degli elementi del ciclo di vita nei criteri di vaglio tecnico fosse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili e della molteplicità delle applicazioni delle plastiche di origine biologica. A suo avviso, tali elementi erano stati menzionati nella valutazione d'impatto che accompagnava il progetto di regolamento delegato. Di conseguenza, poiché i dati scientifici più recenti non erano sufficientemente operativi per essere utilizzati, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia, essa ha deciso di non includere un criterio relativo al principio di non arrecare un danno significativo per quanto riguarda l'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per l'attività di fabbricazione di materie plastiche di base.
223 Infine, la Commissione ha indicato che avrebbe esaminato le prove scientifiche supplementari pertinenti e le avrebbe prese in considerazione in sede di riesame dell'atto delegato, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia. Essa ha dichiarato di lavorare già su una politica in materia, in particolare su un progetto di comunicazione sulle plastiche, che avrebbe fornito orientamenti su come fabbricare, utilizzare e trattare le plastiche di origine biologica.
224 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non ha seguito una raccomandazione del gruppo di esperti sulla finanza sostenibile, occorre osservare che le raccomandazioni di tale gruppo non vincolano la Commissione, circostanza che peraltro la ricorrente non contesta. Inoltre, la ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della sua scelta di non seguire una siffatta raccomandazione siano viziate da un errore manifesto di valutazione.
225 Infatti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e k), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico devono tener conto del ciclo di vita dell'attività in questione, ma devono anche essere facili da utilizzare e da verificare. La Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che l'integrazione universale degli elementi del ciclo di vita nei criteri fosse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili e della molteplicità delle applicazioni delle plastiche di origine biologica.
226 Orbene, occorre rilevare che il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione nella sua valutazione sul carattere operativo o sulla sufficienza di elementi scientifici e complessi al fine di determinare se era possibile fissare un siffatto criterio di vaglio tecnico e se detto criterio sarebbe stato facile da utilizzare e da verificare.
227 Inoltre, l'argomento della ricorrente vertente sull'esistenza di altri elementi pertinenti o di soluzioni alternative non è idoneo a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione quando ha ritenuto che l'integrazione universale degli elementi del ciclo di vita nei criteri fosse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili e della molteplicità delle applicazioni delle plastiche di origine biologica. Tale errore non può essere dimostrato, in particolare, dalla circostanza, invocata dalla ricorrente, che talune tecnologie consentirebbero l'identificazione e il monitoraggio dei prodotti, tenuto conto del carattere generale di tale affermazione.
228 Del pari, i pochi elementi invocati dalla ricorrente, qui di seguito menzionati, non sono dettagliati né dimostrati nel caso di specie, e non sono quindi sufficienti a rimettere in discussione la valutazione della Commissione secondo cui la fabbricazione di materie plastiche di base doveva essere classificata come attività di transizione, contribuendo sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
229 Anzitutto, l'asserita assenza di riciclaggio delle materie plastiche di origine biologica derivanti dall'acido polilattico non può avere un impatto sull'insieme delle materie plastiche di base, dato che la ricorrente lo invoca peraltro solo a titolo di semplice esempio.
230 Inoltre, anche ammettendo che la percentuale di materie plastiche di origine biologica utilizzate in imballaggi possa essere un elemento pertinente e sufficiente a dimostrare un errore manifesto di valutazione, resta il fatto che tale percentuale non è dimostrata nel caso di specie e che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione fa valere che solo circa la metà della produzione di materie plastiche di base è utilizzata per l'imballaggio.
231 Infine, per quanto riguarda la quantità di terra che, secondo la ricorrente, è necessaria per sostituire le materie plastiche petrolchimiche con materie plastiche di origine biologica, la ricorrente non sviluppa alcun ragionamento che consenta di stabilire un collegamento tra tale argomento e le questioni di cui trattasi.
232 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo.
Sulla terza parte del quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all'obiettivo di utilizzo sostenibile e di protezione delle risorse acquatiche e marine
233 La ricorrente fa valere che, al punto 3.3.2 dell'allegato II della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione per i motivi dedotti nell'ambito della terza parte del terzo motivo, in merito alla fabbricazione di materie plastiche di base.
234 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
235 Occorre anzitutto constatare che la ricorrente si limita a rinviare agli argomenti da essa dedotti nell'ambito della terza parte del terzo motivo e che sono stati respinti in tale contesto (v. supra, punti da 156 a 173).
236 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere la terza parte del quarto motivo e, di conseguenza, detto motivo nonché il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
237 Conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
238 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Repubblica francese, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ClientEarth AISBL sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Costeira
Kancheva
Öberg
Zilgalvis
Tichy-Fisslberger
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025.
Firme



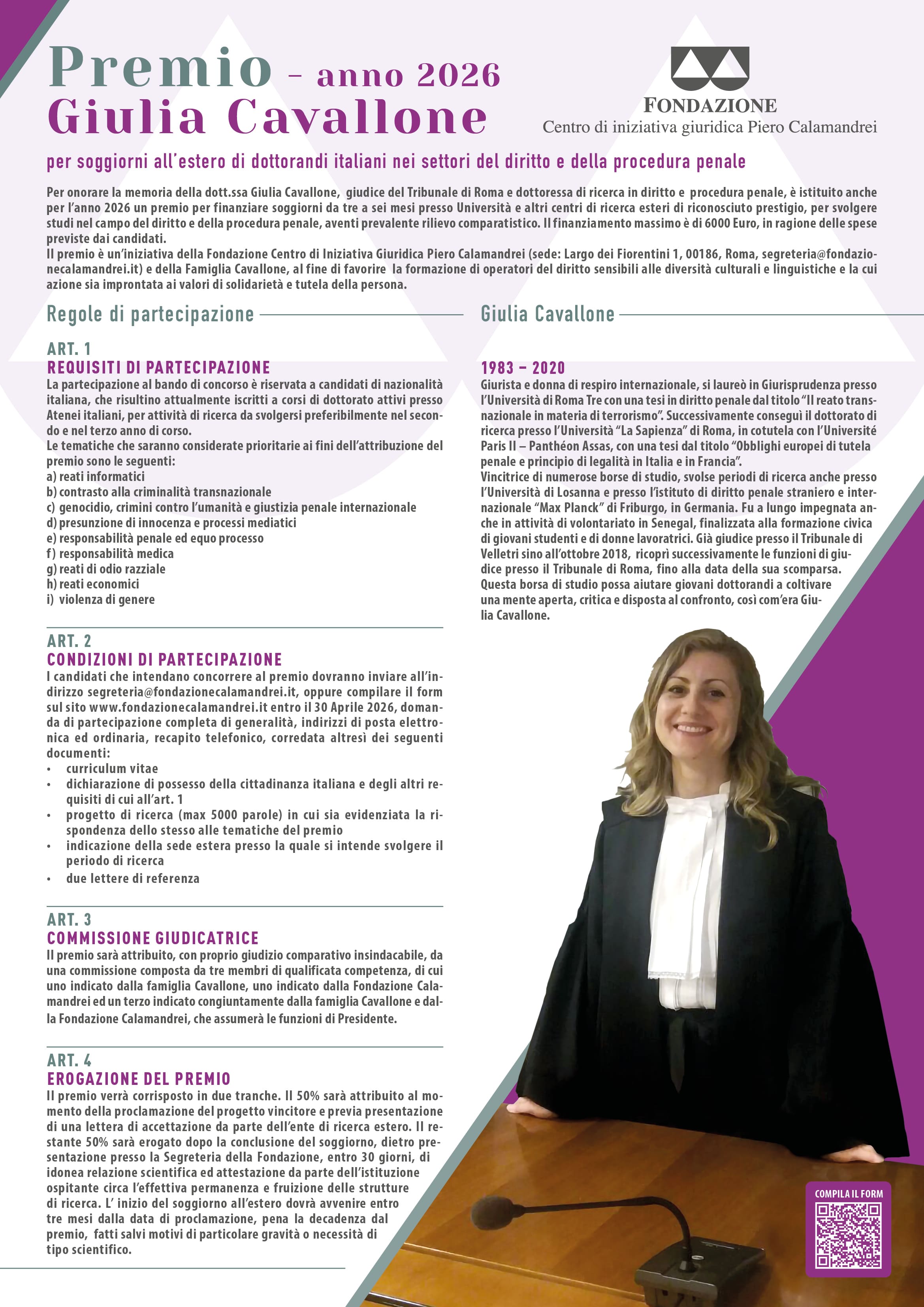 Scarica la locandina
Scarica la locandina