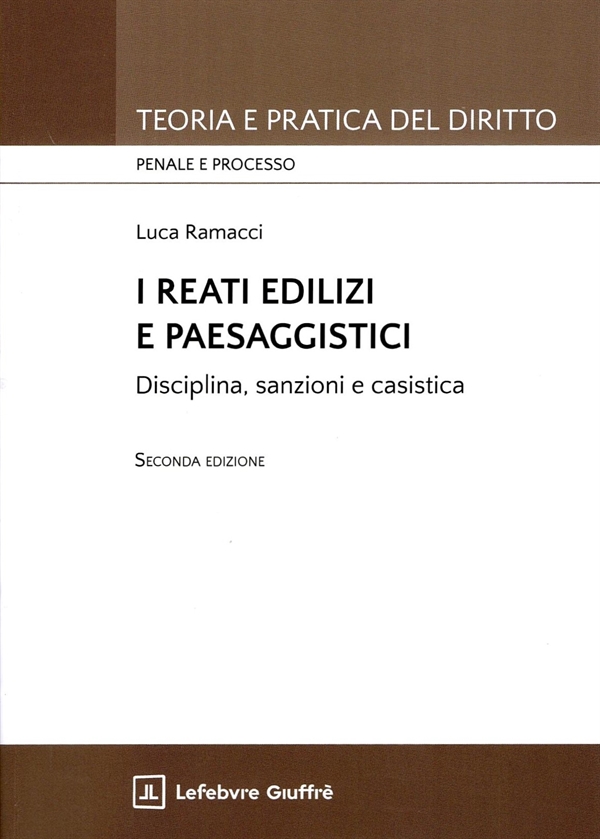ITER DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE E RECEPIMENTO ITALIANO
ITER DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE E RECEPIMENTO ITALIANO
Un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente
di Carlo M. GRILLO
1. Premessa: considerazioni generali (diritto all’ambiente, diritto ambientale e
tutela dell’ambiente)
La ultrasessantenne Costituzione italiana nulla espressamente e direttamente prevede circa la tutela dell’ambiente, interesse a quell’epoca (1947) evidentemente non ritenuto prioritario. Né in proposito è stata adeguatamente aggiornata come le costituzioni di importanti Paesi europei quali: Germania (1994), Belgio (1993), Olanda (1993), Svizzera (1998), Finlandia (2000), Francia (2005).
I giuristi ‘ambientali’ italiani, quindi, pur concordi nell’affermare che il principio deve ritenersi comunque immanente nell’ordinamento nazionale, hanno fatto notevoli sforzi ermeneutici nel corso degli anni per individuare specifiche norme a supporto della tutela dell’ambiente. La stessa definizione di ‘diritto all’ambiente’, in carenza di una definizione normativa di ‘ambiente’, è stata frutto faticoso dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha trovato iniziale conforto e sprone in due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale del 1987 (nn. 210 e 641) e nella sentenza n. 439/1994 della Corte di Cassazione (sez. III pen.).
Si è fatto così ricorso, di volta in volta, alle norme costituzionali che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il paesaggio (art. 9), la salute (art. 32), l’utilità sociale (art. 41).
Solo con la riforma del 2001 il termine ‘ambiente’ è entrato, in punta di piedi, nella Costituzione italiana, con il novellato art. 117, riguardante il riparto delle competenze normative, che riserva la ‘tutela dell’ambiente’ alla legislazione esclusiva dello Stato mentre la ‘valorizzazione dei beni ambientali’ alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, sempre però nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
A testimonianza di questa tardiva ‘presa d’atto’ si ricorda che soltanto nel 1986 l’Italia ha istituito il Ministero dell’Ambiente (ora ‘Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare’).
Del resto anche il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, nonostante sia più giovane di un decennio (1957), concedeva poco spazio alla politica ambientale comunitaria, che mancava in effetti di una specifica base giuridica, tanto da dover fare riferimento agli artt. 2, 100 e 235 di allora. E ciò fino all’Atto Unico Europeo del 1986 (con l’introduzione degli originari artt. 130R, 130S, 130T), in una continua escalation, che ha segnato tappe determinanti a Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001), fino a Lisbona (2007).
Attualmente il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in cui è stato trasfuso il Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1/12/2009), precisato che in materia ambientale l’ Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri (art. 4), dedica all’ambiente un Titolo autonomo (il XX della Parte III - artt. 191, 192, 193), nel quale si evidenzia che l’Unione persegue la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente, anche per proteggere la salute umana, ponendosi l’obiettivo di uno sfruttamento accorto e razionale delle risorse naturali. Pertanto mira ad un elevato livello di tutela della qualità dell’ambiente, recependo il principio di precauzione, affermato per la prima volta dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite (1982), poi fatto proprio dalla Dichiarazione di Rio (1992) e dal Protocollo di Kioto (1997), nonché quelli dello sviluppo sostenibile, dell’azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, di <chi inquina paga>.
Oggi dunque è pacifica l’esistenza, fino a qualche anno fa contestata, di un vero e proprio diritto dell’ambiente, come autonoma disciplina giuridica, comprensivo di tutte le norme nazionali, comunitarie e internazionali che disciplinano, nei vari settori, la materia ambientale.
A livello nazionale, per meglio delineare il terreno in cui il giurista ambientale italiano è tenuto a muoversi, va evidenziato che le molteplici norme protettive dell’ambiente in senso lato (tranne le due recentemente introdotte dal d. l.vo 121/2011) non trovano sede nel codice penale, il cui originario corpo risale al 1930, rimanendo tuttora al di fuori di esso nonostante recenti disegni di legge tragicamente naufragati, ai quali si accennerà in seguito.
Fino a qualche anno fa, i fenomeni di inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque, elettromagnetico, acustico, nonché la tutela del paesaggio, della flora e vegetazione, dei beni culturali, delle aree protette, dell’assetto edilizio ed urbanistico erano disciplinati da autonome leggi, risalenti a tempi e Governi diversi, non armonizzate e coordinate tra loro e talvolta addirittura in parte incompatibili, tanto che non era infrequente il caso di conflitto di norme regolanti la medesima fattispecie, che doveva essere dunque risolto dal giudice.
Nel 2006 finalmente ha visto la luce il Testo Unico Ambientale (decreto legislativo n. 152), col quale il Governo, in forza di un’ampia delega conferitagli due anni prima dal Parlamento e recependo ben otto direttive comunitarie ancora inattuate, ha cercato di riordinare, semplificare, razionalizzare e coordinare buona parte della materia: accorpando disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina in modo da ridurre le ripetizioni; integrando, aggiornando e coordinando previsioni disseminate in testi eterogenei in modo da limitare la stratificazione normativa prodottasi nel corso degli anni; abrogando espressamente oltre trenta disposizioni tra leggi, decreti legislativi, decreti presidenziali e ministeriali. Il TUA non comprende tuttavia - pur senza voler ridimensionare l’innegabile merito del legislatore delegato che è riuscito a vararlo - tante altre materie riguardanti l’ambiente, come quelle dell’inquinamento elettromagnetico ed acustico, della tutela dei beni culturali e del paesaggio, delle aree protette, della flora e della fauna selvatica, dell’edilizia ed urbanistica, delle sostanze che riducono lo stato di ozono stratosferico, delle radiazioni ionizzanti, ecc., per le quali ancora si deve fare riferimento a molteplici leggi complementari disseminate nell’ordinamento nazionale.
A livello comunitario, la strada della tutela penale dell’ambiente non è stata agevole, a partire dalla Convenzione del Consiglio di Europa del 1998, mai entrata in vigore - com’è noto - per il ridotto numero di ratifiche intervenuto. Successivamente, mentre la Commissione europea stava elaborando una proposta di direttiva in materia, veniva emessa - ex artt. 31 e 34 n. 2 lett. b) del Trattato UE - la famosa decisione quadro n. 80/2003/GAI sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, probabilmente ritenendo il Consiglio che una direttiva in tale materia travalicasse le proprie competenze in quanto, avendo efficacia diretta (a certe condizioni) negli ordinamenti nazionali, avrebbe comportato una procedura di infrazione in caso di inottemperanza. A seguito del ricorso da parte della Commissione, che sollevava conflitto di competenza interistituzionale (ex art. 47 TUE), però, nel settembre 2005 la Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione (causa C-176/039), annullava in toto la decisione quadro (analoga decisione quadro, la n. 667/2005/GAI, è stata annullata nell’ottobre 2007 in causa C-440/05), affermando sostanzialmente che la materia ambientale, da considerarsi comunitaria in senso stretto e quindi rientrante nel c.d. primo pilastro, avrebbe dovuto essere disciplinata con direttiva, e non con decisione, tipica del c.d. terzo pilastro quale strumento di coordinamento e di ravvicinamento delle disposizioni nazionali. Per quanto concerne in particolare il diritto penale sostanziale e processuale, la Corte, pur riconoscendo che la materia rientra nella sovranità degli Stati membri, affermava la competenza della Comunità ad adottare provvedimenti “in relazione al diritto penale degli Stati membri” se necessari in funzione strumentale di garanzia per l’effettiva tutela dell’ambiente, aprendo quindi in generale alla possibilità (strumentale) di ‘criminalizzazione comunitaria’ di determinate condotte e inaugurando così una nuova fase del processo di integrazione europea.
2. La direttiva comunitaria: nasce un diritto penale europeo?
Si giungeva pertanto alla direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 (sulla tutela penale dell’ambiente) del Parlamento europeo e del Consiglio che, muovendo dal rilievo che i reati ambientali spesso si estendono oltre i confini degli Stati ove vengono commessi per cui le risposte degli ordinamenti nazionali devono essere almeno in parte condivise, imponeva ai legislatori nazionali di prevedere, in materia ambientale, entro il 26 dicembre 2010 - sia per le persone fisiche che giuridiche (con alcune eccezioni) - sanzioni “efficaci, proporzionali e dissuasive”. Naturalmente dette sanzioni sono qualificate ‘penali’ per le persone fisiche, ma non anche per gli enti, in considerazione della circostanza che in diversi Stati membri, come l’Italia, “societas delinquere non potest”.
Secondo la direttiva, nove condotte ‘illecite’ devono necessariamente essere previste come reati (di ‘danno’ o di ‘pericolo concreto’), sempre che siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, ed anche nei confronti dell’intenzionale favoreggiatore e istigatore. Le condotte illecite riguardano: i rifiuti, le sostanze o radiazioni ionizzanti, gli impianti in cui si svolgono attività pericolose, i materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose, le sostanze che riducono lo strato di ozono, le specie animali o vegetali selvatiche, i siti protetti.
Naturalmente si tratta di norme minimali, nel senso che gli Stati membri ben possono adottare misure più severe per assicurare un’efficace tutela dell’ambiente, purché compatibili col Trattato CE. Tale disposizione in effetti anticipa l’art. 193 TFUE, che prevede la notifica alla Commissione europea dei provvedimenti nazionali di ‘maggiore protezione’.
Da un esame delle condotte illecite elencate dalla direttiva, anche se detta elencazione non ha mancato di suscitare qualche perplessità, si evince che la rilevanza penale deve rimanere circoscritta ai comportamenti concretamente pericolosi o dannosi per la risorsa ambientale o per l’integrità fisica dell’uomo, mentre alle violazioni formali (o burocratiche) deve essere riservata evidentemente l’area dell’illecito amministrativo.
Questa direttiva, intervenuta prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha riproposto il tema dell’esistenza di un ‘diritto penale europeo’, di cui gli studiosi già discettavano, pur consapevoli dei limiti fissati in materia dalla Comunità.
E’ innegabile, infatti, che molte decisioni quadro riguardano il diritto penale sostanziale, individuando fattispecie criminose da perseguire; così, ad esempio, la 2002/457/GAI in materia di terrorismo, la n. 2002/626/GAI sulla tratta di esseri umani, la 2003/568/GAI in tema di corruzione, la 2004/68/GAI su sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile; ed altre ancora.
In definitiva, in linea con alcune importanti decisioni della CGCE (si ricorda in proposito anche: CGCE, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, C 5440/05, in tema di tutela penale dell’ambiente marino dall’inquinamento navale), si è prevalentemente ammesso, pur non trovando questa posizione compromissoria valido aggancio normativo, che le direttive possono descrivere le fattispecie e richiedere che siano sanzionati penalmente i fatti da esse descritti, ma non spingersi fino ad indicare la tipologia e l’entità delle pene, anche se ne possono valutare la congruità. Infatti l’influenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ha cominciato a manifestarsi incidendo sugli elementi costitutivi della fattispecie penale, come è avvenuto - ad esempio - in materia ambientale, con riferimento alla nozione di ‘rifiuto’, per poi passare al riconoscimento della possibilità di sindacare le scelte penalistiche dei singoli Stati, valutando se le sanzioni, comminate a protezione di determinati beni giuridici, siano “efficaci, proporzionali e dissuasive”.
Nell’ambito della Cooperazione giudiziaria in materia penale (Titolo V, Capo IV del TFUE), è specificamente prevista l’adozione di norme minime sia in materia procedurale, sia con riguardo proprio al diritto penale sostanziale. Per quanto concerne questo, l’art. 83 riconosce la possibilità al Parlamento europeo e al Consiglio di definire reati e sanzioni in determinate sfere di criminalità particolarmente grave e di dimensione transnazionale. Dieci i settori presi in considerazione: terrorismo; tratta degli esseri umani; sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica; criminalità organizzata.
La disposizione - che ritengo di estremo interesse, potendo in futuro toccare anche la materia ambientale - consente inoltre al Consiglio europeo (all’unanimità e previa approvazione del Parlamento), ‘in funzione dell’evoluzione della criminalità’, di individuare ulteriori settori di intervento. E’ prevista poi, se appare indispensabile il ravvicinamento degli ordinamenti per garantire l’efficace attuazione di una politica dell’ EU in un campo già oggetto di misure di armonizzazione, la possibilità di adottare, tramite direttive, ‘norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione’.
Completa il quadro l’art. 84 del Trattato, che riconosce al Parlamento e al Consiglio, a prescindere da qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari, la facoltà di stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità.
Alla luce di quanto precede, ritengo che ormai si possa legittimamente e a ragione parlare di un diritto penale europeo, nonostante gli argini costituzionali degli Stati membri.
3. Normativa interna di recepimento
Tornando alla direttiva 2008/99/CE, essa - come si è detto - doveva essere attuata dagli Stati membri, entro il 26 dicembre 2010, termine abbondantemente superato dall’Italia, che lo ha fatto solo con il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121. E’ singolare che la stessa legge delega (l. n. 96/2010 – legge comunitaria 2009) stabiliva, per il recepimento della direttiva, il termine del 9 aprile 2011 (nove mesi dall’entrata in vigore della legge), già successivo quindi a quello prescritto. Ma, due giorni prima della scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri si limitava ad approvare uno schema di decreto legislativo, riservandosi di acquisire i prescritti pareri, per cui si giungeva in porto solo nel luglio successivo, e cioè dopo oltre un semestre dalla scadenza del termine stabilito dalla direttiva e dopo una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea del gennaio 2011.
Ma, a parte tale evidente sfasatura e prima di esaminare il contenuto del decreto legislativo n. 121/2011, ci si deve chiedere come abbia operato in materia il legislatore nazionale nel periodo intercorrente tra l’emanazione della direttiva e il suo recepimento.
Ebbene, tre dei cinque correttivi sostanziali del Testo unico ambientale del 2006 (decreti legislativi 128/2010, 205/2010, 219/2010), come del resto altre norme integratrici del TUA, in quanto successivi alla menzionata direttiva, avrebbero dovuto comunque tenerne conto benché non fosse stata ancora recepita, ma non lo hanno fatto in maniera adeguata. Invero, anche dopo il menzionato triplice intervento legislativo del 2010 (anzi quadruplice, se si considera la l. n. 36/2010, relativa alla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue), ed altri di minore portata, sono rimasti sempre e solo sei i ‘delitti’ ambientali previsti dal nostro ordinamento. E tutti relativi ai rifiuti. La maggior parte delle condotte illecite indicate dalla direttiva - riguardanti radiazioni ionizzanti, impianti per attività pericolose, materiali nucleari e sostanze radioattive, sostanze che riducono lo stato di ozono – non risulta essere stata disciplinata ex novo in ottemperanza alla stessa.
La situazione, sotto tale punto di vista, non può dirsi migliorata neppure per effetto del decreto legislativo di recepimento de quo, che si è limitato ad introdurre nel codice penale due nuove fattispecie incriminatrici (gli artt. 727 bis e 733 bis), sempre di natura contravvenzionale, riferite - la prima - all’uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, e - la seconda - al danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto.
Sotto altro profilo, invece, appare di indubbio rilievo l’introduzione, nel decreto legislativo n. 231/2001, dell’art. 25 undecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che in relazione alle due nuove contravvenzioni codicistiche, a numerose altre fattispecie di reati ambientali, previste sia dal TUA (Testo Unico Ambientale) che da varie normative speciali, comminando sanzioni pecuniarie amministrative (quantificate in quote) nonché sanzioni interdittive temporanee, fino alla interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, per le aziende utilizzate in maniera stabile (‘scopo unico o prevalente’) per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti.
Com’è noto il decreto legislativo 231/2001, attuativo della delega conferita con l. n. 300/2000, pur senza vulnerarlo, ha tuttavia inferto un duro colpo al principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 Cost., introducendo nel nostro ordinamento giuridico la ‘responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato’, e così sostanzialmente ampliando il concetto di responsabilità connessa ad un illecito penale. La peculiarità della normativa in questione è quella di essere, per quanto concerne la individuazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, come un contenitore che di anno in anno va sempre più riempiendosi. Dai due originari articoli (24 e 25) si è ormai giunti a diciassette articoli, con altrettante categorie di reati presupposto; ben sedici, infatti, le disposizioni normative (leggi e decreti legislativi) che dal 2001 al 2012 hanno rimpinguato la specifica sezione del decreto. Del resto l’indicazione dei reati presupposto non può che essere tassativa, in ossequio al principio di legalità (art. 2 d. l.vo 231/2001), di cui quello di determinatezza della fattispecie vietata è un corollario. Ormai anche la rubrica della Sezione III - Capo I del decreto non è più corretta, facendo riferimento a ‘reati previsti dal codice penale’, mentre gli attuali reati presupposto sono contenuti anche nel codice civile (reati societari, corruzione tra privati) o in leggi speciali (T.U. finanze, T.U. ambiente, terrorismo ed eversione, diritto d’autore, immigrazione).
4. Criticità
Attualmente, lo si ripete, ad eccezione delle sei ipotesi delittuose relative alla materie dei rifiuti, tutte le altre violazioni previste dalla normativa ambientale nazionale hanno natura contravvenzionale o semplicemente amministrativa.
Si può allora affermare che l’ordinamento italiano prevede, nei settori di intervento indicati dalla direttiva, sanzioni “efficaci, proporzionali e dissuasive”? E che siano egualmente perseguite le condotte degli intenzionali favoreggiatori e istigatori, nonché delle persone giuridiche?
Per quanto concerne le condotte di favoreggiamento o istigazione, il diritto penale interno è adeguatamente ‘attrezzato’; infatti prevede il favoreggiamento reale (art. 379) e l’istigazione a delinquere (art. 414) come autonomi delitti, in relazione a qualsiasi reato, quindi anche contravvenzionale, per cui non crea difficoltà la loro configurazione in relazione ai reati ambientali. Così pure completa disciplina trovano tutte le ipotesi di concorso o compartecipazione criminosa (art. 110 e seguenti).
Anche sotto il profilo del coinvolgimento delle persone giuridiche nei reati ambientali, non si rilevano particolari problemi, in quanto l’art. 25 undecies, innestato nel corpo del d. l.vo 231/2001, appare abbastanza completo, inserendo tra i reati presupposto, oltre alle due contravvenzioni codicistiche di recente creazione, varie categorie di illeciti riguardanti le materie dei rifiuti, delle acque, dell’aria, della bonifica dei siti, dell’ozono stratosferico, delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dell’inquinamento provocato dalle navi.
Con riferimento, invece, al rigorismo sanzionatorio cui è finalizzata questa direttiva - anche se resta ancora da dimostrare l’assioma secondo cui il mero inasprimento delle pene determini una maggiore efficacia del precetto - si ritiene che l’attuazione della stessa avrebbe dovuto comportare, come si è detto, una previsione più numerosa di delitti, giacché le contravvenzioni difficilmente possono far fronte alle esigenze di un elevato livello di tutela dell’ambiente, cui la politica comunitaria deve mirare. Sotto tale profilo mi sento quindi di affermare, senza tema di smentita, che si poteva e si doveva fare di più: la politica criminale italiana non è ancora in linea con i dettami europei, prevedendo tuttora sanzioni abbastanza blande, conseguenza della natura contravvenzionale di quasi tutti i reati ambientali.
Com’è noto, le pene detentive (reclusione/arresto) e quelle pecuniarie (multa/ammenda), rispettivamente previste per i delitti e per le contravvenzioni, aldilà della diversa denominazione, sono tra loro profondamente differenti anche sotto molteplici aspetti sostanziali, che non è il caso di approfondire in questa sede. Basti pensare solo al diverso tempo di prescrizione, alla configurabilità del tentativo punibile (escluso per le contravvenzioni), alla possibilità dell’oblazione (esclusa per i delitti), alle conseguenze sulla recidiva e sulle misure di sicurezza, ecc.. Addirittura le pene della reclusione e dell’arresto, a parte altri aspetti, pur avendo entrambe natura detentiva, devono essere scontate con modalità e in stabilimenti diversi.
La differente tipologia di pena, però, non è l’unico né il principale elemento distintivo tra delitti e contravvenzioni, che invece deve individuarsi nel diverso grado di offensività o lesività attribuito dal legislatore alle condotte illecite che ritiene di inquadrare in questa o in quella categoria, richiedendosi peraltro - per la configurabilità dei delitti - la intenzionalità della commissione (o omissione) del fatto da parte dell’agente, mentre - per le contravvenzioni - la sola condotta colposa (negligente, imprudente, imperita o violatrice di norme).
Per tale ragione lo stesso comportamento potrebbe, in un determinato contesto storico-sociale-politico-culturale, concretare un delitto e, in un altro, una contravvenzione. E’ infatti sempre e comunque una scelta ‘politica’ la qualificazione del reato; e questo è molto importante anche in relazione alla materia dei reati ambientali, di cui trattiamo. La via imboccata dal legislatore nazionale è purtroppo rivelatrice dell’interesse riservato oggi in Italia alla tutela dell’ambiente.
Ma aldilà della opzione sanzionatoria, deve rilevarsi che i delitti indicati dalla direttiva comunitaria 99/2008 (per la commissione dei quali si richiede dolo o colpa grave dell’agente) sono configurati come reati di danno (o di pericolo concreto) e quindi esigono un’effettiva compromissione (o minaccia) delle risorse ambientali o dell’integrità fisica delle persone, mentre le contravvenzioni previste dall’ordinamento interno sanzionano generalmente violazioni formali, norme comportamentali (quali, ad esempio, il superamento di valori limite per determinate emissioni o l’esercizio di un’attività senza autorizzazione) sovente sganciate da un danno e anche solo dal pericolo, poste dall’ordinamento proprio per evitare eventi dannosi. Sarà pertanto, in concreto, molto più ardua per la giustizia inquirente la dimostrazione della sussistenza dei delitti ambientali, così come configurati dalla direttiva, dovendo sempre essere provato il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento, e quindi, ad esempio, tra un determinato sversamento o abbandono di rifiuti ed un ‘rilevante’ vulnus per l’ambiente. Soprattutto perché l’offesa ad alcuni beni si realizza per effetto di condotte ripetute nel tempo e non di un singolo comportamento, che potrebbe in ipotesi anche non essere dannoso o pericoloso. In definitiva si potrebbe correre il rischio di sentirsi più armati, disponendo di un sistema sanzionatorio più rigoroso, ma di essere in concreto meno efficaci, e dunque meno dissuasivi, potendosi accertare più difficilmente la colpevolezza dei trasgressori ed affermarne la penale responsabilità.
Un altro ostacolo all’attuazione della direttiva “ecocrime” a livello nazionale è rappresentato dal principio di legalità sotto lo specifico profilo della tassatività/determinatezza dell’illecito penale. Infatti già il legislatore italiano in materia di ambiente non è mai stato tanto rispettoso del detto principio, facendo spesso ricorso a locuzioni vaghe e generiche, quali “scarichi potenzialmente pericolosi”, “rischio inaccettabile per la salute pubblica”, “ingente quantitativo”, “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, e numerose altre che rendono indispensabile (e non sempre agevole) l’opera di mediazione del giudice. Con la direttiva in esame, che peraltro prescrive sanzioni molto più severe, i problemi di indeterminatezza non vengono risolti ma forse aggravati, venendo utilizzate espressioni quali: “danni rilevanti” per le risorse ambientali; “deterioramento significativo” delle stesse ovvero di un habitat; “quantità non trascurabili” di rifiuti; “quantità trascurabili” di esemplari di specie animali o vegetali. Si resta dunque nel campo del vago, pur consci che, quanto più le norme sono caratterizzate da indeterminatezza, tanto maggiore è il margine di discrezionalità che deve riconoscersi all’interprete, con il conseguente prevedibile rischio di rilevanti oscillazioni ermeneutiche che vulnerano l’esigenza di certezza dei cittadini, per cui - alla fine - è l’intero sistema repressivo in materia ambientale che risulterà indebolito da questa crisi di legalità.
A ben guardare, però, esiste - a mio avviso - il rimedio giuridico per tentare di sopperire, da parte dell’interprete, a tale indeterminatezza del precetto: integrarlo in ogni caso col relativo disposto delle 61 direttive e degli 8 regolamenti indicati nell’ Allegato A (alla direttiva 2008/99/CE in questione), contenente la lista della legislazione comunitaria da cui desumere le violazioni costituenti ‘atti illeciti’ ai sensi dell’art. 2 della direttiva stessa.
5. Conclusioni
In estrema sintesi, ritengo che l’Italia non abbia finora attuato congruamente la direttiva 2008/99/CE. Del resto è quanto osservava la stessa Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato al Governo del d. l.vo 121/2011, in cui veniva evidenziato che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge delega, l’adeguato recepimento della direttiva in questione avrebbe dovuto costituire oggetto di un successivo intervento normativo, che doveva essere necessariamente preceduto da un completo ripensamento e riordino dell’intera materia dei reati ambientali. Evidentemente la ‘colpa’ è proprio del Parlamento che con la menzionata Legge comunitaria 2009 ha posto dei paletti che hanno lasciato spazi troppo angusti al legislatore delegato, donde il rinvio del problema ad un successivo (ed auspicabilmente prossimo) intervento normativo. Certo tutt’altra cosa era il disegno di legge delega per la riforma dei reati in materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri italiano nell’aprile 2007, e purtroppo naufragato nei flutti della politica, che sostanzialmente anticipava la direttiva 2008/99/CE. Infatti, allineandosi ad altri Paesi europei (come Spagna, Austria, Germania) che hanno da tempo introdotto la materia ambientale nei rispettivi codici penali, con questa legge l’Italia si proponeva di inserire nel vecchio codice penale del 1930 il Titolo VI bis “Dei delitti contro l’ambiente”, comprendente una decina di ipotesi delittuose punite con pene detentive anche severe, come per esempio nel caso dei reati di ‘disastro ambientale’ o ‘associazione a delinquere per commettere reati contro l’ambiente’. A tal proposito deve considerarsi che il reato di associazione a delinquere attualmente previsto dal nostro codice è ipotizzabile solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni, per cui non può quasi mai configurarsi in relazione alle violazioni di natura ambientale, a meno che reato-fine sia uno di quei sei delitti sopra ricordati. Eppure il fenomeno delle c.d. ecomafie, sorto alla fine degli anni ’80 quando la criminalità organizzata decide di passare dai delitti ‘strutturali’ (omicidi, estorsioni, usura, traffico di droga, sfruttamento della prostituzione, ecc.) a quelli ‘silenziosi’, è una realtà incontestabile nell’Italia di oggi, tanto che viene valutato - come risulta dagli ultimi rapporti annuali di ‘Legambiente’ - in circa venti miliardi di euro il relativo business gestito, con riferimento soprattutto al ciclo dei rifiuti e del cemento (abusivismo edilizio). E sempre più labile appare il confine tra legalità e illegalità.
A questo punto la speranza in tempi migliori, per una maggiore attenzione ai temi dell’ambiente da parte del legislatore nazionale, è d’obbligo!



 Scarica la locandina
Scarica la locandina