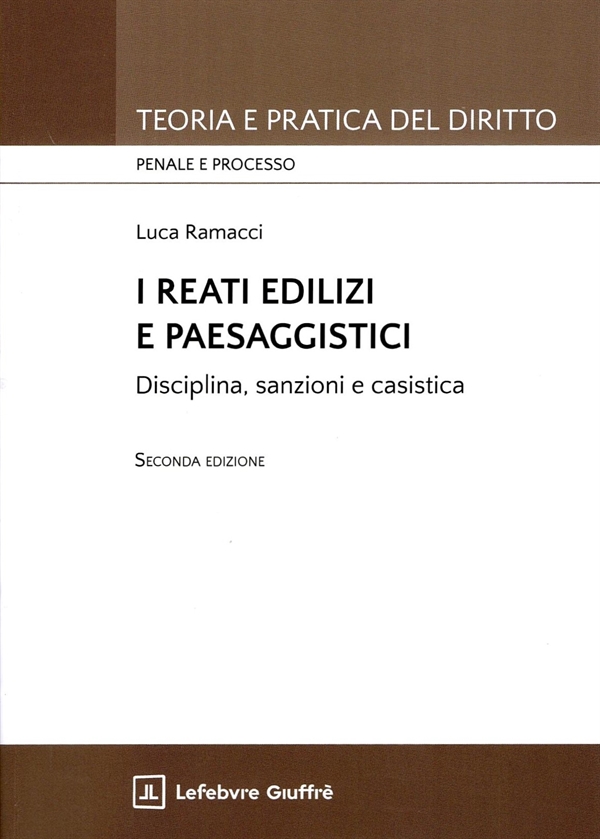Cass. Sez. III n. 9052 del 6 marzo 2020 (PU 21 gen 2019)
Cass. Sez. III n. 9052 del 6 marzo 2020 (PU 21 gen 2019)
Pres. Liberati Est. Mengoni Ric. Groza
Rifiuti.Cessione a titolo oneroso del rifiuto e mantenimento di tale condizione
La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006), non viene certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l’oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell’ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/7/2019, il Tribunale di Catanzaro dichiarava Nicolae Ciprian Groza colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di 4.000,00 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver effettuato attività di trasporto di rifiuti non pericolosi (materiale ferroso e plastica) in mancanza della prescritta autorizzazione.
2. Propone ricorso per cassazione il Groza, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- violazione ed errona applicazione dell’art. 256 contestato, in relazione all’art. 3, punto 1, direttiva 2008/98/CE; omessa applicazione dell’art. 184-ter, d. lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale non avrebbe considerato che il materiale ferroso trasportato dal ricorrente non costituirebbe rifiuto in senso tecnico, avendo un discreto valore economico e costituendo l’oggetto dell’attività dei cd. “ferraioli”; l’imputato, peraltro, non avrebbe avuto alcuna intenzione od obbligo di disfarsene, volendo, piuttosto, vendere il prodotto e ricavarne un guadagno. Quand’anche, poi, l’art. 3, punto 1, della citata direttiva si dovesse riferire agli originari detentori, le considerazioni del Tribunale in punto di rifiuto costituirebbero mere congetture, inidonee a supportare una decisione di condanna. Da ultimo sul punto, si rileva che, dopo le modifiche del 2010, perché un materiale possa sfuggire alla qualifica di rifiuto non è neppure necessario che abbia una valore economico, come in questo caso, risultando sufficiente l’esistenza di un mercato o di una domanda al riguardo;
- omessa motivazione su punto decisivo, con violazione di legge. La sentenza non conterrebbe alcun passaggio con riguardo ad un profilo essenziale della previsione, quale la reiterazione – e non occasionalità - della condotta illecita, invero necessaria per poter configurare il delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la sentenza impugnata, infatti, contiene una motivazione del tutto adeguata con riguardo ai profili dedotti, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e coerente con la costante giurisprudenza in materia. Come tale, dunque, non censurabile.
4. In particolare, è stata innanzitutto riscontrata la qualifica di rifiuto propria del materiale ferroso in sequestro, e ciò in forza di elementi di fatto che la stessa impugnazione non contesta: le condizioni di deterioramento del prodotto, le modalità di trasporto, il quantitativo molto consistente (450-500 kg., per circa 9 mc. di volume), in uno con la natura dello stesso, hanno congruamente condotto il Giudice a concludere che “il materiale in questione costituisca scarto di autovetture di cui i proprietari si erano già prontamente disfatti e, quindi, rifiuti ad ogni effetto.”
5. Nei medesimi termini, poi, la sentenza ha escluso – poiché non provata – un’eventuale attività “di commercio, intermediazione e smaltimento” che il ricorrente avrebbe eseguito sul medesimo prodotto, evidenziandone il carattere ipotetico o solo meramente ventilato; quel che, peraltro, ben emerge anche dal ricorso in esame, nel quale la qualifica di “ferraiolo” è attribuita al Groza senza alcun supporto probatorio.
6. In ogni caso, ed in ciò ulteriormente si apprezza la pronuncia impugnata, il Tribunale ha sottolineato che quand’anche il materiale in esame avesse avuto davvero un valore economico, potesse esser compravenduto e ciò costituisse il fine (non provato) dell’attività del Groza, non se ne potrebbe comunque escludere la qualifica di rifiuto, una volta acquisita. Al riguardo, infatti, deve ribadirsi il costante e condiviso indirizzo in forza del quale la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l’oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell’ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica; d’altronde, come già sostenuto da questa Corte (Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, Zantonello, non massimata; Sez. 3, n. 15447 del 20/1/2015, Napolitano, non massimata), nell’indagine in esame – volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto - si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene.
7. Opinare in termini diversi, al pari del ricorrente, comporterebbe dunque la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già “a monte” acquisita.
Dal che, l’inconferenza del richiamo, nel corpo del ricorso, alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 ed agli artt. 184-bis e 184-ter, introdotti nel d. lgs. n. 152 del 2006 dal d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Come infatti ben sostenuto nella sentenza impugnata, e sopra richiamato, l’eventuale recupero o riutilizzo del prodotto ad opera del Groza ha costituito una mera illazione sprovvista di prova, alla quale il ricorso non ha fornito alcun elemento di fatto ulteriore, eventualmente lamentandone l’offerta al Tribunale e la mancata o viziata valutazione.
8. Da ultimo, osserva il Collegio che anche il secondo motivo di impugnazione risulta del tutto infondato.
Questa Corte ha più volte sostenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, in esame, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (tra le molte, Sez. 3, n. 8193 dell’11/2/2016, Revello, Rv. 266305); ipotesi, quest’ultima, che la sentenza ha ancora congruamente escluso, sottolineando il considerevole quantitativo di materiale trasportato (sopra richiamato), che rende evidente la sussistenza di una preliminare attività di raccolta o, comunque, di ricezione del materiale da parte dell’imputato. Ben altro, quindi, rispetto ad un’attività meramente occasionale, del tutto sprovvista di un minimum di organizzazione.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020