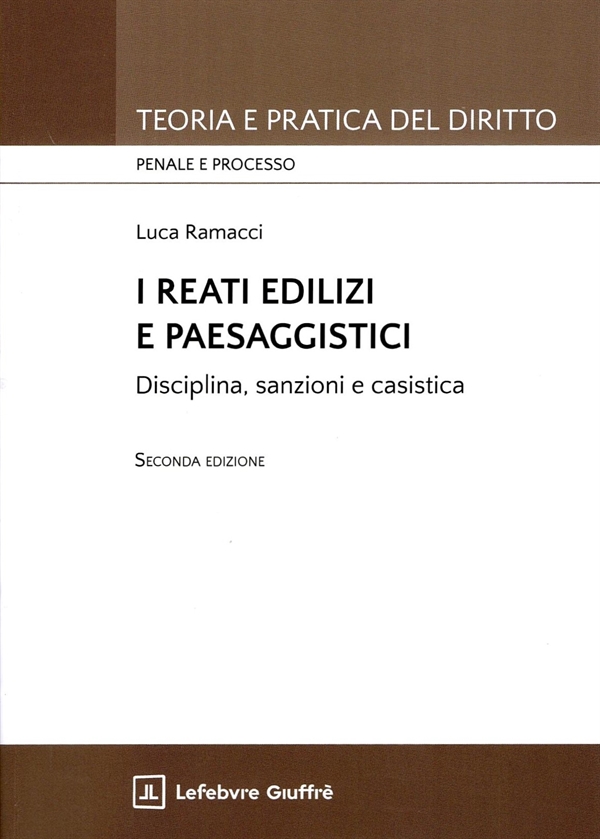Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss d. leg. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita
Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss d. leg. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita
di Vincenzo PAONE
la sentenza in commento è pubblicata qui: Ambiente in genere. Procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale
I. Con la sentenza n. 36405 del 18 aprile 2019-dep. 26 agosto 2019, imp. Rossello, la Cassazione è intervenuta sul tema se la procedura di estinzione prevista dagli artt. 318 bis ss d. leg. 152/06 sia applicabile anche alle condotte cd. “esaurite”.
Il problema presenta molteplici sfaccettature ( 1 ) che tra breve analizzeremo per dimostrare l’erroneità della decisione che si commenta.
Prima di tutto, occorre ricordare che la l. 22 maggio 2015 n. 68 ha esteso alle contravvenzioni previste nel d.leg. n. 152/06 la disciplina che il d.leg. 19 dicembre 1994 n. 758 aveva predisposto per le contravvenzioni relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro.
Recita l’art. 20, 1° comma, cit. dec. che «Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario».
Al di là del non precipuo termine utilizzato («eliminare» la contravvenzione), è evidente che attraverso la prescrizione impartita dall’organo di PG, in occasione dell’accertamento della violazione ad una delle norme in tema di sicurezza su lavoro, si interviene per ottenere la “regolarizzazione” della situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata al fine di ripristinare la legalità violata mediante un comportamento «virtuoso» da parte del trasgressore.
Pertanto, l’emanazione della prescrizione è l’aspetto centrale e peculiare del procedimento che sfocia nell’estinzione del reato sicchè dovrebbe ritenersi conseguenziale che l’istituto sia precluso allorchè non vi sia nulla da regolarizzare né sotto il profilo di una condotta illecita ancora in atto né sotto il profilo degli eventuali effetti, derivanti dal reato, suscettibili di eliminazione.
Come è noto, la disciplina originaria è stata «integrata» da un intervento della Corte costituzionale: si tratta della sentenza 18 febbraio 1998, n. 19 originata da tre ordinanze con le quali era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, 1° comma, d.leg. n. 758/94 per violazione l’art. 3 Cost., "nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l’autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione", o "abbiano regolarizzato la violazione nonostante l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l’abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste".
Nelle ordinanze di remissione, si assumeva essere privo di ogni razionale giustificazione riservare al contravventore, che avesse spontaneamente e autonomamente regolarizzato la violazione prima che l’organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione di cui all’art. 20 d.leg. n. 758/94, ovvero quando tale organo sia intervenuto, ma avesse omesso di impartire le prescrizioni o le avesse impartite senza osservare le forme stabilite dalla legge, un trattamento deteriore rispetto alla posizione di chi aveva tenuto il medesimo comportamento a seguito dell’apposita prescrizione dell’organo di vigilanza.
Ecco i passi salienti della sentenza n. 19:
«La nuova normativa mira, cioé, da un lato ad assicurare l’effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l’interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, é di gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale, dall’altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale…
…Da tale complesso normativo emerge che entrambe le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell’organo di vigilanza: anzi, é plausibile e ragionevole sostenere che a maggior ragione dovrebbe essere ammesso alla definizione in via amministrativa, in vista dell’estinzione del reato e della conseguente richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, a nulla rilevando che la notizia del reato sia stata inoltrata da un’autorità di polizia giudiziaria diversa dall’organo di vigilanza…
…Appare infatti che le "lacune" segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dall’obiettiva difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa. Pertanto, é senz’altro possibile un’applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un’autorità di polizia giudiziaria diversa dall’organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l’organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall’art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonchè a verificare l’avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell’art. 21, commi 1 e 2, sì che l’autore dell’illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell’estinzione del reato disciplinata dall’art. 24».
Riservando al prosieguo la riflessione sulla ratio che la Corte costituzionale ha individuato nella normativa del 1994, evidenziamo che, nonostante il preciso contenuto della decisione n. 19, la successiva giurisprudenza ordinaria in materia di sicurezza sul lavoro ha ritenuto applicabile la procedura di estinzione anche in presenza di condotte comunque “esaurite”.
Ad inaugurare questo «filone» è stata la sentenza n. 34900 del 6/06/2007, Rv. 237198, PM. in proc. Loi, secondo cui, atteso, il disposto dell'art. 15, 3° comma, d.leg. 23 aprile 2004 n. 124, la procedura di estinzione trova applicazione anche quando si tratta di reati istantanei già perfezionatisi o di già avvenuta, spontanea regolarizzazione delle pregresse violazioni.
In motivazione, si legge che «…l’art. 15, comma 3, dispone che la procedura… si applica anche: a) nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero; b) nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione…Risulta quindi che, a seguito della modifica legislativa, è ormai superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg., nelle ipotesi di reati istantanei già perfezionatisi (sez. 3^, 4 novembre 2005, n. 47228, Greco, m. 233190)...La finalità dell'istituto, infatti, non può più essere individuata solo nello scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori (cfr. sez. 3^, 4 novembre 2005, n. 47228, Greco, cit.), ma altresì in quello di permettere in via generale l'estinzione amministrativa del reato, anche quando non vi sono regolarizzazioni da effettuare perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione è già spontaneamente avvenuta».
La sentenza Loi è stata seguita da Cass. n. 34750 del 3/05/2011, Rv. 251229, Costantini; n. 37228 del 15/09/2015, Rv. 268050, Eheim e n. 2257 del 5 ottobre 2017, Climinti, inedita.
II. La l. n. 68/2015 ha recepito le norme portanti costituenti la disciplina del 1994 sicchè, per quanto non espressamente previsto, si possono estendere le acquisizioni cui è pervenuta la giurisprudenza in tema di sicurezza sul lavoro. Tra queste, il meccanismo c.d. «ora per allora» elaborato dalla Corte costituzionale nel 1998 e perciò applicabile – nelle congrue situazioni – anche alle contravvenzioni contenute nel d.leg. n. 152/06.
Siamo giunti al punctum dolens: infatti, il meccanismo c.d. «ora per allora» è applicabile soltanto quando la regolarizzazione dell’illecito sia avvenuta grazie al comportamento attivo e volontario del contravventore antecedente all’accertamento dell’illecito da parte dell’organo di vigilanza o si applica a qualsiasi condotta esaurita, indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato l’esaurimento della condotta?
La Cassazione ha optato per questa seconda soluzione.
Peraltro, poiché dalla sentenza non risulta il caso concreto in relazione al quale è stata risolta la questione, giova segnalare che nella specie era stato contestato il reato di cui all’art. 256, 4° comma, d.leg. n. 152/06 perché l’imputato, nel corso dell’attività di gestione di rifiuti, aveva superato i quantitativi autorizzati. Come si vede, la violazione rientra tra quelle istantanee da cui non derivano ulteriori effetti antigiuridici passibili di rimozione.
Orbene, la Corte Suprema ha sostenuto che «Deve, infatti, ritenersi che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 318 bis e ss del d.lgs. n. 152 del 2006 si applichi tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso. L'assunto in questione trova decisivo fondamento nell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede l'applicazione della procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 756 del 1994 «alle condotte esaurite, ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione». Ed è chiaro che la disposizione in esame identifica due condotte alternative, alle quali è parimenti possibile applicare la procedura estintiva in esame».
Dato che il richiamo all’art. 15 d.leg. n. 124/04 è decisivo nel pensiero della Corte (giacchè in mancanza di siffatta disposizione i termini della questione si sarebbero ridotti al prendere atto che l’art. 318 d.leg. n. 152/06 nulla dice sul punto specifico e che, al più, si poteva integrare la disposizione alla luce del dictum della Corte cost.) evidenziamo che i principale profili problematici sono i seguenti:
- l’art. 15 d.leg. n. 124/04 ha portata innovativa o meramente ricognitiva: la sentenza n. 36405, a pag. 5, ha sostenuto che «…deve rilevarsi che la pronuncia in questione (la pronuncia della Corte cost. n. 19/1998: ndr) è precedente all'introduzione dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, con cui il legislatore ha espressamente disciplinato l'oggetto della questione posta all'attenzione della Corte in un senso comunque non contrastante con la sentenza richiamata. La stessa, infatti, non ha inteso escludere l'applicabilità delle procedure estintive alle condotte esaurite diverse dallo spontaneo ravvedimento operoso del contravventore, ma, in risposta all'unico petitum proposto, si è legittimamente limitata a riconoscere l'applicabilità della procedura di estinzione prevista a favore del soggetto che si sia conformato alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza anche a queste ultime ipotesi».
- l’art 15 d.leg. n. 124/04 si estende «automaticamente» alla procedura di cui all'art. 318 d.leg. n. 152/06: al riguardo la Cassazione ha affermato che «la procedura di estinzione prevista dal testo unico sull'ambiente è, infatti, costruita sul medesimo meccanismo previsto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 758 del 1994, e, dunque - come segnalato anche dal ricorrente - ne segue l'interpretazione».
Orbene, la tesi che l’art. 15 abbia innovato l’ordinamento, introducendo l'applicabilità della procedura estintiva anche alle condotte esaurite tout court, non ci pare sostenibile.
Nel 2004 il legislatore aveva davanti a sé il quadro normativo e giurisprudenziale prima illustrato sicchè è poco verosimile che sia stata compiuta la scelta radicale propugnata dalla Cassazione.
Vi è di più: la sentenza ha sottovalutato che, successivamente alla sentenza n. 19/98, la stessa Corte costituzionale è stata investita in più occasioni proprio della tematica concernente i reati con condotta esaurita.
Infatti, con diciotto ordinanze di analogo tenore era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, 2° comma, d.leg. n. 758/94 nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione.
Nella maggior parte delle ordinanze di rimessione, il giudice a quo aveva infatti precisato che l'organo di vigilanza non aveva impartito alcuna prescrizione a norma dell'art. 20 in quanto si trattava di “reato già consumato e non ottemperabile”, mentre in altre ipotesi l'impossibilità di impartire la prescrizione era stata ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non poteva essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata, ovvero a reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiuridica che aveva dato origine alla violazione contestata. Al riguardo, il rimettente aveva rilevato che nella fattispecie in esame era materialmente impossibile per l'organo di vigilanza impartire una prescrizione finalizzata all'eliminazione della contravvenzione accertata, «trattandosi di reato istantaneo caratterizzato da un'offesa del bene protetto che si perfeziona e si esaurisce nel momento della commissione del fatto, senza protrarsi nel tempo, sicchè risulta ontologicamente impedita qualsiasi possibilità di regolarizzazione e la conseguente emanazione di una prescrizione non avrebbe alcuna utilità, in considerazione della oggettiva impossibilità di ripristinare una situazione conforme a diritto».
Infine, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata si poneva in contrasto, tra l’altro, con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe irragionevolmente dipendere la possibilità di definire in via amministrativa il procedimento dalla natura della violazione, ossia da un elemento estraneo alla volontà del contravventore, ovvero dalla insindacabile discrezionalità dell'organo di vigilanza di impartire la prescrizione, e determinerebbe disparità di trattamento tra il contravventore a cui venga imposta una prescrizione che gli consente di definire la violazione contestata avvalendosi della procedura amministrativa prevista dalla legge, e il contravventore al quale non venga impartita alcuna prescrizione, che si vedrebbe preclusa la possibilità di definire in via amministrativa il procedimento penale a suo carico.
La Corte cost., con ord. n. 416 del 10 dicembre 1998, nel dichiarare la questione manifestamente infondata, ha affermato che «…le censure di legittimità costituzionale si basano sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia <<ontologicamente>> impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994; che l'obiettiva diversità della struttura dei diversi reati, quale risulta dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del reato stesso, nonchè la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole assicurare l'osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale; che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie incriminatrici; che sotto questo profilo non ha pregio neppure la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina impugnata in realtà non riconosce alcuna "discrezionalità" dell'organo di vigilanza: l'impossibilità di impartire la prescrizione - secondo la prospettazione del rimettente - é infatti una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione contestata, sicchè non può configurarsi alcun eccesso di delega da parte del legislatore delegato; che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del 1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o fosse stata impartita senza osservare le forme prescritte, aveva precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a <<ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo in esame>>; che tale conclusione trova il suo fondamento nella ratio del decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori é prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale; che, sulla base di tale ratio, ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione del reato, valutate la natura e le concrete modalità di realizzazione della contravvenzione contestata, il contravventore potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994».
Due sono le considerazioni che si possono fare, entrambe di estrema rilevanza: in primo luogo, le situazioni oggetto della pronuncia riguardano i casi in cui non sia possibile impartire una prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione (perché si tratta di “reato già consumato e non ottemperabile” o perché è comunque venuta meno la situazione antigiuridica che aveva dato origine alla violazione contestata) ed è agevole comprendere che si tratta esattamente se non di tutti, certamente di una buona parte dei casi che, secondo la tesi qui avversata, potrebbero ricadere nel novero dei reati a condotta esaurita.
Il che dimostra che il problema è stato preso già in esame dall’organo di controllo della legittimità delle leggi che non ha avuto nulla da eccepire.
In secondo luogo, la Corte costituzionale ha messo l’accento sulla circostanza che l’estensione della procedura estintiva ad opera della sentenza n. 19/98 si basava sul rilievo accordato al comportamento volontario dell'autore dell'infrazione che vi aveva posto rimedio, situazione nettamente diversa da quella di chi non ha nulla da «rimediare» perché il reato commesso è cessato senza lasciare conseguenze ulteriori da eliminare.
Successivamente, la Corte costituzionale ha esplicitato analoga posizione nell’ord. n. 205 del 24 maggio 1999. In questa vicenda, la questione di legittimità costituzionale era stata sollevato aggredendo la parte della disciplina del 1994 in cui non si prevede che l’organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione.
Anche questa volta la Corte ha stabilito che le censure si basavano sull’erroneo presupposto che, trattandosi di reato per cui era "ontologicamente" impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare la contravvenzione accertata, la natura del reato costituisse elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla applicabilità della disciplina del d.leg. n. 758/94.
La sentenza ha concluso che l’obiettiva diversità della struttura dei diversi reati, quale risultante dagli elementi costitutivi della fattispecie e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del reato stesso, nonchè la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole imporre l’osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale; e che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie incriminatrici.
Per completezza, si fa presente che con ord. n. 192 del 23 maggio 2003 la Corte costituzionale ha reiterato il suo pensiero in un caso in cui si dubitava della legittimità della disciplina nella parte in cui prevede che la prescrizione al contravventore per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate possa essere impartita dall’organo di vigilanza solamente ove questi agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
Insomma, con le pronunce passate in rassegna (e non considerate dalla Corte suprema nel caso Rossello) il Giudice delle leggi ha stabilito, senza alcun dubbio, che la procedura estintiva non è applicabile quando la regolarizzazione dell’illecito non dipenda dal volontario e spontaneo adempimento da parte del trasgressore attuato prima dell’intervento dell’organo di vigilanza.
Alla luce di quanto sopra, ribadiamo perciò che l’art. 15, 3° comma, d.leg. n. 124/04 non dovrebbe avere valore innovativo, essendosi limitato a recepire il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 19/98: in pratica, il legislatore del 2004 ha esteso la procedura estintiva al caso in cui la fattispecie sia «a condotta esaurita» e per meglio chiarirne il senso ha selezionato una specifica ipotesi, quella in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge precedentemente all'emanazione della prescrizione, escludendo tutte le altre possibili eventualità.
III. Per avvalorare questa interpretazione, ci dobbiamo ora soffermare sulla ratio individuabile nel d.leg. n. 758/94.
Si legge nella sentenza n. 36405 (pag. 6) che «la Corte cost…ha identificato come "deflattiva" e non "premiale" la ratio sottesa alla procedura di estinzione di cui si discute ed ha quindi implicitamente negato che la stessa sia appannaggio esclusivo del soggetto che - per prescrizione impartita dall'autorità di vigilanza o per spontaneo ravvedimento operoso - rimuova attivamente le conseguenze dell'illecito».
Questa conclusione non si può condividere.
Non si contesta che la Corte cost. abbia dichiarato che la disciplina del 1994 «si propone di conseguire una consistente deflazione processuale», ma ci pare improprio dire che questa sia la finalità prevalente atteso che, poche righe prima, si è anche sottolineato che «La nuova normativa mira, cioé, da un lato ad assicurare l’effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l’interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, é di gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale».
Invero, la componente di «premialità» che accompagna la normativa del 1994 (e quella del 2015) è innegabile: infatti, come altro può definirsi un meccanismo in cui lo Stato rinuncia ad esercitare la sua pretesa integrale (condannare per la contravvenzione commessa irrogando la pena prevista in via edittale) in cambio di un comportamento positivo tenuto dal contravvenire, il quale a sua volta è ammesso ad un doppio beneficio (il pagamento di una sanzione ridotta e il proscioglimento dal reato) in contropartita della sua collaborazione.
Peraltro, è appena il caso di segnalare che nella decisione del Supremo Consesso n. 26758 del 5/05/2010 – menzionata anche nella sentenza in esame, sia pure ad altri fini – si afferma testualmente: «… il legislatore ha previsto… un particolare procedimento ad opera dell'organo di vigilanza, quale attività di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), che precede quello penale ovvero si innesta in esso come una parentesi incidentale che comporta la sospensione del procedimento penale stesso; ciò al fine di perseguire una specifica conformazione alle prescrizioni antinfortunistiche impartite dall'organo di vigilanza a chi le abbia violate; il quale, ove adempia a tali prescrizioni, beneficia di una particolare misura premiale consistente nell'oblazione in via amministrativa (pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in misura più favorevole di quella dell'oblazione prevista in generale per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (art. 162 c.p.: terza parte del massimo della pena dell'ammenda) o per le contravvenzioni punite con pena alternativa (art. 162 bis c.p.: metà del massimo della pena dell'ammenda)».
Ecco dunque perché, in nome delle finalità complessive assegnate alla procedura estintiva, è stata giustificata l’equiparazione della situazione tipica prevista dalla normativa (del 1994 e ora anche del 2015) a quella del trasgressore che «elimina» la contravvenzione ambientale, prima dell’accertamento dell’illecito da parte dell’organo di vigilanza, attraverso un comportamento «speculare» a quello che avrebbe potuto essere oggetto di prescrizione.
In questa ricostruzione del sistema, l’argomento letterale, imperniato sul significato da attribuire a quell’«ovvero» che compare nell’art. 15 d.leg. n. 124/04, diventa meno pregnante.
Premesso che la Cassazione ha affermato che «certamente» il legislatore ha utilizzato la congiunzione «ovvero» con il significato di «oppure» e non di «cioè», dobbiamo riconoscere che il dibattito sul significato più corretto, dal punto di vista lessicale, del termine «ovvero» è ancora aperto e perciò la scelta della Corte Suprema di accettare l’uno anziché l’altro significato potrebbe anche andare esente da critiche.
Il fatto però è che, in presenza di un termine polisenso, il significato più corretto, nell’ambito normativo in cui si colloca, può ben dipendere da criteri diversi da quello strettamente letterale. Pertanto, da questo angolo visuale, l’interpretazione della congiunzione «ovvero» utilizzata nell’art. 15 poteva essere condotta tenendo conto di quanto prima esposto e quindi concludere assegnando alla congiunzione valore esplicativo e non alternativo.
IV. In ordine alla questione se l’art. 15 d.leg. n. 124/04 si estenda «automaticamente» alla procedura di cui all'art. 318 d.leg. n. 152/06, come opinato nella sentenza n. 36405, va prima di tutto ricordata l’opinione di un Chiaro Autore ( 2 ) che ha sostenuto che la modifica in tema di reati a condotta esaurita apportata dall'art. 15 alla procedura del d.leg. n. 758/98 non sia rilevante ai fini della analoga procedura estintiva, prevista dalla l. n. 68/15.
Orbene, a nostro avviso, se l’art. 15 ha valore ricognitivo e non innovativo, come si è spiegato in precedenza, non si vedono motivi per non applicarlo anche nel settore degli illeciti ambientali, atteso che non aggiunge nulla di più rispetto a quanto sancito dalla Corte cost. nel 1998.
Se però dovessimo ritenere che l’art. 15 sia innovativo, non ci sentiamo proprio di confermare la stessa conclusione.
V. Quanto appena accennato, ci porta a lumeggiare sugli aspetti sostanziali che stanno alla base della tematica di cui si sta parlando.
Invero, la locuzione «condotta esaurita» compare soltanto nell’art. 15, 3° comma, d. leg. n. 124/04 e dunque, seguendo l’impostazione che la norma è «ricognitiva» e che la congiunzione «ovvero» ha valore esplicativo, la nozione in oggetto è fornita positivamente dalla legge nella parte in cui si spiega che l’ipotesi di condotta esaurita corrisponde a quella in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto alla regolarizzazione precedentemente all'emanazione della prescrizione. In tal modo, la disposizione ha una sua interna coerenza e completezza applicativa.
Di contro, se si abbraccia la tesi che l’art. 15 abbia valore innovativo e che «ovvero» significhi «oppure», la nozione è quanto mai evanescente.
Infatti, la locuzione rimanda alla tematica relativa il momento di consumazione del reato, vale a dire al momento in cui si è «esaurita» la fase di esecuzione/realizzazione della condotta costituiva del fatto tipico. Se così fosse, non ha però senso limitare il concetto al solo reato istantaneo – come fa la sentenza in commento, che parla di «illecito istantaneo…per cui non sia possibile impartire prescrizioni», perchè anche nel reato permanente è individuabile un momento in cui si esaurisce la condotta esecutiva del reato.
Al di là di questo rilievo – secondario – l’attenzione va invece posta sulla «novità» della sentenza n. 36405 secondo cui per condotte esaurite si intendono tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.
In realtà, ad assumere rilevanza ai nostri fini non è tanto il fatto che la fattispecie concreta non sia produttiva di conseguenze dannose o pericolose, quanto il fatto che risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.
Per dimostrare tale assunto, proponiamo una serie di esempi ( 3 ) che riguardano tanto l’area della sicurezza sul lavoro che della tutela ambientale:
- casi in cui le conseguenze del reato non sono oggettivamente eliminabili: ad es. sforamento dei limiti quantitativi di rifiuti ammessi (è l’ipotesi esaminata nella sentenza n. 36405); immissione di sostanze liquide in un corso d’acqua (è evidente che il danno esiste, ma in concreto non si può asportare il liquido sversato); abbandono di rifiuti che un terzo abbia successivamente provveduto a rimuovere; conclusione dei lavori in un cantiere edile; cessazione dell’attività per fallimento dell’azienda; vendita o distruzione della macchina irregolare;
- casi in cui le conseguenze non sono soggettivamente eliminabili: ad es. dismissione volontaria della carica di rappresentante legale dell’azienda; licenziamento del dirigente.
Ecco dunque che ci poniamo la domanda cruciale: in base a quali motivi, alla situazione di chi regolarizzi prima di essere destinatario di una prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, dovrebbero essere equiparate tutte le altre situazioni in cui non esiste alcun elemento di meritevolezza per applicare il meccanismo cd. ora per allora?
Secondo noi, la sola «condotta esaurita» da assumere quale presupposto per estendere la procedura estintiva è quella in cui la situazione illecita (intendendo sia la condotta criminosa in senso stretto sia le conseguenze della stessa) sia venuta meno per scelta virtuosa, indotta o spontanea, del contravventore. Ogni altra ipotesi, in cui in cui non sia possibile o utile impartire la prescrizione di regolarizzazione, non può invece essere invocata per attivare la procedura estintiva e consentire che lo stesso «premio» (estinzione del reato oltre alla riduzione della sanzione) venga accordato anche a questi responsabili.
VI. Avviandoci alla conclusione, la sentenza n. 36405 merita una riflessione sotto altro profilo.
La Cassazione ha sostenuto che «… che la conclusione cui si è pervenuti risponde - tanto nei reati ambientali quanto nelle violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro - ad esigenze di intrinseca ragionevolezza, in quanto impedisce di applicare un trattamento peggiorativo al soggetto che abbia commesso un illecito di limitata gravità, perché istantaneo e non produttivo di conseguenze dannose o pericolose, rispetto al contravventore che - pur avendovi spontaneamente posto rimedio - abbia commesso un illecito dannoso o pericoloso per l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori: se quest'ultimo soggetto può beneficare della procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e ss del d.lgs. n. 152 del 2006 e 20 e ss. del d.lgs. n. 756 del 1994, tanto più la procedura in questione deve essere riconosciuta in capo al contravventore che abbia commesso una violazione meno grave - perché istantanea e priva di conseguenze - ed abbia correttamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative imposte dall'autorità di vigilanza».
Orbene, a parte il fatto che, nel settore la sicurezza sul lavoro, il d.leg. n. 758/94 non ha fissato alcun filtro, come ha fatto invece la l. n. 68/15, nel senso che non rileva se l’illecito sia produttivo o meno di conseguenze dannose o pericolose, il discorso non è persuasivo.
Infatti, per provare la propria tesi, la Cassazione ipotizza che sarebbe ingiusto trattare peggio chi abbia commesso un illecito di limitata gravità, perché istantaneo e non produttivo di conseguenze dannose o pericolose, rispetto al contravventore che abbia commesso un illecito dannoso o pericoloso per l'ambiente, ponendovi però spontaneamente rimedio e che perciò potrebbe beneficiare della procedura estintiva.
La Corte però ha trascurato che le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e pertanto non è affatto scontato che a quel contravventore potrebbe essere impartita una prescrizione di regolarizzazione. Così opinando, viene meno il motivo per equiparare all’adempimento «indotto» quello «spontaneo».
Tutto ciò senza considerare che, secondo la migliore interpretazione, la procedura estintiva è applicabile solo alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con la pena alternativa che corrispondono alle situazioni in cui, tendenzialmente, il fatto non è produttivo di danno ambientale. Anche per questa via, si svuota dunque di rilevanza il secondo termine del confronto operato dalla Cassazione per riconoscere in capo al contravventore, che abbia commesso una violazione meno grave, in quanto priva di conseguenze, il diritto ad essere ammesso al pagamento della sanzione dall'autorità di vigilanza.
Resta un’ultima riflessione critica da svolgere con riferimento alla parte finale della sentenza in cui, per avallare la tesi prescelta, si menzionano quelle pronunce che hanno affermato che l'omessa indicazione da parte dell'organo di vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (v. ex plurimis, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017; Sez. 3, n. 26758 del 5/05/2010).
Questi i passaggi salienti tratti dalla sentenza Rossello: «Le pronunce prendono le mosse dal presupposto implicito secondo cui la procedura di estinzione possa applicarsi anche alle condotte esaurite, tanto che richiamano espressamente il disposto di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 nella sua alternativa previsione delle condotte esaurite che si concretizzano negli illeciti istantanei e delle ipotesi di spontaneo ravvedimento operoso, e, proprio per questo, prevedono la possibilità di presentare istanza di oblazione in sede amministrativa o in sede penale, come imposto dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994…
…il contravventore, tanto che abbia commesso un illecito istantaneo, tanto che abbia spontaneamente regolarizzato l'illecito, può proporre istanza di oblazione al cui accoglimento e all'avvenuto pagamento segue l'estinzione del reato. Infatti, si afferma espressamente che «il beneficio in questione non potrebbe essergli precluso per il solo fatto che non ci sia nulla da regalarizzare»…Dunque, anche le più recenti pronunce in ordine alla non improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata indicazione delle prescrizioni pongono sullo stesso piano le condotte esaurite che si siano concretizzate nella commissione di un illecito istantaneo, privo di conseguenze dannose e pericolose, e la condotta di spontanea e volontaria regolarizzazione della violazione da parte del contravventore».
Orbene, in primo luogo, le richiamate sentenze del 2010 e del 2017, nel superare il precedente orientamento in materia, hanno prospettato la soluzione pratica per garantire al contravventore la più ampia possibilità di beneficiare della procedura estintiva, ma non è stata esaminata in modo specifico la questione della condotta esaurita.
Tra l’altro, la sentenza n. 26758 del 2010, quando dice che all’imputato non può essere precluso il diritto di chiedere al giudice di essere ammesso all'oblazione in misura ridotta solo perché nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita, sostiene questa conclusione proprio con riferimento all’ipotesi in cui egli abbia "regolarizzato" adottando misure equiparabili a quelle che l'organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, il che conferma, ancora una volta, la nostra impostazione e non quella della Cassazione.
Insomma, le sentenze del 2010 e del 2017 non hanno affermato che la procedura estintiva sia applicabile in ogni caso di condotta esaurita, nell’accezione ampia sostenuta nella sentenza n. 36405, ma si sono limitate a riconoscere quello che fin dal 1998 aveva detto la Corte costituzionale.
Giunti alla fine di questo laborioso excursus, che dire ancora: sperare che la Cassazione ci ripensi oppure pensare ad un intervento della Corte cost. affinchè valuti se la normativa – interpretata secondo l’orientamento qui in commento – sia legittima nella parte in cui dispone il medesimo trattamento penale a fronte di situazioni ontologicamente differenti in assenza di qualsiasi razionale giustificazione.
1 Per approfondire l’argomento, si rinvia a Paone, Dopo tre anni dall’entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente, n. 2/2019, par. 4; Id., Applicazione della procedura di estinzione dei reati in materia di lavoro anche in presenza di condotte “esaurite”: qualche dubbio, in www.lexambiente, 27 settembre 2016; Amendola, Contravvenzioni ambientali a condotta esaurita e procedura estintiva della legge 68/2015, in www.lexambiente, 16 Febbraio 2018.
2 Amendola, Contravvenzioni ambientali a condotta esaurita e procedura estintiva della legge 68/2015, cit.
3 Che ovviamente non hanno affatto la pretesa di definire l’intera gamma delle situazioni di condotta esaurita.