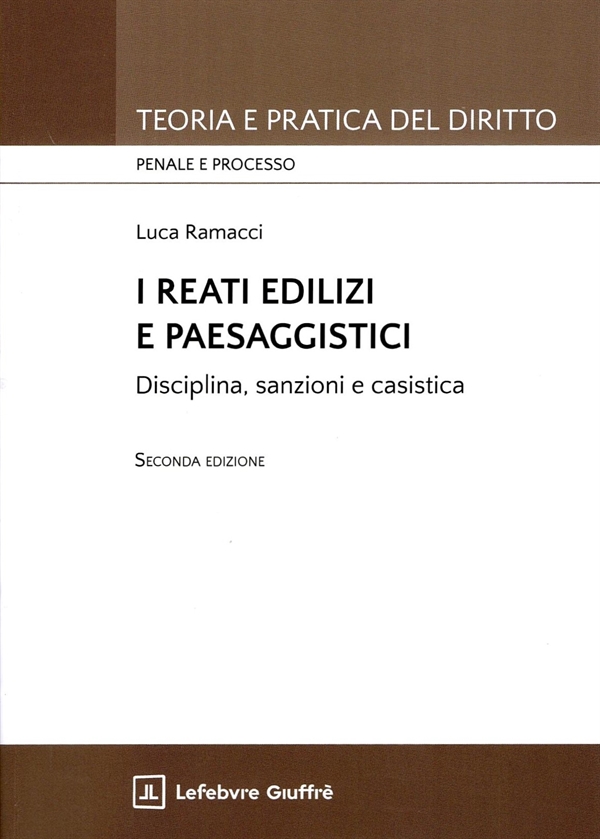La produzione di energia: primo inquadramento d’apice
La produzione di energia: primo inquadramento d’apice
di Alberto Pierobon
La materia dell’energia, come nota la maggior parte della dottrina (1), è partita da concetti penali e civilistici: si veda l’art. 624, comma 2, del c.p. ove “agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l’energia elettrica che abbia un valore economico” e l’art. 814 del c.c. “si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”.
“Il mutamento di prospettiva e la fuoriuscita dell’energia dalle troppo strette maglie della tradizione civilistica è stato sancito, a distanza di poco più di un lustro dalla codificazione, dalla Costituzione repubblicana” (2) .
Però la dottrina non ha mancato di segnalare una certa vaghezza del testo (3), per esempio per l’art. 117,comma 3, della Costituzione, ove “la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” sono considerate, com’è noto, materie di legislazione concorrente, che cioè spettano alla Regione, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali.
“Sul punto la riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente recepito gli orientamenti che erano via via venuti emergendo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale da un lato aveva ribadito la preminenza dell’interesse generale al reperimento e sfruttamento delle fonti energetiche, nonché ad un adeguato approvvigionamento della collettività – con la conseguente riserva a favore della legislazione statale – ma dall’altro aveva sottolineato come nel settore si manifestassero anche profili di interesse regionale, come la sanità e l’urbanistica. Profili che si erano poi venuti delineando ed ampliando con il fronte impulso al decentramento amministrativo dato dalla «Legge Bassanini» (legge n.59 del 1997). Secondo un’opinione condivisa, tuttavia, l’attribuzione dell’int era materia energetica alla legislazione concorrente di Stato e Regioni da parte del nuovo Titolo V è un passo in avanti troppo accentuato per una materia che necessita di strategie unitarie e che utilizza necessariamente persone fisiche non frazionabili come la rete di distribuzione, con il concreto rischio di pregiudicare il perseguimento degli interessi nazionali a causa della moltiplicazione di attribuzione delle competenze legislative ed amministrative” (4).
Anche l’inciso de “il sostegno all’innovazione per i settori produttivi” pone problemi di lettura, introducendo un criterio incerto tra il teleologico e quello ontologico-oggettivo.
Comunque sia, non possono negarsi obiettive interconnessioni tra la materia dell’energia e quella dell’agricoltura dove l’art. 117, comma 4, prevede per le Regioni una competenza legislativa esclusiva.
Si vedano altresì:
- l’art. 117, comma 6, Cost. sulla potestà regolamentare delle Regioni, salvo che nelle materie di legislazione esclusiva statale (salvo la delega dello Stato alle Regioni). Quindi il potere legislativo in materia di energia elettrica è ripartito, ma godono di una competenza regolamentare piena per la parte “concorrente”. Per cui comuni, province e città metropolitane dispongono della potestà regolamentare in relazione alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l’art. 118, comma 1, Cost. sulle funzioni amministrative, il quale stabilisce che esse sono attribuite ai Comuni, “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Viene previsto l’utilizzo di una clausola residuale, della quale può avvalersi la potestà regionale per legislativamente conferire ex art. 118 Cost. e quindi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, compiti e funzioni amministrativi a comuni, province e città metropolitane in materia di energia, sempre che non rientrino tra quelli riservati allo Stato. Rimangono ferme le funzioni fondamentali dei predetti enti, come definite dal t.u.e.l.
L’art.43 Cost. sancisce gli interessi di carattere generale che riguardano anche il settore energetico (ovvero, il carattere di servizio pubblico, fonte di energia, situazione di monopolio, preminente interesse nazionale (5)) che diversamente qualifica anche l’impresa imponendo, per il suo esercizio, una forma differenziata della riserva pubblica (6).
In effetti l’applicazione dell’art. 43 Cost. storicamente è avvenuta anche perché si era costituito un cartello di imprese produttrici di energia, tali da creare costi sproporzionati alle nascenti industrie e attività produttive. Pertanto “si diede vita, in applicazione dell’ art. 43 Cost., alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con cui, salvo alcune limitate deroghe ed eccezioni, si riservavano in via esclusiva per l’intero territorio nazionale all’Enel (Ente nazionale per l’energia elettrica), ente pubblico appositamente e contestualmente istituito, tutte le attività inerenti alla produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, disponendosi a tal fine il trasferimento coattivo, in favore del prede tto ente, delle imprese che già svolgevano le attività de quibus. […] L’istituzione dell’Enel e la nazionalizzazione dell’industria elettrica costituiscono, come noto, l’unica occasione in cui il legislatore abbia fatto uso del dirompente potere, «riservatogli» (riserva di legge) dall’art. 43 Cost. di espropriazione e di riserva originaria di imprese (riserva di attività economica). Il dato non sorprende laddove si consideri che per tale settore industriale ricorrevano, contemporaneamente, tutti i presupposti richiesti dalla norma costituzionale per fondare la legittimità dell’intervento di riserva e/o trasferimento: infatti, le imprese relative si riferivano a fonti di energia, operavano in una situazione di oligopolio (costantemente ritenuta assimilabile a quella di monopolio economico), rigua rdavano un servizio pubblico essenziale e rivestivano certamente un carattere di preminente interesse generale” (7).
L’art. 44 Cost. sembra instaurare un collegamento tra l’agricoltura e l’ambiente nell’elemento terra, ove: “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera”…
In questo contesto occorre porsi la domanda se la produzione di energia abbia (o meno) natura di “servizio essenziale” per i cittadini?
Come abbiamo dianzi sinteticamente osservato, la materia energetica indubbiamente interferisce con altre materie, quali: la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente, la tutela dell’ecosistema, l’ordinamento civile (si veda l’art. 117, comma 2, Cost. relativo alle competenze esclusive ‑ riservate ‑ dello Stato).
Se è vero, come conveniamo, che l’ambiente più che materia è un “valore costituzionale dal contenuto integrale” ovvero ricomprendente “una pluralità di materie ed interessi” (8), ovvero di valori, e dove si riscontrano “plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate” (9), essa materia “si colloca all’incrocio di varie competenze legislative” (10), collegati ad una serie di situazioni soggettive diversamente tutelabili.
Diverse sono infatti le finalità ecologiche riscontrabili nei vari settori del diritto, in quanto finalizzate a tutelare varie, autonome, entità, tant’è che si parla della “concorrenza di competenze” (11), per cui “il giudice nel bilanciamento tra libertà dell’impresa e tutela dell’ambiente e della salute persegue ragionevolmente la seconda apportando alla prima restrizioni fondate sull’utilità sociale” (12).
Però, nell’intreccio di competenze tra le materie, col metodo teleologico, la Corte ha adottato il criterio della prevalenza, oppure il principio-criterio della leale collaborazione (ma quest’ultimo, solo quando si abbia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove “non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri” (13)).
Nella valutazione delle finalità perseguite si invoca il criterio della prevalenza.
Dove troviamo le materie cosiddette “trasversali” (tutela dell’ambiente, della concorrenza, ricerca, eccetera) cioè delle materie che “allo scopo di raggiungere i fini loro propri, possono incidere negli ambiti di competenza della legge regionale, possono attraversare trasversalmente le materie regionali” e che, però, consentono anche “interferenze nel senso opposto, della legge regionale nel campo delle materie trasversali”.
“Ciò che è specifico delle materie trasversali è che la competenza legislativa statale viene connotata dal fine da raggiungere, più che dal riferimento a un ben delimitato campo materiale, tanto che si può ben parlare di «smaterializzazione delle materie»” (14).
Nella concorrenza di competenze sembra però assumere un ruolo primario la competenza (rectius, valore) della tutela dell’ambiente, essendo questa la prima e vera finalità dell’intera strategia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
--------
(1) Citata nelle note seguenti.
(2) Così G.D. Comporti, Energia e Ambiente, in (a cura di G. Rossi) “Diritto dell’ambiente”, Torino, 2008, p. 258.
(3) B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005, p. 221.
(4) L. Salvini, Prefazione al volume (a cura di G. Bonardi e C. Patrignani), Fare energia. Fiscalità e agevolazioni, Milano, 2007, p. XVII.
(5) G. Pavanello, Energia elettrica nel diritto amministrativo, voce, Digesto.
(6) G.D. Comporti, op.cit., p. 259.
(7) A. Collavecchio, Energia elettrica, voce, Digesto.
(8) Corte cost. 25.11.2004, n.354 e 12.4.2005, n. 151.
(9) Corte cost. 28.1.2005, n. 51.
(10) Corte cost. 8.6.2005, n. 219.
(11) Corte cost. 28.1.2005, n. 50.
(12) Corte cost. 3.6.1998, n. 196
(13) Corte cost. n. 219 del 2005.
(14) Benelli, La “smaterializzazione” delle materie, Milano, 2006