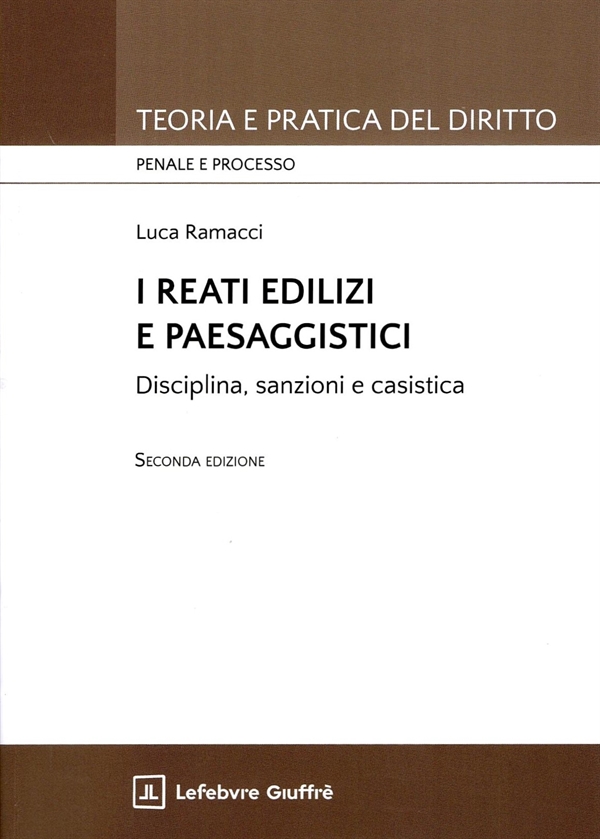Chiunque
si sia occupato, anche marginalmente, di problematiche connesse alla gestione
dei rifiuti sa che dilatare o restringere la nozione di rifiuto significa – di
fatto - condizionare l’ambito di applicazione del decreto Ronchi e di tutti
gli obblighi e vincoli da esso imposti.
Negli
anni abbiamo assistito ai più svariati tentativi di ridisegnare la fisionomia
del concetto di rifiuto.
Di
fronte al fluttuare delle interpretazioni, può comunque essere fissato qualche
punto fermo.
In
primo luogo, quella che si tenta di identificare è la nozione di rifiuto ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
nulla ha a che vedere con una generica definizione elaborata dalla prassi oppure
estratta dal linguaggio comune.
Il
punto di partenza, allora, è rappresentato dalla lettera dell’art. 6, 1°
comma lett. a) del d.lgs. 22/97, che richiede due fattori concorrenti, perché
propriamente possa parlarsi di rifiuto.
Il
primo elemento, che non ha mai suscitato particolari problemi di
interpretazione, è il cd. criterio tabellare, ovvero l’appartenenza della
sostanza ad una delle categorie individuate nell’allegato A: si tratta di
un’elencazione aperta di carattere non tassativo, come palesemente si evince
dai punti Q1 “residui di produzione
in appresso non specificati” e Q16
“qualunque sostanza o materia che non rientri nelle categorie sopra
elencate”.
Altrettanta
chiarezza non ha accompagnato, invece, il secondo termine definitorio, ovvero il
collegamento operato dall’art. 6 del d.lgs. 22/97 tra la nozione di
“rifiuto” ed il concetto di “disfarsi” di una sostanza.
Certamente
oggi non si può ignorare che la prospettiva dalla quale tale giudizio deve
essere formulato è quella del detentore[1],
a nulla rilevando l’eventualità che altri soggetti, diversi dal detentore,
possano di fatto utilizzare ancora il materiale di cui comunque il detentore si
disfa.
In
più occasioni, infatti, la Corte di Giustizia CE ha sconfessato la petizione di
principio secondo cui ciò che è suscettibile di riutilizzazione economica non
è rifiuto[2].
Tra le innumerevoli prese di posizione citiamo, ultima in ordine cronologico, la
sentenza Arco in cui la CGCE ribadisce, ove mai ve ne fosse stato bisogno, che
“anche se un rifiuto è stato oggetto
di un’operazione di recupero completo la quale comporti che la sostanza di cui
trattasi ha acquisito le stesse proprietà e caratteristiche di una materia
prima, cionondimeno tale sostanza può essere considerata un rifiuto se il
detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.”
D’altronde, basterebbe considerare che le operazioni di recupero dei rifiuti
altro non sono che forme di riutilizzazione dei medesimi.
La
Corte di Giustizia si è pronunciata anche su un altro aspetto ritenuto
essenziale, ovvero la necessità che l’effettiva esistenza di un rifiuto sia
accertata caso per caso, senza ricorso a schemi presuntivi[3].
Invero, rischia di contrastare con il diritto comunitario una normativa
nazionale che, ricorrendo a metodi di prova quali presunzioni iuris et de
iure, finisca per escludere la natura di rifiuto di una sostanza e, quindi,
restringere l’ambito di applicazione della direttiva stessa[4].
Resta
da chiedersi a quali condizioni si può ragionevolmente sostenere che il
detentore si disfi di un determinato materiale o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsene.
La
risposta, evidentemente, non può che venire dalle fasi stesse di gestione dei
rifiuti.
Come
puntualizzato dalla circolare del Ministro dell’Ambiente n. 3402/V/MIN del 28
giugno 1999, recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di
rifiuto, “con il termine disfarsi il legislatore comunitario intende
qualificare la destinazione di una sostanza alle operazioni di smaltimento o
recupero indicate negli allegati B e C del decreto legislativo 22 febbraio 1997,
n. 22”.
La
portata del termine “rifiuto”, quindi, dipende dalla identificazione dei
concetti di “smaltimento”
e “recupero”[5].
Tuttavia,
se è pacifico individuare come “rifiuto” ciò che è avviato allo
smaltimento, risulta molto più delicato identificare come rifiuti le sostanze
destinate al recupero.
Nonostante
le difficoltà di una verifica caso per caso, - almeno fino al giorno 8 luglio
2002 - in presenza di una delle attività di recupero di cui all. C non si
dubitava della natura di rifiuto del materiale in questione.
Un
problema sarebbe potuto sorgere per attività di recupero non espressamente
menzionate nell’all. C., ma anche questo dubbio era stato chiarito dalla
circolare interpretativa 28 giugno 1999.
In
accoglimento di una nozione estensiva di rifiuto, la circolare citata ha
precisato che il concetto di recupero funzionale alla definizione di rifiuto non
comprende soltanto le operazioni menzionate nell’allegato C, ma anche
procedure di riutilizzo diverse da quelle descritte in siffatto elenco.
Come
a dire che è rifiuto ciò che è avviato allo smaltimento o recupero, anche se
con un’operazione non espressamente indicata negli allegati B e C.
D’altronde,
l’elencazione delle attività di recupero e smaltimento contenuta negli
allegati B e C ha valore puramente esemplificativo: le operazioni contenute in
quell’elenco sono descritte sulla base di una sorta di metodo empirico che
riflette quanto in concreto avviene nella pratica.
A
chiusura del cerchio, la circolare 28 giugno 1999 esclude dalla nozione di
rifiuto ed esonera dal relativo regime i materiali di cui il detentore non si
disfi, non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi, sempre che ricorrano
due ulteriori condizioni: la sussistenza delle caratteristiche delle materie
prime secondarie ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 d.lgs. ed il diretto,
oggettivo ed effettivo impiego in un ciclo produttivo. La medesima
esclusione vale altresì per i beni di consumo dei quali il detentore non si
disfa, proprio in quanto possono essere utilizzati e sono effettivamente
utilizzati per la loro funzione originaria.
Certo,
non si vuole con ciò nascondere la difficoltà di tradurre nella pratica le
enunciazioni appena sintetizzate.
Da
una parte, molte delle procedure di recupero di cui alle norme tecniche del D.M.
5 febbraio 1998 sono attività riutilizzo diretto nell’industria. Con
la conseguenza che è a volte in concreto arduo individuare il confine tra
impiego diretto in un ciclo produttivo e vera e propria operazione di recupero.
D’altro
canto, il ragionamento rischia di risultare per certi versi tautologico, nel
senso che si identifica come rifiuto ciò che è destinato ad operazioni di
recupero e smaltimento e, d’altro canto, è avviato ad una destinazione di
smaltimento o recupero ciò che è rifiuto.
Sul
quadro così delineato è intervenuto il D.L. 8 luglio 2002 cd. Ronchi quater,
n. 138, che all’art. 14 contiene una nuova interpretazione autentica della
definizione di rifiuto.
La
prima parte della definizione non comporta particolari difficoltà, visto che si
ribadisce, con una chiarezza ancora maggiore rispetto alle enunciazioni della
circolare 28 giugno 1999, che disfarsi di una sostanza vuol dire avviarla ad
attività di smaltimento o recupero.
I
problemi cominciano laddove, in maniera del tutto apodittica, si afferma che non
ricorre la decisione di disfarsi in presenza – alternativamente – di una
delle due condizioni: o l’effettivo ed oggettivo riutilizzo senza trattamento
alcuno e senza pregiudizio per l’ambiente oppure il riutilizzo con trattamento
senza operazioni di recupero di cui all’all. C del decreto legislativo 22/97.
Avremmo
potuto ritenere, con una certa ingenuità, che questo fosse il fondo della
schizofrenica confusione creata intorno alla nozione di rifiuto.
Ma
– evidentemente – al peggio non c’è fine. Ed ecco l’emendamento al cd.
Ronchi quater dalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2002 in sede di
approvazione della legge di conversione del D.L. 138/2002, in cui le due
condizioni alternative (riutilizzo senza trattamento; riutilizzo con trattamento
senza procedura di recupero) non sono più riferite al dibattuto problema della
identificazione della decisione di disfarsi di una sostanza, ma altresì alla
sussistenza dell’obbligo di disfarsi. Come se un obbligo di tal fatta non sia
semplicemente quello che deriva da una fonte normativa o da provvedimento
specifico della pubblica amministrazione.
E’
facile prevedere che l’odissea della definizione di rifiuto non si concluderà
con questo intervento normativo.
Tuttavia,
ci sono una serie di considerazioni che possono già essere formulate.
In
primo luogo, non sembra azzardato dubitare della legittimità costituzionale di
tale norma sotto il profilo della compatibilità con l’art. 77 della
Costituzione. Stentiamo ad individuare i presupposti della necessità ed urgenza
in una interpretazione autentica di un testo normativo già chiarito da una
recente circolare ministeriale.
Inoltre,
sorprende come, fornendo una rinnovata interpretazione del concetto di rifiuto,
si ignori tutta la sistemazione raggiunta dalla questione in dottrina e
giurisprudenza.
Nel
qualificare l’attività di riutilizzo, infatti, si precisa che essa debba
essere effettiva e oggettiva, senza alcuna menzione di un’altra
caratteristica, da sempre ritenuta essenziale per avere un riutilizzo senza
recupero in senso proprio, ossia che si tratti di reimpiego diretto.
Conseguentemente,
è formulata una vera e propria presunzione assoluta in base alla quale si
esclude l’intenzione o l’obbligo di disfarsi in presenza di riutilizzo,
anche non diretto, purché non vi sia trattamento o in alternativa in caso di
riutilizzo con trattamento, purché non ricorra una delle operazioni di recupero
di cui al d.lgs. 22/97. Con buona pace della nozione di “reimpiego diretto”
elaborata dagli esperti del settore.
Resta
da chiedersi se la presunzione assoluta introdotta dalla lett. a) dell’art. 14
del cd. decreto Berlusconi operi addirittura in presenza di una delle operazioni
di recupero elencate nell’all. C del d.lgs. 22/97.
Invero,
questo il legislatore non lo dice esplicitamente.
Tuttavia,
al giurista non sfugge che un testo così formulato, con menzione solo nel punto
b) dell’art. 14 della necessità che non ricorra recupero di cui all. C,
lascia aperta la possibilità di ritenere che non sussista più alcun rifiuto,
pur in presenza di operazioni di cui alla lett. R1-R13 dell’all. C.
Qualunque
strada l’interprete decida di percorrere, è importante avvertire che
attribuire ad una vastissima gamma di materiali la patente di sostanza
riutilizzabile, senza alcun vincolo di gestione imposto dalla normativa sui
rifiuti, rappresenta una scelta densa di effetti pratici di grande rilievo.
Per
la gran parte delle attività di recupero “rifiuti” si finisce per aprire un
varco alla possibilità che esse siano esercitate senza più alcun obbligo di
comunicazione di inizio di attività alle autorità competenti ai sensi
dell’art. 33 del d.lgs. 22/97. In altre parole, se davvero si ritiene che non
ci sia più una sostanza definibile come rifiuto, ne consegue che non può
parlarsi propriamente di recupero, che altro non è che una fase della gestione
dei rifiuti.
Il
medesimo discorso vale per il complesso sistema sanzionatorio previsto dal
decreto Ronchi, il cui ambito operativo risulterà fortemente ridotto.
In
conclusione, vale forse la pena di rammentare che il principio della prevalenza
del diritto comunitario cd. compiuto (regolamenti e direttive comunitarie self
executing) si traduce in un vero e proprio obbligo di disapplicazione della
normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria e che tale principio
vale anche per le sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
Non
si vede come giudici e pubblici funzionari potranno ignorare che
l’interpretazione di rifiuto contenuta nel D.L. n. 143/2002 contrasta con la
definizione elaborata dalla CGCE[6],
che in più riprese ha specificato che il concetto di rifiuto non può essere
interpretato in senso restrittivo dal legislatore nazionale e richiede comunque
una valutazione caso per caso, che non tollera presunzioni, soprattutto se di
carattere assoluto.
Non
meraviglia, pertanto, che all’indomani dell’entrata in vigore del D.L. cd.
omnibus, gli autori da sempre più attenti alle problematiche ambientali abbiano
tempestivamente fornito una rilettura di tale norma, tale da renderla conforme
al diritto comunitario[7].
Partendo dal presupposto che il legislatore distingue dal punto di vista
terminologico un generico riutilizzo dal recupero in senso tecnico, si trae la
conseguenza che il riutilizzo di cui all’art. 14 è integrato sempre da
operazioni diverse da quelle di vero e proprio recupero.
Come
a dire che, nonostante l’intervento del Governo, continua ad aversi rifiuto in
presenza di una delle procedura di recupero di cui all’all. C del d.lgs. 5
febbraio 1997.
In
conclusione, si auspica che il legislatore nazionale, gli operatori del settore
e le imprese prima o poi si rassegnino al fatto che il sistema di sorveglianza e
di gestione istituito dalle direttive comunitarie si riferisce a tutte le
sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se dotate ancora di valore
economico e raccolte a titolo commerciale a fini di riciclo, recupero o
riutilizzo.
Almeno
fintanto che l’Italia rimarrà Stato membro dell’Unione Europea.
[1]
in Amendola, I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti, Ambiente e
Territorio, Maggioli Editore, 1999, si evidenzia come nella traduzione del
testo delle direttive del 1975 e del 1978 contenuta nel D.P.R. 915/1982 il
termine “disfarsi” era stato tradotto con il
verbo “abbandonare”, dando così luogo all’equivoco che è
rifiuto solo ciò che è “abbandonato” , ovvero una sostanza che non
serve più a nessuno.
[2]
Nello stesso senso CGCE, 28 marzo 1990, sentenza Vessoso; CGCE, 18 dicembre
1997, C-129/96, rel. Sevon: “il mero fatto che una sostanza sia inserita
in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di
rifiuto”.
[3]
Corte di Giustizia CE, 15 giugno 2000, proc. riuniti c-418/97 e c-419/97,
Arco.
[4] Come si legge testualmente nella sentenza CGCE Arco, già citata.
[5]
In tal senso, vedi le conclusioni
formulate dall’avvocato generale Jacobs sentenza della CGCE, 25 giugno
1997, C-304/94, Tombesi ed altri.
[6]
CGCE, nella sentenza Tombesi, già cit., ha precisato che “una
normativa nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che
esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica
non è compatibile con le direttive comunitarie”; nello stesso senso
sentenza ARCO, già citata.
[7]
G. Amendola, Il Ronchi quater di Berlusconi, in dirittoambiente.com.
Il paragrafo a cui si fa riferimento nel testo è è polemicamente
intitolato “come interpretare l’interpretazione autentica”.