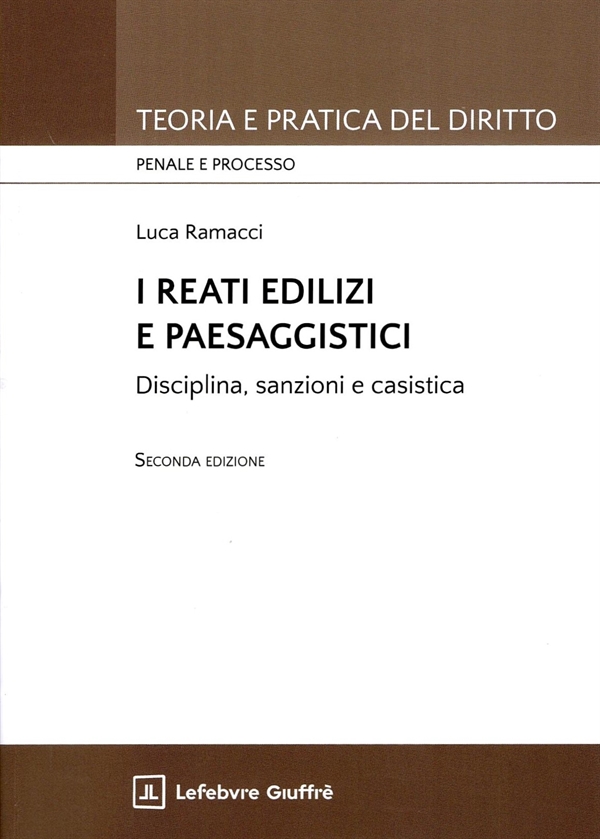Consiglio di Stato Sez. VI n.7570 del 6 novembre 2019
Consiglio di Stato Sez. VI n.7570 del 6 novembre 2019
Beni ambientali.Beni paesaggistici e beni culturali propriamente detti
I beni di cui all’art. 134 comma 1 lettera a), ovvero i beni culturali propriamente detti e quelli di cui all’art. 134 comma 1 lettera c), ovvero i beni paesaggistici, rappresentano il risultato di strumentazioni tra loro parallele e differenziate, poiché la tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura, mentre invece la tutela dei beni culturali immobili riguarda non visuali ma cose, in genere manufatti. Sono oggetto quindi di tutela in tal senso le realizzazioni dell'uomo che possono essere completamente artificiali, come nel caso degli edifici, ovvero essere costituite da dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani come caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno rappresentate ad esempio da parchi e giardini. In tal caso, la componente naturalistica rimane quantitativamente dominante, ma ciò non esclude la possibilità di apporre il vincolo perché si tratta pur sempre di tutelare l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida
Pubblicato il 06/11/2019
N. 07570/2019REG.PROV.COLL.
N. 00266/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2019, proposto dalla società:
Fial Immobiliare S.r.l. unipersonale, già Fefim S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Raimondo e Riccardo Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Di Raimondo in Roma, via Savoia, 86;
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, non costituita in giudizio;
nei confronti
dell’associazione “Latium Vetus” e del Comitato di Quartiere S. Palomba, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e dei signori Monia Bartolucci, Daniela Boccacci, Stefano Casale, Diego Casubolo, Eugen Ciceu, Fabio D'Annibale, Gianni Di Biase, Rossella D'Orazio, Mirela Melita Fedus , Nicolino Fortugno, David Romano, Luigi Russo, Luciano Santini, Salvatore Verde, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rossi in Roma, via Gabriele Camozzi 9;
della Regione Lazio, del Comune di Pomezia e della signora Paola Boccacci, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 30 ottobre 2018 n.10464, che ha respinto il ricorso n. 6836/2018 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- MIBACT, Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, nella parte in cui riguardano terreni ricadenti nell’area di proprietà della Fial S.r.l.:
a) del decreto 27 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – G.U. serie generale 25 novembre 2017 n.276, recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area ‘Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia ed altre della Campagna Romana’ nei Comuni di Pomezia e Ardea”;
b) della descrizione dei confini, elaborato n.2 allegato al decreto;
c) dell’inquadramento territoriale su ortofoto, tavola n.5, allegato al decreto;
d) delle individuazioni delle tenute storiche, tavole nn. 6 e7, allegate al decreto;
e) della individuazione dei siti di interesse storico monumentale, tavola n.11, allegata al decreto;
f) di tutte le perimetrazioni di cui alle tavole nn.8-10 e 12-15 allegate al decreto;
g) della delimitazione dei confini sui fogli catastali, tavola n.16, allegata al decreto;
h) della relazione istruttoria;
di ogni atto ovvero provvedimento presupposto ovvero conseguente o richiamato;
e di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero conseguenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Matteo Di Raimondo e Stefano Rossi e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente appellante impugna il decreto 27 ottobre 2017 della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio meglio indicato in epigrafe (doc. 1 ricorrente appellante, decreto in questione), che ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettere c) e d) del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42, e quindi ha sottoposto a vincolo, un’ampia zona dell’agro romano, estesa per circa 2000 ettari fra i Comuni di Pomezia ed Ardea. La società stessa è infatti proprietaria di un lotto di terreno, che si trova in Comune di Pomezia, località S. Palomba, distinto al catasto al foglio 14 particelle 122 e 402, sul quale intendeva realizzare un capannone industriale, come da domanda di permesso di costruire presentata il giorno 14 aprile 2014 prot. n.37772 del Comune di Pomezia, intervento di costruzione non più consentito per effetto del vincolo imposto, il tutto nei termini che ora si illustreranno (doc. ti 17-21 ricorrente appellante, titolo di proprietà ed atti della richiesta di permesso).
2. Il decreto 27 ottobre 2017, come si è detto, dichiara di notevole interesse pubblico l’area denominata “Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia ed altre della Campagna Romana” nei Comuni di Pomezia e Ardea.
2.1 Si tratta di un’ampia area di circa 2000 ettari, che secondo quanto riporta lo stesso decreto “conserva ancora un insieme particolarmente armonioso di elementi agricoli e naturali, scarsamente antropizzati se non dalla realizzazione, nel corso del tempo, di interessanti esempi di insediamenti agricoli tipici della campagna romana, inscindibilmente coniugati con numerose preesistenze architettoniche (casali, torri, castelli) e archeologiche, così come riscontrabili nelle carte archeologiche storiche e recenti, che testimoniano l’antica vocazione agricola dell’area a cui si aggiunge la funzione di presidio del territorio e delle vie di comunicazione nel periodo medievale”. In altre parole, si tratta di una zona che fin dai tempi dell’antica Roma è stata destinata all’agricoltura, con la funzione essenziale di approvvigionare la vicina città, ed è stata da sempre attraversata dalle strade che a Roma conducono; in particolare, nel Medio Evo è stata caratterizzata da grandi centri agricoli, detti domuscultae, raccolti intorno a torri e castelli costruiti a scopo di controllo del territorio e di difesa. Il più importante di questi centri, compreso nell’area interessata e citato anche nell’intestazione del decreto, è poi il complesso monumentale di Torre Maggiore, che come si vedrà rileva direttamente ai fini di causa, si trova a circa 4 chilometri dall’abitato di Pomezia, all’interno di un lotto di terreno di circa 4 ettari, e comprende una cinta muraria medievale con un edificio ed una torre a sezione quadrata di 7.10 metri di lato, che con i suoi 34 metri di altezza è una delle più alte della campagna romana (per tutto ciò, si veda la relazione generale allegata al decreto, doc. 3 ricorrente appellante, in particolare alle pp. 11-12).
2.2 Il decreto di vincolo è stato pronunciato, come pure si è detto, ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettere c) e d) del d. lgs. 42/2004, e quindi considerando l’area come facente parte dei “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, come previsto dalla lettera c), nonché come comprendente “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, come previsto dalla lettera d).
2.3 Si tratta poi di un vincolo cd vestito, ovvero di un vincolo che ai sensi dell’art. 140 comma 2 del d. lgs. 42/2004 “detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”. In altre parole, il decreto di vincolo non si limita a imprimere all’area la qualificazione di bene paesaggistico e a lasciare la sua concreta tutela alle autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare di volta in volta a fronte dei singoli interventi, ma agisce in via diretta, prevedendo fin da subito con una serie di disposizioni puntuali gli usi del territorio considerato che sono ammessi e quelli che non sono ammessi. Il relativo potere, come è noto, è stato previsto per la prima volta dall’art. 10 comma 1 del d. lgs. 24 marzo 2006 n.157, che ha modificato l’art. 140 comma 2 consentendo al decreto di vincolo di dettare “una specifica disciplina di tutela”, ed è stato reso più incisivo, nel senso di cui al testo attuale riportato, dall’art. 2 comma 1 lettera l) n. 2) del d. lgs. 28 marzo 2008 n.63.
2.4 Nel caso in esame, il decreto di vincolo ha proceduto anzitutto a confermare “la disciplina adottata con il Piano territoriale paesistico regionale del Lazio- PTPR… così come già indicato nella tav. 29_387 e relative norme tecniche”. Com’è noto, il PTPR laziale nella sua cartografia, di cui fa parte la tavola indicata classifica le varie porzioni del territorio regionale in categorie omogenee, denominate “paesaggi”, distinti a seconda delle caratteristiche intrinseche e dell’uso dell’area, e per ciascuna di tali categorie all’interno delle norme di attuazione- NTA detta una specifica disciplina di tutela, indicando gli interventi non ammessi e quelli ammessi, con i relativi limiti e condizioni. Il decreto di vincolo ha quindi cristallizzato in via generale la disciplina già dettata dalla Regione; la ha poi integrata e modificata in casi specifici. Nel dettaglio, il decreto stesso ha riclassificato talune aree espressamente indicate da un tipo all’altro di “paesaggio”, stabilendo di volta in volta una tutela minore, o più spesso più intensa, di quanto già previsto dalla Regione. Il decreto ha infine introdotto alcune disposizioni di tutela puntualmente indicate, ulteriori rispetto a quelle previste nel sistema dei “paesaggi”, ovvero il divieto di arature e movimenti terra superiori ad un certo limite e non autorizzati intorno ai siti monumentali elencati e – per quanto direttamente rileva ai fini di questo giudizio- il divieto di “realizzare ulteriori manufatti a destinazione d’uso produttivo, commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali; realizzare nuove strade carrabili asfaltate a scorrimento veloce; eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e i tracciati viari secondari” in tutte le aree classificate come “paesaggio agrario di rilevante valore” ovvero come “paesaggio dell’insediamento storico diffuso” (per tutto ciò, v. sempre il doc. 2 ricorrente appellante, cit.).
3. Tutto ciò premesso, va illustrata la situazione specifica del fondo per cui è causa, di proprietà della ricorrente appellante.
3.1 Come risulta, per tutti, dall’inquadramento su ortofoto (doc..5 in I grado MIBACT allegato all’elenco del 7 marzo 2018), l’area vincolata ha la forma approssimativa di un trapezio rettangolo rovesciato, la cui base maggiore si estende da nord ad est sud est. La parte superiore di questa ideale base maggiore, quindi a nord dell’area considerata, presenta però una frastagliatura in corrispondenza con la zona industriale di Santa Palomba, in Comune di Pomezia. Tale zona industriale -come è evidente sia dalla cartografia citata, sia dalle immagini satellitari disponibili in rete in pubblico dominio e quindi da considerare come fatti notori- si caratterizza perché accanto a lotti di terreno già urbanizzati, sede di stabilimenti vari, ne contiene altri ancora liberi o parzialmente liberi, che sono stati ricompresi nel perimetro del vincolo. In particolare, è libero anzitutto il lotto rettangolare di quattro ettari di cui si è detto, entro il quale sorge la Torre Maggiore, già da tempo vincolata come singolo monumento: questo lotto costituisce una sorta di dente di sega che si insinua all’interno dell’area industriale ed ha a nord un deposito di petroli, dai caratteristici serbatoi cilindrici ben visibili nell’ortofoto, a est il capannone di un’azienda metalmeccanica e a sud l’altro capannone del centro logistico di una nota catena di supermercati.
3.2 Il terreno di proprietà della ricorrente appellante è un altro dei lotti non ancora, o non completamente, urbanizzati, ha la forma di un rettangolo disposto in direzione da nord ad est sud est, quella del confine del vincolo, si trova poco più ad est del rettangolo di Torre Maggiore, si trova a ridosso dell’azienda metalmeccanica che si trova ad est, guarda a nord il deposito di petroli, e ad ovest il centro logistico dei supermercati, dai quali è separato da un altro lotto libero, di proprietà di terzi.
3.3 Ciò posto, il terreno di proprietà della ricorrente appellante era stato classificato come destinato ad insediamenti industriali negli strumenti urbanistici relativi, come da certificato urbanistico (v doc. 18 ricorrente appellante, cit.); successivamente, nell’ambito del PTPR era stato classificato come “paesaggio degli insediamenti urbani” per la particella 122 e “paesaggio agrario di continuità” per la particella 402, classificazione che previo assenso dell’autorità di tutela consente tutti gli interventi ammessi dalla disciplina urbanistica di zona, e quindi nella specie anche un insediamento di carattere industriale (appello, p. 5 § c; fatto specifico non contestato; per il regime specifico del paesaggio degli insediamenti urbani dispone l’art. 27 tabella B punto 4.4.2 delle NTA al PTPR , per quello del paesaggio agrario di continuità dispone l’art. 26 tabella B punto 4.4.2 sempre delle NTA). Per queste ragioni, la ricorrente appellante, con la ricordata istanza 14 aprile 2014 (v. doc. 19 ricorrente appellante) aveva domandato al Comune di Pomezia il rilascio di un permesso di costruire per realizzarvi un capannone industriale.
3.4 Tale intervento peraltro ora non è più realizzabile, dato che il decreto di vincolo ha cambiato la classificazione del terreno in “paesaggio dell’insediamento storico diffuso”, imprimendovi come si è visto il divieto di comunque realizzarvi “ulteriori manufatti a destinazione d’uso produttivo, commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali”. Il punto rilevante del decreto, per la precisione, è quello ove si dice che viene “classificata come paesaggio dell’insediamento storico diffuso la porzione territoriale delimitata dal perimetro del vincolo in corrispondenza della zona industriale (via della Medicina) e dalla particella catastale 21 del foglio 14, a seguire dalla fascia di rispetto della ferrovia Roma Napoli…” (sempre doc. 2 ricorrente appellante, cit.).
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla società contro tale decreto, ritenendo in sintesi estrema che esso costituisca legittimo esercizio dell’ampia discrezionalità di cui notoriamente l’amministrazione dispone in materia.
5. Contro questa sentenza, la ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, di riproposizione di quelli già dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti:
- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 136 lettere c) e d) del d. lgs. 42/2004 e falso presupposto. Il decreto di vincolo, a suo dire, intenderebbe dichiarare di interesse pubblico una vasta area connotata da un carattere omogeneo di campagna romana; i terreni della ricorrente appellante però non avrebbero nessuna di queste caratteristiche, sarebbero invece integralmente inseriti nell’ambito dell’area industriale di S. Palomba e sarebbero, in sostanza, circondati da capannoni industriali: non avrebbero quindi i requisiti previsti per apporvi il vincolo;
- con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 135 comma 4 lettere c) e d) del dl lgs. 42/2004, sostenendo che la riclassificazione della tutela paesaggistica operata mediante il vincolo violerebbe il principio di proporzionalità; non ci potrebbe in astratto, a suo dire, spingere a proibire lo sfruttamento del terreno in contrasto con quanto previsto dai piani urbanistici. In concreto, poi, la modifica apportata avrebbe imposto ai suoi terreni un vincolo assoluto di inedificabilità, e non semplicemente rafforzato la tutela già imposta;
- con il terzo motivo, deduce violazione del principio di legittimo affidamento e difetto di motivazione quanto alla precedente propria richiesta di permesso di costruire, dato che a suo dire sarebbe stato contraddittorio avere apposto il vincolo senza tenere conto della destinazione industriale dell’area e della richiesta già presentata;
- con il quarto motivo, deduce infine violazione dell’art. 140 comma 2 del d. lgs. 42/2004, nel senso che il Ministero sarebbe andato oltre quanto la norma prevede. Il decreto di vincolo avrebbe previsto le specifiche disposizioni di tutela secondo tecniche e con effetti che dovrebbero essere propri ed esclusivi della pianificazione territoriale, e ciò ha fatto oltretutto senza alcun confronto con gli enti locali, mentre, sempre ad avviso dell’appellante, avrebbe se mai dovuto acquisire e valutare tutti gli atti e le istanze di permesso di costruire relative ai terreni in questione da essi posseduti.
6. Hanno resistito il Ministero, con atto 15 gennaio e memoria 26 luglio 2019, nonché le due associazioni ed i cittadini indicati in epigrafe, con unico atto 18 luglio e con memoria 26 luglio e replica 5 settembre 2019, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto; in particolare, gli intervenienti appellanti hanno eccepito, prima della loro infondatezza nel merito, l’inammissibilità di tutti i motivi di appello, il primo perché sconfinante nel merito amministrativo, e i restanti perché generici, in quanto non indicherebbero la parte della sentenza cui si riferiscono.
7. Alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2019, infine, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
8. E’ anzitutto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi di appello proposta dagli intervenienti appellati con riguardo da un lato al primo di essi, dall’altro con riguardo ai restanti. Con riguardo al primo motivo, è evidente che esso non contiene rilievi di merito, ovvero non pretende di sostituire un proprio punto di vista alle scelte dell’amministrazione, ma si limita, in termini pacificamente ammissibili, a mettere in discussione la razionalità della scelta espressa, nel che consiste il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità. Con riguardo ai residui motivi, per costante giurisprudenza – per tutte C.d.S. sez. V 11 ottobre 2017 n.4717 e sez. VI 29 marzo 2007 n.1472- ciò che rende inammissibile l’appello è la pedissequa riproposizione dei motivi di primo grado, senza che in alcun modo si critichino le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, fermo che per far ciò non si richiedono formule particolari: nella specie, a semplice lettura dell’atto, le ragioni per cui la sentenza di I grado si ritengono errate sono del tutto comprensibili, salvo ovviamente il loro esame nel merito.
9. Ciò posto, l’appello è infondato appunto nel merito e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
10. Vanno per chiarezza sintetizzate le norme applicabili alla fattispecie, nei termini già delineati anche dal Giudice di I grado, che qui si condividono.
10.1 Le norme in questione sono contenute all’interno del titolo I della parte terza del d. lgs. 42/2004, artt. 131-159, dedicato alla tutela e valorizzazione dei “beni paesaggistici”, ove per “paesaggio” si intende, ai sensi dell’art. 131 commi 1 e 2, il “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” tutelato “relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”: in questo modo, all’evidenza, viene precisato e concretizzato il comma 2 dell’art. 9 Cost, per cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
10.2 Il titolo in esame, all’art. 134 comma 1, considera tre distinte categorie di beni paesaggistici, ovvero alla lettera a) “gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico”, categoria che rileva nel caso di specie, individuati con un provvedimento puntuale emesso all’esito del procedimento di cui agli artt. 138 e ss.; alla lettera b) le “aree tutelate per legge” di cui all’art. 142, ovvero determinate parti del territorio per le quali la legge ritiene applicabile in via diretta il regime di protezione da essa previsto; infine, alla lettera c) gli “ulteriori immobili ed aree” individuati come “di notevole interesse pubblico” sottoposti alla tutela dei piani paesaggistici a sua volta previsti dalla legge.
10.3 La giurisprudenza ha chiarito che i beni di cui all’art. 134 comma 1 lettera a), ovvero i beni culturali propriamente detti, e quelli di cui all’art. 134 comma 1 lettera c), ovvero i beni paesaggistici, rappresentano il risultato di “strumentazioni tra loro parallele e differenziate”, poiché “la tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura”, mentre invece “la tutela dei beni culturali immobili riguarda .. non visuali ma cose, in genere manufatti”. Sono oggetto quindi di tutela in tal senso le “realizzazioni dell'uomo” che possono essere completamente artificiali, come nel caso degli edifici, ovvero essere costituite da “dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani” come “caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno” rappresentate ad esempio da parchi e giardini. In tal caso, la componente naturalistica rimane quantitativamente dominante, ma ciò non esclude la possibilità di apporre il vincolo perché si tratta pur sempre di tutelare “l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida”. In tal senso, C.d.S. sez. VI 3 luglio 2012 n.3893, da cui le citazioni.
10.4 Della categoria più generale dei beni culturali fanno poi parte le due specie che rilevano ai fini di causa, ovvero come si è detto i “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, ai sensi della lettera c) dell’art. 136, nonché “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo
10.5 La giurisprudenza ha chiarito che l’individuazione di un bene culturale, sia in generale sia in particolare, per quanto qui interessa, nel caso in cui si tratti di delimitare i confini di una zona da sottoporre a vincolo quale bellezza d’insieme, costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità solo in caso di manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà dei risultati; nel caso che interessa non ricorre poi arbitrarietà per il solo fatto che non ogni singolo elemento compreso nell’area considerata presenta i caratteri della bellezza naturale, dato che appunto si tratta di tutelare l’insieme: così per tutte C.d.S. sez. VI 7 marzo 2016 n.914, citata anche dal Giudice di I grado e pronunciata in un caso consimile, nonché sez. VI 14 ottobre 2015 n.4747, in termini più generali.
10.6 Sempre la giurisprudenza si è poi occupata del caso che qui rileva, ovvero dell’ipotesi in cui si intenda vincolare una porzione di territorio particolarmente estesa, ed ha affermato che il tipo di vincolo da imporre anche in questo caso non è necessitato a priori, ma dipende dalle finalità che in concreto si vogliono perseguire: quando, come avviene più di frequente, si intenda conservare la visuale, si imporrà la tutela dei beni paesaggistici; si potrà invece legittimamente imporre la tutela propria del bene culturale quando si intenda conservare non la visuale, ma la consistenza materiale dell’area, che rappresenti un’eredità storica. In tal senso, l’ampia estensione dell’area è irrilevante, perché la tutela dovrà estendersi fin dove del bene culturale esistano le caratteristiche: in tal senso, la citata C.d.S. 3893/2012, relativa al vincolo di tutto il complesso dei laghi di Mantova, nonché C.d.S. sez. VI 29 gennaio 2013 n.533, citata già dal Giudice di I grado e relativa ad un caso del tutto analogo al presente, ovvero al vincolo dell’ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina, esteso a tutta l’area “avente le caratteristiche del richiamo identitario”.
10.7 La tutela dei beni culturali passa anzitutto per lo strumento generale dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146: in generale, i titolari dei beni vincolati “non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, ed ogni singolo intervento va autorizzato con un provvedimento puntuale, che valuta nel caso concreto la compatibilità fra quanto si vuol realizzare ed il vincolo imposto, senza però che di regola vi siano interventi individuati a priori come ammissibili o non ammissibili, salva ovviamente la tutela dell’esistenza del bene in quanto tale.
10.8 Tuttavia la legislazione si è per così dire evoluta nel senso di anticipare la tutela, ovvero di prevedere già nel provvedimento che impone il vincolo di bene culturale una serie di prescrizioni da rispettare, ovvero di predeterminare già in quella sede gli usi e le trasformazioni consentite. Come si è detto sopra, il testo originario dell’art. 140 comma 2, che in origine si limitava a disporre “il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari”, è stato infatti modificato una prima volta con il d. lgs. 157/2006, nel senso che “i provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare”, e successivamente con il d. lgs. 63/2008, che ha introdotto il testo attuale sopra riportato: “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.” La dichiarazione di interesse pubblico quindi ora deve obbligatoriamente prevedere una disciplina di questo tipo: dei relativi rapporti con la pianificazione urbanistica regionale e subregionale, sulla quale la disciplina stessa prevale, si dirà subito.
10.9 Il procedimento per individuare un bene culturale è di competenza della Regione ai sensi dell’art. 140, per cui appunto “La regione … esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, … emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico”; lo stesso potere però spetta, ai sensi del successivo art. 141 anche all’autorità centrale, ovvero al Ministero, ed è questo il potere esercitato nel caso in esame, sul quale quindi bisogna soffermarsi, tenendo conto del fatto che in tale ipotesi è appunto il Ministero che viene a dettare la “specifica disciplina di tutela” contenuta nella dichiarazione stessa.
10.10 Secondo la giurisprudenza, per tutte le citate C.d.S. 533/2013 e 914/2016, il potere ministeriale di individuare un bene culturale e di sottoporlo alla relativa tutela è quindi un potere originario, che non si riduce ad un intervento sostitutivo di quello regionale; si osserva in proposito che attribuire un tale potere di intervento all’autorità centrale è perfettamente compatibile con la Costituzione, e non lede le autonomie locali, dato che, per costante giurisprudenza della Corte, per tutte 20 luglio 2016 n.189 e 30 dicembre 1987 n.641, la tutela del paesaggio e dell’ambiente deve essere unitaria e omogenea su tutto il territorio nazionale. Dalla qualificazione di tale potere come originario, discende poi, sotto il profilo procedurale, che il suo esercizio non viola il dovere di leale collaborazione con le autonomie locali nel momento in cui, come nella specie non è contestato sia avvenuto, il Ministero acquisisca il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Regione interessata.
10.11 L’esercizio del potere di vincolo comporta poi, come si è detto, che il Ministero venga a dettare le specifiche disposizioni di tutela del bene che si impongono sulla pianificazione degli enti locali., e ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza non perché il Ministero pianifichi in sostituzione della Regione, ma perché si tratta di proteggere un valore cui la Costituzione assegna rango prevalente: in sintesi l'individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela s'impone e prevale sul potere pianificatorio regionale: così per tutte la citata C.d.S. 533/2013. Il risultato ultimo, osserva sempre la giurisprudenza, può in fatto frustrare le aspettative dei privati proprietari, interessati invece ad edificare e a urbanizzare le aree tutelate; peraltro, non sussiste in proposito un affidamento in senso giuridico che sia tutelabile, dato che esso, a tutto voler concedere, riguarderebbe propriamente profili urbanistici, non profili di tutela del patrimonio culturale, che si distinguono dai primi e su di essi prevalgono appunto ai sensi dell’art. 9 Cost: così la citata C.d.S. 3893/2012.
11. Applicando i principi sopra delineati al caso di specie, è infondato anzitutto il primo motivo di appello, centrato sul presunto carattere illogico del vincolo apposto su un’area particolarmente estesa. Come si è detto, e come è stato condivisibilmente affermato dal Giudice di I grado, l’ampiezza dell’area non è di per sé ostacolo ad imporvi un vincolo di bene culturale, ove l’area stessa, complessivamente intesa, ne rivesta i caratteri. Ciò è senz’altro vero nel caso di specie, dato che, secondo la relazione storico artistica che si è richiamata, l’area stessa costituisce memoria di una particolare destinazione agricola dell’entroterra di Roma e delle strutture che a tale destinazione si sono accompagnate: si tratta di una conclusione conforme al dato storico di comune esperienza, che non si può certo qualificare come illogica o arbitraria. Che poi in concreto i terreni di proprietà della ricorrente appellante non presentino ciascuno in ogni sua parte tali caratteristiche non impedisce, come si è pure visto, che il carattere unitario dell’area complessivamente intesa sussista e sia tutelabile.
12. I restanti tre motivi sono fra loro connessi, dato che riguardano diversi aspetti del rapporto fra il vincolo e le sue prescrizioni, da un lato, e la pianificazione urbanistica pregressa dall’altro; vanno quindi trattati congiuntamente e risultano tutti infondati.
12.1 In primo luogo, e ciò porta a respingere il quarto motivo, non risponde al vero che il Ministero, per agire legittimamente, si sarebbe dovuto confrontare, in termini concretamente non precisati con gli enti locali, e in particolare avrebbe dovuto acquisire e valutare tutti gli atti e le istanze di permesso di costruire relative ai terreni interessati, fra i quali quindi anche quelli della ricorrente appellante. Si è infatti già visto che il Ministero, nell’esercizio del potere che gli spetta in via originaria ai sensi dell’art. 141, si intende avere rispettato l’obbligo di leale collaborazione con gli enti locali nel momento in cui si sia conformato alla disciplina prevista sul punto dalla stessa legge, in particolare quando abbia richiesto il parere della Regione ai sensi dell’art. 138 comma 3; si osserva poi in aggiunta che al procedimento in esame è comunque consentita la partecipazione degli altri possibili interessati, pubblici e privati, in particolare dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle associazioni dato che ai sensi dell’art. 141 comma 2 il Ministero è tenuto a valutare eventuali osservazioni da essi proposte. Si è parimenti visto che il potere di vincolo qui rilevante persegue un interesse diverso e di rango superiore rispetto all’interesse ad edificare un terreno libero.
12.2 Tale ultima considerazione porta a respingere il secondo e terzo motivo, secondo i quali, in sintesi, l’imposizione del vincolo non avrebbe tenuto conto dell’interesse del privato a urbanizzare l’area: si è visto, ancora una volta, che l’ipotetico affidamento in tal senso cede di fronte alla tutela del bene culturale, tutela che quindi può impedire lo sfruttamento dell’area mediante nuove edificazioni, se pure le stesse fossero in origine compatibili con la pianificazione di area.
13. La complessità e particolarità della controversia è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato (ricorso n.266/2019 R.G.), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore