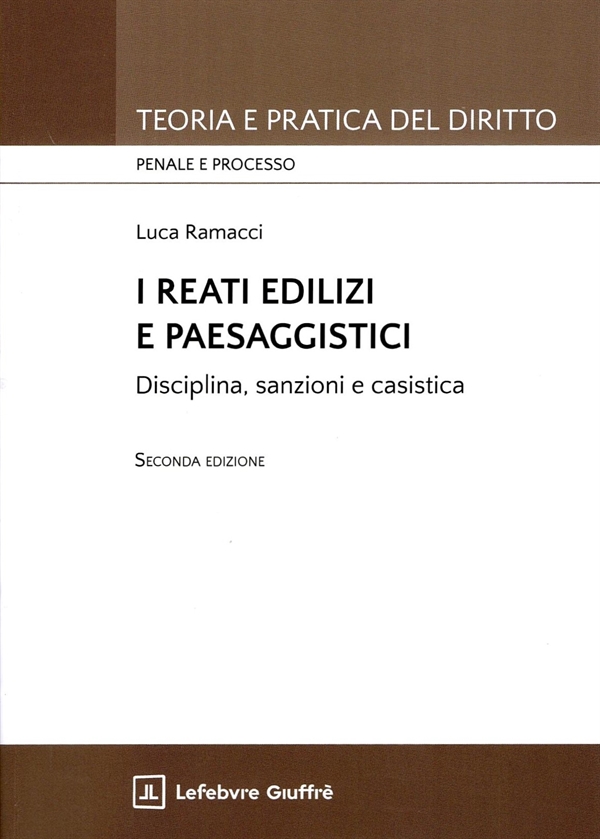Cassazione, scarichi e utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento
Cassazione, scarichi e utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento
di Gianfranco AMENDOLA
pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore
Di recente1 la Cassazione è tornata ad occuparsi di inquinamenti provocati da allevamenti di bestiame, argomento che, come le imprese agricole, è sempre stato oggetto di benevola attenzione da parte del legislatore. L’occasione è stata una sentenza del Tribunale di Bari che, modificando la originaria imputazione, formulata dal P.M., di scarico senza autorizzazione in quella di utilizzazione agronomica irregolare, aveva condannato il legale rappresentante di un’azienda agricola in relazione alla immissione su terreno di reflui da allevamento.
In fatto, la vicenda è semplice e non controversa: nel caso di specie, infatti, come ammesso anche dalla difesa, il letame prodotto dall’azienda zootecnica veniva ammassato su una platea destinata allo stoccaggio dello stesso, priva di cordolo e di un sistema di convogliamento per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui, con l’ovvia conseguenza che, in via del tutto accidentale e disomogenea, i liquidi provenienti dal letame stoccato si riversavano sul terreno seminativo adiacente alla platea di stoccaggio.
In realtà, quindi, le problematiche giuridiche da considerare sono due e riguardano la rilevanza penale di questi sversamenti con riferimento sia alla disciplina degli scarichi sia a quella della utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento. Giova, pertanto, a questo punto, delineare, con la Cassazione, un quadro sintetico della normativa del D. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA) attinente queste due problematiche2:
1) Quanto alle acque reflue, l’art. 101, comma 7, dettando i criteri generali della disciplina degli scarichi, stabilisce che “sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura” (lett. a) ovvero “provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame” (lett. b).
A questo proposito, si deve ricordare che la lettera b) inizialmente richiedeva che dovesse trattarsi di effluenti di allevamento i quali “praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”; con la conseguenza che, in assenza di queste condizioni, gli effluenti di allevamento rientravano nell’ambito delle “acque reflue industriali” ed il loro scarico non autorizzato era punito con la sanzione penale di cui all’art. 137, comma 1; ma questa parte veniva eliminata dall’articolo 2, comma 8, D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 16. E quindi, come precisa la sentenza in esame, “mentre con la normativa pregressa le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche …. nell’attuale assetto normativo, per effetto della caducazione suindicata, l’assimilazione prevista dell’art. 101, comma 7, delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame, diviene la regola (Sez.3, n.26532 del 21/05/2008, Rv.240552)”. Si tratta, insomma, di una “assimilazione secca”, per cui è evidente che le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame sono oggi assimilate tout court alle acque reflue domestiche; e pertanto il loro scarico non autorizzato non ha rilevanza penale ma è punito solo con sanzione amministrativa (art. 133, comma 2 TUA).
2) Per quanto concerne l’utilizzazione agronomica -e cioè, come specifica l’art. 74, comma 1, lett. p) del TUA, “la gestione di effluenti di allevamento,,,,, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute”-, l’art. 112 stabilisce un obbligo di comunicazione rinviando, per la regolamentazione, alla disciplina regionale, prevedendo (art. 137, comma 14) sanzione penale (ammenda da euro 1500 a euro 10.000 o l’arresto fino ad un anno) qualora la fertirrigazione venga svolta in casi non consentiti dalla legge o con modalità difformi da quelle consentite.
Nel caso di specie, come si è detto, è pacifico che i liquami non erano affatto destinati ad una utilizzazione finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute ma si riversavano sul terreno in via del tutto accidentale e non omogenea; e, pertanto, come rilevato dalla difesa e dalla Suprema Corte, non ricorrevano affatto gli elementi richiesti per il reato, ritenuto in condanna, di utilizzazione agronomica irregolare di effluenti di allevamento.
In sostanza, quindi, la vicenda in esame attiene ad acque reflue non industriali ma assimilate a quelle domestiche, e non si tratta di fertirrigazione. Pertanto, non sussiste nessuno dei due reati contestati in primo grado: né, cioè, lo scarico non autorizzato (relativo solo ad acque reflue industriali) né quello collegato alla disciplina della fertirrigazione.
Ma fortunatamente la Cassazione va oltre e vede quello che non era stato rilevato in primo grado né dal P.M. né dal Tribunale concludendo che non si tratta affatto di scarico ma ricorre, invece, il reato di cui all’art. 256, comma 2, il quale punisce i “titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti”. E, a questo proposito, richiama la sua costante giurisprudenza secondo cui per “scarico” si deve intendere l’immissione diretta nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni mentre, in assenza di queste condizioni è ipotizzabile, appunto, il reato di abbandono di rifiuti liquidi.
Rinviando alla sentenza in esame per un puntuale esame della giurisprudenza anche con specifico riferimento agli effluenti di allevamento di bestiame, sembra opportuno aggiungere solo che questa conclusione è totalmente condivisa dalla Corte europea3 la quale, sin dal 2007, ha precisato che “ il legislatore comunitario ha inteso qualificare espressamente le acque di scarico come «rifiuti», ai sensi della stessa direttiva pur prevedendo che tali rifiuti possano, al ricorrere di talune condizioni, non rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima e, conseguentemente, nel regime giuridico generale che essa istituisce” (n. 26), aggiungendo che la nozione di rifiuto non va mai interpretata restrittivamente e che vi rientrano anche fuoriuscite accidentali di acque reflue. Quindi, di regola, anche le acque di scarico, ed anche se scaricate accidentalmente, sono disciplinate dalla normativa sui rifiuti. E, oltre ai precedenti citati dalla sentenza in esame, vale la pena di ricordare che “ in materia di rifiuti, integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. Costituisce infatti “ruscellamento” vietato, ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui. “4; e che “la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicché, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti”5.
In conclusione, quindi, secondo la Cassazione non sussistevano i reati contestati in primo grado bensì quello “nuovo” di abbandono di rifiuti.
E, a questo proposito, ha ritenuto, rigettando semplicemente il ricorso, non necessario il rinvio del processo ad altra data in quanto <<il fatto riqualificato da questa Corte non può dirsi contestato “a sorpresa” rispetto a quella che era l’originaria contestazione – ossia l’effettuazione di scarichi di reflui zootecnici senza la prescritta autorizzazione -, poi riqualificata erroneamente dal giudice, il quale ha ritenuto configurabile la violazione di cui agli artt. 101, comma 7, 112 e 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006, del tutto erronea>>. E pertanto, <<la diversa qualificazione giuridica operata da questa Corte appare come uno dei naturali e «non sorprendenti» epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa>>.
Insomma -dice la Suprema Corte- i fatti erano noti e cambia solo la loro qualificazione giuridica per cui non è necessario fare alcun rinvio visto che non c’è niente di nuovo rispetto a quello che era stato portato a conoscenza dell’imputato e della sua difesa.
Ragionamento che appare del tutto aderente alle regole formali ma che, francamente, lascia qualche perplessità rispetto alla reale salvaguardia del diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, la errata qualificazione giuridica del fatto è stata operata prima dal P.M. e poi dal Tribunale; ed è su questa base giuridica che ha discusso la difesa, non prendendo, quindi, affatto in considerazione la possibilità che potesse esservi una ipotesi di reato diversa, come poi ha ritenuto la Suprema Corte. Tanto più che la diversa qualificazione operata dalla Cassazione circa la differenziazione tra scarico e sversamento di rifiuti liquidi non è affatto evidente a prima vista ma si basa su una elaborata interpretazione giurisprudenziale, certamente condivisibile, ma che non tutti conoscono: di sicuro, peraltro non sembra la conoscessero né il P.M. né il Tribunale, prima ancora della difesa.
Detto questo, la conclusione è semplice: il TUA è una pessima legge che ha subito e continua a subire continue correzioni e integrazioni per cui è opportuno consultare ogni volta il testo attualmente in vigore dal sito “Normattiva” e verificare le elaborazioni giurisprudenziali, come quella ricorrente nel caso in esame. Insomma, tutto il contrario di una legge semplice e facilmente comprensibile anche dai non addetti ai lavori così come sarebbe ancor più doveroso dopo l’inserimento in Costituzione del valore ambiente.
- https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-liquami-zootecnici-2
- Ci sia permesso, in proposito, per approfondimenti, citazioni e richiami, rinviare al nostro Diritto penale ambientale, Pacini Giuridica, Pisa 2024, pag. 76 e segg.↩︎
- CGCE, sez. 2, 10 maggio 2007, proc. C-252/05↩︎
- Cass., pen., sez. 3, n. 48596 del 17 novembre 2016 (cc 20 ott 2016), Colombo↩︎
- Cass. pen., sez. 3, n. 5738 del 10 febbraio 2023 (UP 2 feb 2023)↩︎



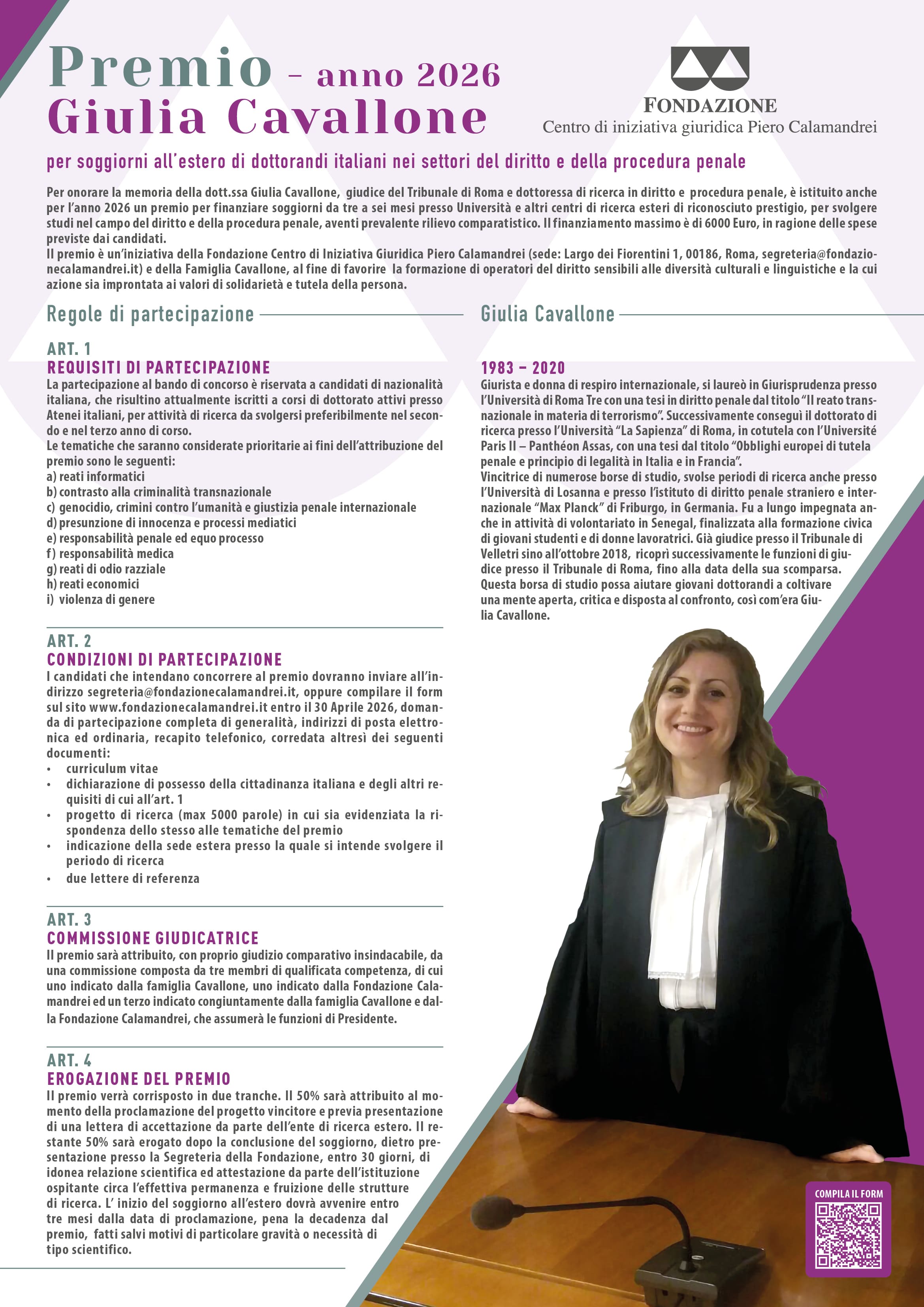 Scarica la locandina
Scarica la locandina