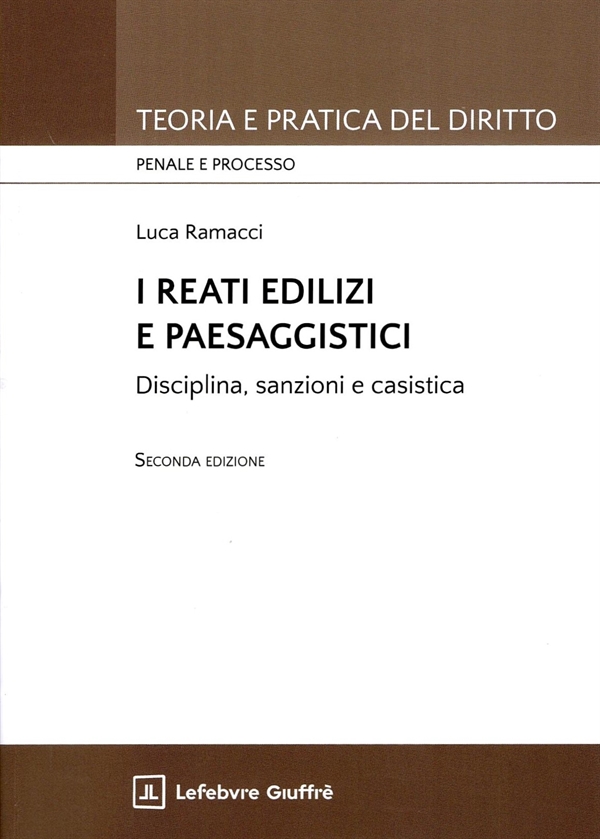La nuova
nozione di rifiuto
di Mauro Sanna
Relazione tenuta al corso "Gestione dei Rifiuti" Rispescia (GR) maggio 2003 presso il Centro Studi di diritto Ambientale dei CEAG - Legambiente
Sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2002 è stato pubblicato il D.L. 8 luglio
2002 n. 138, contenente all’art. 14 la interpretazione autentica della
definizione di “rifiuto” di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del DLgs
22/97 dove il rifiuto è indicato come ”qualsiasi sostanza o oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi“.
Quanto
al momento in cui un rifiuto si origina, esso si ricava dalla definizione del
“produttore”, di cui alla successiva lett.b) del primo comma dell’art. 6,
che lo individua come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”.
Per
cui il rifiuto, oltre ad originarsi al momento della sua produzione, avrà
origine anche da attività successive a questa e svolte da soggetti diversi dal
produttore, quali:
- operazioni di
pretrattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- operazione di
miscuglio che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- altre
operazioni in genere che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
Sulla
base della lettera d) del medesimo comma, tutte le azioni successive connesse
con il disfarsi di un rifiuto - raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento- rientrano quindi tra le attività di gestione di
un rifiuto.
Tralasciando
la nozione di smaltimento , non utile in questa sede, si tenterà invece di
esplicare la nozione di recupero.
Il
recupero può avvenire con operazioni semplici o complesse a seconda del numero
e della qualità delle trasformazioni a cui il rifiuto iniziale è assoggettato
per poter essere recuperato.
Tali
operazioni saranno diverse a seconda che il recupero riguardi una sostanza o un
oggetto, oppure che si abbia recupero in un ciclo di produzione o di consumo, o
ancora che il recupero sia di materia o di energia.
Le
attività di recupero realizzate si
distingueranno, oltre che per il numero ed il tipo delle operazioni che le
compongono, anche in relazione alla nuova utilizzazione a cui è destinato il
rifiuto recuperato.
Il
recupero, con un ampia definizione che possa comprendere tutte queste variabili,
può considerarsi come l’insieme delle operazioni di reimpiego, di
riutilizzazione e di riciclo, che consentono di valorizzare, riutilizzare,
reimpiegare ed in genere recuperare le risorse di materia o di energia contenute
in un rifiuto, cosicché possano essere reintrodotte in cicli di produzione,
sottraendole alla distruzione o alla perdita totale, cioè allo smaltimento.
Relativamente
alle operazioni comprese nell’attività di recupero, esse possono essere
definite come segue:
-
reimpiego: nuovo impiego di un oggetto tal quale dopo un primo ciclo
d’uso, con le stesse modalità e finalità, senza che l’oggetto originale
subisca modifiche sostanziali ;
-
riutilizzazione: utilizzazione di una sostanza dopo un primo ciclo
d’uso, in uno successivo, uguale o diverso dal primo e più spesso secondario
rispetto a quello originario ;
-
riciclo: operazione per la quale , terminato un ciclo di utilizzo di una
sostanza o di un oggetto, tutta la materia prima di partenza
presente in esso o parte di questa è recuperata
come tale o come energia, con una sua parziale o totale trasformazione,
anche sostanziale, riportandola in lavorazione mediante una nuova immissione in
un ciclo produttivo..
Le
attività elencate nell’allegato C del DLgs 22/97 sono di fatto tutte attività
di recupero che possono esser ricondotte a quelle di riciclo, tant’è che per
molte operazioni questo termine è usato come sinonimo.
Solo
per le operazioni R2, R6 ed R9 il recupero è fatto coincidere con la
rigenerazione, cioè con un trattamento preliminare necessario al reimpiego o al
riutilizzo di una sostanza o di un oggetto, che di fatto non subiscono però
alcuna trasformazione sostanziale.
Le
operazioni di recupero elencate nell’allegato C possono essere perciò
suddivise in due tipologie.
-
Operazioni di rigenerazione, che non modificano in modo sostanziale la
sostanza o l’oggetto iniziale, ma ripristinano solo il suo uso originario:
·
R2, rigenerazione/recupero
di solventi;
·
R6, rigenerazione degli
acidi e delle basi;
·
R9, rigenerazione o altri
impieghi degli oli;
-
Operazioni di riciclo, che modificano in modo sostanziale la sostanza o
l’oggetto iniziali, che vengono poi ad essere destinati ad altri cicli di
produzione e consumo:
· R1, utilizzazione
principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
· R3, riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi ( comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche);
·
R4, riciclo/recupero dei
metalli o dei composti metallici;
·
R5, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
·
R7, recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
·
R8, recupero dei prodotti
provenienti dai catalizzatori;
·
R10, spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o
dell’ecologia.
Vi
sono poi le operazioni R11, R12 ed R13 che sono comuni alle due tipologie di
recupero, che precedono o seguono le specifiche operazioni:
·
R11, utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate
da R1 a R10;
·
R12, scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate
da R1 a R11;
· R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta nel luogo in cui
sono prodotti).
Se
alla luce di quanto sopra, si esamina il contenuto nell’art. 14 del D.L. 8
luglio 2002 n. 138, in particolare il comma 1 lett. c), si evidenzia come le
condizioni che determinano l’obbligo di disfarsi di un rifiuto sono:
-
quando è stabilito da una disposizione di legge;
-
quando è stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità;
-
quando è imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del
bene;
-
quando i rifiuti siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all’allegato D del decreto legislativo n.22.
Si
ha perciò che, nel caso che un
rifiuto sia classificato come pericoloso perché inserito nell’allegato D
(peraltro abrogato dalla decisione 2001/118/CE e successive modificazioni ed
integrazione ), sussiste sempre l’obbligo di disfarsene e quindi non può
essere oggetto di decisioni alternative da parte del produttore o detentore dei
rifiuti.
Ne
consegue che quanto riportato nel comma 2 dell’art.14 del D.L. 138/2002 a
proposito del possibile esercizio della volontà di disfarsi di un rifiuto,
potrà riguardare solo i
rifiuti speciali non pericolosi e non i rifiuti pericolosi per i quali, come
stabilito alla lett.c) del primo comma, sussiste sempre “l’obbligo di
disfarsi”.
Perciò
per i rifiuti speciali, e solo per essi, il comma 2 del D.L. esplicita le due
condizioni che, quando sussistono, fanno venir meno a priori la decisione del
disfarsi e quindi la presenza del rifiuto.
La
prima condizione da verificare è ”se gli stessi (rifiuti) possono essere e
sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo
di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente” (comma 2
lett. a).
Sulla
base di detta condizione, perciò, non ci si troverà in presenza di un rifiuto
ogni qualvolta una sostanza od un oggetto, senza alcun intervento preventivo di
trattamento, siano riutilizzati o reimpiegati nel ciclo produttivo e di consumo
originario, o in uno analogo o diverso, quando cioè la sostanza o l’oggetto
tal quali entrano in un nuovo ciclo produttivo successivo al primo.
Queste
operazioni d’altra parte, non sono comprese nell’allegato C del D.Lg.22/97
che, come detto contempla sempre, come attività di recupero, solo attività di
riciclo o di rigenerazione .
Pertanto
nessuna innovazione è apportata alla disciplina del recupero da
quanto previsto dalla lett. a) del comma 2 del D.L. 138/ 02 .
La
seconda condizione indicata dalla lett. b) del medesimo comma, prevede che una
sostanza o un oggetto non siano da considerare rifiuti, venendo meno per essi
l’intenzione di disfarsene, “quando gli stessi possono essere e sono
effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato
C del decreto legislativo n.22” (comma 2 lett.b))
Sulla
base di questa deroga si ha che, pur se la sostanza o l’oggetto sono usciti
dal
ciclo produttivo iniziale e quindi il produttore o detentore se ne è
disfatto, se vengono assoggettati ad un trattamento preventivo (non meglio
identificato), per essi non ricorrerà più la decisione di disfarsene e quindi
non saranno più da considerare rifiuti, purché successivamente non intervenga
una operazione di recupero prevista dall’allegato C al D.Lgs. 22/97.
Il
problema è comprendere cosa debba intendersi per “trattamento preventivo”.
Esso
dovrà certamente essere un trattamento che di fatto permetta alla sostanza ed
agli oggetti di essere riimmessi direttamente in un ciclo produttivo.
Tuttavia,
non essendo operazione di recupero finale di sostanza o di energia, potrà
essere solo un trattamento che prepari il rifiuto originario ad essere
riutilizzato, cioè una rigenerazione della sostanza o dell’oggetto iniziali,
che ne consenta l’impiego o l’utilizzo in un ciclo produttivo successivo.
Tale
trattamento preventivo perciò potrà essere solo una delle operazioni di
rigenerazione R2,R6 o R9, previste dall’allegato C del D.Lgs. 22/97 non certo
una delle altre operazioni di recupero R1,R3,R4,R5,R7,R8 ed R10 perché queste
sarebbero tutte operazioni definitive e non preparatorie. Anche per questo
aspetto quanto previsto dalla lett. b) del secondo comma dell’art.14 non
sarebbe affatto innovativo rispetto al D.Lgs. 22/97 e alla normativa europea.
E’
infatti evidente che un olio rigenerato mediante un’operazione R9 non è più
un rifiuto, ma una materia prima; analogamente un acido o una base rigenerati
attraverso una operazione R6 ed egualmente un solvente rigenerato attraverso una
operazione R2..
In
tutti questi casi si avrebbe al termine dell’operazione di
recupero/rigenerazione una sostanza direttamente riutilizzabile in un ciclo
produttivo.
Diversa
è invece la situazione se il trattamento preventivo rientra tra le operazioni
di smaltimento previste dall’allegato B del D.Lgs. 22/97. Infatti, in questo
caso è evidente che da una operazione di smaltimento di un rifiuto, qualsiasi
essa sia - trattamento biologico D8, trattamento chimico fisico D9
raggruppamento preliminare D13, o ricondizionamento D14- non potrà mai derivare
una sostanza o un oggetto che non siano rifiuti; sarebbe infatti una
contraddizione nei termini che da
una attività di smaltimento derivasse una materia prima.
D’altra
parte anche dalla definizione risulta chiara la differenza che intercorre tra
un’attività di ricondizionamento ed una di rigenerazione: nel primo caso si
avrà un trattamento di sostanza o oggetto, usciti da un ciclo produttivo, che non conduce ad un
prodotto definitivo, ma prepara solo il rifiuto per essere sottoposto ad una
operazione di smaltimento finale; nel caso della rigenerazione invece si avranno
una sostanza o un oggetto che, usciti da un ciclo produttivo,
sono resi idonei ad entrare direttamente in un altro ciclo produttivo
come materia prima.
In
conclusione nel caso di ricondizionamento o di raggruppamento, essendo queste
attività di smaltimento intermedio, per il rifiuto trattato sussisterà sempre
l’alea che esso possa avere un destino non conforme a quello previsto dalla
normativa sui rifiuti e per questo esso dovrà essere assoggettato a tale
disciplina fino al suo destino finale.
Tale
conclusione è quella che è stata più volte enunciata anche dalla Corte di
Giustizia Europea.
E
in effetti, se una sostanza è stata solo ricondizionata,
ma non rigenerata, nel successivo utilizzo o recupero definitivo, anche
trattandosi di un ciclo produttivo in cui non intervengano materie prime,
verrebbero tuttavia meno quelle cautele di carattere sanitario e ambientale che
sono invece previste nel trattamento di un rifiuto.
Basti
ricordare nell’ambito della produzione di energia, la combustione di un
rifiuto, sottoposto solo a raggruppamento o condizionamento, senza che siano
adottate le cautele di combustione o controllo previste per un rifiuto; oppure
nel campo del recupero di materia, la fusione di un rifiuto, assoggettato solo a
raggruppamento o condizionamento, operazioni che di fatto non eliminano le
sostanze inquinanti presenti nel rifiuto stesso, che vengono perciò combuste in
un ciclo tecnologico di fusione destinato a materia prima non contaminata.