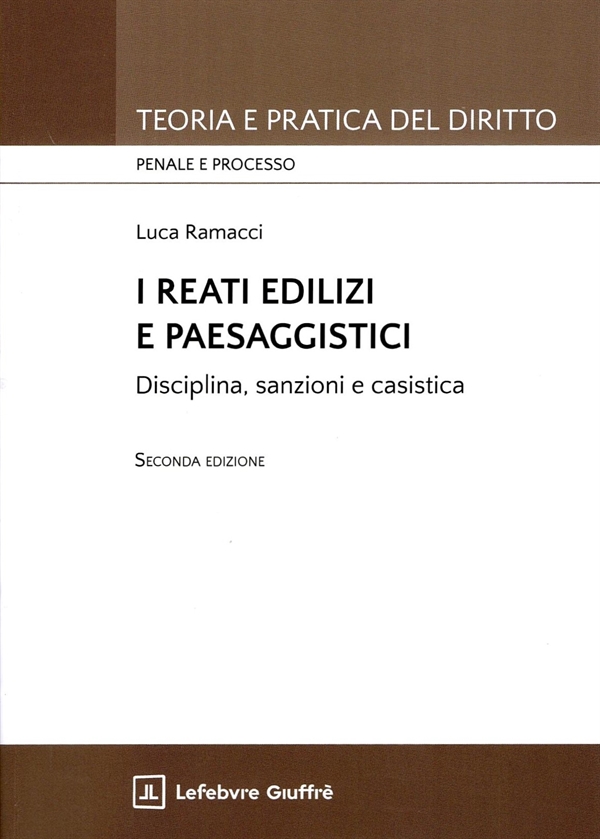INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ATTIVITA’ DI CONTROLLO NELLE AREE DI MARGHERA E MURANO (VENEZIA) di Luca RAMACCI
L’attività di indagine in materia di inquinamento atmosferico non è
particolarmente frequente e, nel complesso panorama delle violazioni di norme
ambientali, costituisce quasi un’eccezione. Le difficoltà tecniche che
caratterizzano i controlli rendono infatti estremamente difficoltoso
l’intervento di personale che, purtroppo frequentemente, non dispone delle
specifiche conoscenze tecniche per effettuare le verifiche.
L’attività di analisi, in particolare, presenta
notevoli difficoltà operative, richiede tempi anche lunghi e costi non
indifferenti.
Tali difficoltà non risultano, tuttavia, limitate
alla sola attività di campionamento e controllo delle emissioni, poiché anche
la valutazione della semplice rispondenza degli impianti al regime
autorizzatorio previsto per le singole tipologie richiede una specifica
conoscenza tecnica e la capacità di confrontare le caratteristiche reali
dell’impianto con quelle risultanti dalla documentazione esaminata. Nondimeno,
anche l’impianto normativo che regola tale particolare materia presenta
particolare complessità e difficoltà interpretative.
Se a ciò si aggiunge, poi, la notoria scarsità
dei controlli e la ormai cronica inefficienza dei soggetti chiamati ad
eseguirli, non sembrerà strano che – in circa tredici anni dall’entrata in
vigore del D.p.r. 20388 – siano state emesse dalla Corte di cassazione
soltanto trentasei pronunce meritevoli di essere massimate[1].
Come invece potrà osservarsi analizzando i
risultati dell’indagine effettuata a Venezia, nell’area industriale di
Marghera ed in quella di Murano, le verifiche di singoli impianti, specie se
individuati per categoria, consente di avere la chiara percezione della reale
situazione e, occorre dirlo, dell’indifferenza di controllori che, nella
migliore delle ipotesi, appaiono fin troppo distratt
L’indagine trae origine dai risultati di più
vasti accertamenti finalizzati ad individuare lo stato di inquinamento
dell’area lagunare veneziana - che, come è noto, rappresenta un ecosistema
particolarmente complesso, di notevole estensione e con soli tre accessi al mare
aperto – dopo le ripetute ed eclatanti segnalazioni di una nota associazione
di protezione ambientale.
A tale scopo venivano commissionate nel periodo
1995 - 1997, dalla Procura Circondariale del capoluogo lagunare, alcune campagne
di monitoraggio aventi lo scopo di accertare non solo lo stato effettivo di
inquinamento, ma anche la sussistenza di pericoli per la salute pubblica.
Il primo studio[2] prendeva in esame il
sedimento lagunare esistente sullo strato superficiale del fondale mediante il
prelievo di 53 reperti in 14 diverse zone di campionamento, precedentemente
individuate per la successiva ricerca di microinquinanti tossici, con
conseguente acquisizione di oltre 1600 “dati analitici effettivi” evidenzianti la
presenza di sostanze altamente nocive perché cancerogene e/o mutagene.
Le cause dell’inquinamento venivano indicate, per l’area industriale,
nella presenza di stabilimenti produttivi in genere e nella utilizzazione, da
parte di alcuni di essi, di particolari processi di lavorazione e, per quanto
attiene all’area urbana, nelle attività ad essa connesse. In tale ultimo
caso, la mancanza di un adeguato sistema fognario contribuisce sensibilmente al
degrado dell’ambiente lagunare a seguito dell’immissione di reflui, non
trattati, provenienti prevalentemente (ma non esclusivamente a causa della
presenza di insediamenti artigianali e produttivi in area urbana) da
insediamenti abitativi.
Ulteriori conseguenze negative sono poi determinate dall’intenso traffico
navale, prevalentemente di piccolo cabotaggio e finalizzato al trasporto di
merci e persone, al quale veniva attribuita la elevata presenza di residui della
combustione dei carburanti e di prodotti del deterioramento delle parti
metalliche delle imbarcazioni a contatto con l’acqua.
Con riferimento specifico all’area industriale, si osservava poi che la
presenza degli agenti inquinanti non consegue esclusivamente alla immissione di
reflui in laguna, ma anche dalla presenza di depositi di rifiuti industriali a
contatto con l’acqua.
Un ulteriore e non secondario contributo al complessivo inquinamento
dell’area lagunare veniva invece individuato nella ricaduta di sostanze
inquinanti immesse in atmosfera dagli impianti esistenti nell’area industriale
di Marghera e, seppure in minore quantità, dagli insediamenti esistenti
nell’Isola di Murano ed adibiti alla lavorazione del vetro[3].
Una seconda campagna di rilevamenti, eseguiti con mezzi aeronavali,
confermava i risultati dei primi accertamenti[4]
così come un ulteriore studio[5]
evidenziava altre conseguenze dell’inquinamento ed i possibili danni per la
salute.
A fronte di tale quadro preoccupante venivano disposte diffuse indagini
(tuttora non ultimate) finalizzate ad individuare eventuali responsabilità con
particolare riferimento all’inquinamento idrico da insediamenti industriali e
da scarichi insistenti nell’area urbana, all’inquinamento da rifiuti ed
all’inquinamento atmosferico.
La prima campagna di accertamenti, nel settore che qui interessa, veniva
avviata nell’area industriale di Marghera dopo una preventiva verifica delle
segnalazioni di reato pervenute nell’arco degli ultimi 18 mesi a seguito della
quale si riscontrava che, in tale lasso di tempo, erano state inoltrate dai
soggetti adibiti al controllo soltanto 37 notizie di reato per l’intero
territorio di competenza (corrispondente all’intera provincia di Venezia) a
fronte di oltre 4000 punti di emissione solo nella zona industriale di Marghera
(che, occorre ricordarlo, è semplicemente un quartiere anche se di notevole
estensione).
Le indagini sono state dunque finalizzate a
verificare il rispetto della vigente disciplina in materia di immissioni in
atmosfera (D.p.r. 20388) da parte di soggetti aventi stabilimenti o altri
impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che davano
luogo ad emissioni inquinanti
convogliate o tecnicamente convogliabili costituenti rischio potenziale di
inquinamento atmosferico.
Venivano considerati, in
modo particolare, gli insediamenti con impianti esistenti alla data del 1°
luglio 1988 appartenenti alle categorie indicate nell’Allegato 1 dal D.P.C.M.
21 Luglio 1989[6]
e ciò considerando come le notevoli portate di detti impianti inducano a
ritenere che le emissioni generate dagli stessi apportino il maggiore contributo
all’inquinamento atmosferico della zona.
I consulenti nominati[7] effettuavano gli
accertamenti unitamente a personale del Nucleo Tutela Ambiente della Sezione di
Polizia Giudiziaria della Procura e del personale della Guardia di Finanza –
Sezione Operativa Navale di Venezia.
A tale proposito appare utile sottolineare come
l’attività di indagine abbia richiesto necessariamente l’intervento di
personale di Polizia Giudiziaria unitamente a personale avente specifiche
competenze tecniche.
L’apporto della P.G. è stato, in un primo
tempo, contenuto nell’espletamento di attività di acquisizione di atti e
documentazione dell’attività svolta e, successivamente, si è esteso
all’espletamento di atti ulteriori quali l’assistenza all’attività di
campionamento e l’esecuzione di provvedimenti del G.I.P. dei quali si dirà più
dettagliatamente in seguito.
La prima attività di verifica ha avuto ad oggetto l’acquisizione di tutta
la documentazione relativa agli obblighi amministrativi previsti dal DPR 203/88
presentata dai titolari degli insediamenti all’ente competente
(all’epoca la Regione cui subentrava, successivamente, la Provincia).
Nei casi in cui il controllo documentale dava esito positivo, evidenziando la
mancanza dell’autorizzazione o la violazione di altre disposizioni formali,
veniva in un primo tempo richiesto il sequestro preventivo “condizionato”
degli impianti. Tale forma di
sequestro subordinava l’esecuzione della misura all’effettivo adeguamento
degli impianti alla normativa vigente entro un termine prefissato (ed
eventualmente prorogabile) ed alla esecuzione, a cura e spese del titolare
dell’impianto stesso, ma sotto il diretto controllo dei tecnici e della P.G.,
dei rilievi analitici dei fumi immessi in atmosfera.
La soluzione si rendeva necessaria in quanto le analisi dei fumi
presuppongono il regolare funzionamento degli impianti da controllare, di fatto
impossibile in caso di sequestro. Si otteneva, inoltre, la messa a norma in
tempi rapidi degli impianti salvaguardando contemporaneamente le esigenze
economiche dell’imprenditore che non vedeva interrotta la produzione.
La presenza di sostanze inquinanti o il superamento dei limiti di legge
evidenziate dalle analisi nonché il mancato adeguamento amministrativo
comportavano l’immediata esecuzione del sequestro prima “sospeso”.
L’accertata rispondenza dell’impianto ai requisiti di legge determinava,
al contrario, la revoca della
misura cautelare reale e la possibilità di definire il procedimento penale
mediante oblazione o applicazione pena.
All’evidente forzatura interpretativa necessaria per l’adozione del
sequestro “condizionato” e, tutto sommato, produttiva di effetti vantaggiosi
tanto per l’inquirente che per l’indagato, poneva fine la Corte di
cassazione mutando l’orientamento espresso in una precedente pronuncia[8].
Osservava infatti la Corte[9] che “L'istituto del
sequestro preventivo non tollera l'apposizione di clausole, quali il termine o
la condizione, che alterino struttura, conseguenze e finalità legislativamente
determinate come proprie della misura. Non è pertanto ammissibile il c.d.
sequestro condizionato la cui esecuzione viene differita e subordinata
all'adempimento di specifiche prescrizioni entro un termine prefissato”
Venuta meno la possibilità del “sequestro condizionato” si è ovviato
mediante l’applicazione dell’articolo 85 disp. att. C.P.P. individuando, di
volta in volta, le soluzioni pratiche per consentire l’espletamento del
campionamento e delle analisi.
Va detto, comunque, che l’adozione di tale soluzione ha dato risultati più
che soddisfacenti poiché la maggior parte delle aziende controllate ha
proceduto all’adeguamento degli impianti oppure, nel caso in cui gli
interventi da eseguire risultavano particolarmente dispendiosi, ha
definitivamente eliminato gli impianti smantellandoli.
Le indagini hanno anche
evidenziato diversi fatti di rilevanza penale addebitabili ai soggetti preposti
alla definizione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in quanto
alcuni decreti di autorizzazione erano stati rilasciati in palese contrasto con
le norme vigenti, favorendo di fatto i soggetti che li avevano ottenuti.
Nell’ambito
dell’indagine riguardante gli insediamenti industriali di Marghera sono stati
controllati 53 insediamenti individuati, come si è detto, tra quelli a maggior
rischio di inquinamento con un numero complessivo di punti di emissione pari a
circa 1200. Secondo i CC.TT. tali impianti forniscono il maggior contributo
all’inquinamento atmosferico nella zona industriale di Marghera.
Dall’esame finale dei dati effettuato dai medesimi consulenti[10]
è emerso che
-
11
impianti risultavano non più
attivi o con impianti dismessi (per questi impianti i consulenti hanno
riscontrato un diffuso contrasto con la normativa vigente in quanto operanti con
apparecchiature obsolete notevolmente inquinanti
e con valori di emissioni superiori a quelli previsti dalla normativa
tecnica).
-
4
impianti risultavano
rientrare tra quelle ad inquinamento poco significativo
-
3
impianti risultavano non
soggette agli obblighi previsti dal D.p.r. 20388
-
35
impianti risultavano
esistenti e con impianti ancora in esercizio
I
35 insediamenti “attivi” sono stati poi sottoposti ad ulteriori
e più approfonditi controlli ottenendo i seguenti risultati:
-
il 69% degli
insediamenti (24 su 35) sono risultati in contrasto con la normativa vigente
-
il 31% sono
risultati conformi (11 su 35).
In
occasione dei controlli sulle aziende non in regola si è accertata la
commissione di 66 reati contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di
inquinamento addebitati ai vari responsabili unitamente ad altre violazioni
successivamente riscontrate.
Tali violazioni riguardano prevalentemente gli articoli 24 e 25 del D.p.r.
20388 anche se, in tre casi, si è riscontrata la violazione delle disposizioni
in tema di rifiuti (D.p.r. 91582 e D.Lv. 2297).
Occorre precisare che i dati elaborati tengono conto esclusivamente delle
violazioni accertate a seguito del primo controllo documentale e dei successivi
sopralluoghi poiché il ricorso alla preventiva verifica delle violazioni
formali ha fatto sì che l’eventuale superamento di limiti (accertato a
seguito delle analisi successive al primo controllo e dovuto a carenze
costruttive o funzionali dell’impianto ovvero ad altre cause note solo a
seguito dell’indagine) fosse immediatamente eliminato dai responsabili - in
alcuni casi addirittura drasticamente mediante la demolizione eo la dismissione
dei punti di emissione - con conseguente interruzione della permanenza della
violazione e la possibilità di ricorrere a riti alternativi per una o più
ipotesi di reato[11].
Non va’ infine sottaciuto che, alla scarsa attenzione per la funzionalità
e regolarità degli impianti con riferimento all’ambiente esterno, non
raramente si accompagnano situazioni di rischio per la salute dei lavoratori
addetti rappresentati dalla obsolescenza degli impianti, dai risultati di
precise strategie aziendali o, nella maggior parte dei casi, dalla
consapevolezza della scarsità dei controlli.
Come si è accennato in precedenza, una seconda campagna di verifiche – ad
opera dei medesimi Consulenti - ha riguardato anche le vetrerie esistenti in
Murano.
Lo scenario presentatosi ai verificatori è del tutto simile a quello
riscontrato nell’area di Marghera con alcune minime ma significative
distinzioni.
Alla cronica mancanza di verifiche si è riscontrata, talvolta, qualche
manifestazione di insofferenza ai controlli: nonostante molte aziende si siano
mostrate immediatamente disponibili a provvedere ad un tempestivo adeguamento
degli impianti, altre hanno tentato con vari pretesti di ritardare la messa a
norma degli impianti reclamando, in alcuni casi, la necessità di un congruo
termine per l’adeguamento degli impianti stessi i quali, è il caso di
sottolinearlo, sono stati talvolta riscontrati
del tutto privi di sistemi di abbattimento dei fumi eo di impianti idonei a
convogliare le emissioni all’esterno dello stabilimento nonostante il tempo
trascorso dalla data di entrata in vigore della normativa.
La resistenza all’adeguamento degli impianti si riscontra, di regola, da
parte di quei settori produttivi che dispongono di minori risorse economiche e
per i quali appare maggiormente vantaggioso affrontare il rischio – del tutto
eventuale – di una verifica sfavorevole rispetto all’esborso certo di somme
di denaro, anche ingenti, per l’adeguamento degli impianti.
Analoga situazione si è riscontrata nel corso dell’indagine di cui ora si
tratta.
Le rimostranze degli imprenditori del vetro hanno
tuttavia trovato ascolto tanto che si è provveduto all’emanazione del D.M.
1842000 “Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di
emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’Isola
di Murano”[12]
riguardante tuttavia (come riconosciuto anche da unanime giurisprudenza di
merito), i soli impianti “esistenti” secondo la definizione ricavabile dal
D.p.r. 20388, come si desume dal tenore dei richiami effettuati a tale
normativa[13]. La proroga, alle
condizioni indicate nel decreto, è concessa fino al 31 dicembre 2002.
Come
ricordato dai CC.TT., le condizioni previste dal D.M. prevedono che il titolare
dell’insediamento che intende avvalersi della proroga debba:
-
aver comunicato,
entro il 28 giugno 2000, l’adesione all’accordo di programma stipulato in
data 15 novembre 1999 fra i vari enti e le associazioni sindacali.
-
aver presentato, entro il 24 novembre 2000, istanza documentata
che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione
degli impianti, descriva le misure che si intendono adottare per l’adeguamento
delle emissioni in atmosfera dell’impianto ai valori di cui all’accordo
citato.
In
tal caso l’Amministrazione Provinciale autorizza la continuazione delle
emissioni (art.12 DPR 203/88) con
eventuali prescrizioni.
Le
opere impiantistiche e gestionali di cui in precedenza devono, comunque, essere
realizzate entro il 31 dicembre 2002 e rispettare, a tale data, i limiti di
emissione previsti dall’accordo di programma.
Riguardo
a tali limiti, osservano però i consulenti che essi sono più restrittivi,
rispetto a quelli stabiliti dal D.M. 12.07.90, mediamente
del 63%.
Tale
circostanza si presta ad una duplice valutazione. Se da un lato, infatti, come
pubblicamente dichiarato dai soggetti interessati, la scelta di valori così
restrittivi costituisce una sorta di corrispettivo che i soggetti beneficiati
dalla proroga accettano di pagare e che giustifica un siffatto trattamento di
favore rispetto ad altri settori produttivi (che, e’ il caso di ricordarlo,
interviene dopo oltre un decennio dalla data di entrata in vigore di
disposizioni troppo spesso ignorate), dall’altro induce a ritenere non
improbabili richieste di ulteriori proroghe[14]
giustificate da difficoltà tecniche (peraltro ampiamente prevedibili) connesse
alla necessità di raggiungere livelli di abbattimento particolarmente
restrittivi. Non si vede, inoltre, come possa risultare vantaggiosa la spesa per
interventi di tal genere, sicuramente superiore a quella necessaria per
adeguarsi ai limiti già in vigore, in particolar modo per quanti dovessero aver
scelto di aderire al disposto del D.M. dopo aver modificato gli impianti a
seguito dei controlli subiti.
Va altresì
segnalato come, a fronte della prosecuzione della campagna di accertamenti nei
confronti degli insediamenti “nuovi” (non rientranti, come si è detto, nel
D.M. 1842000 in base alla sua inequivocabile formulazione, riconosciuta
anche dalla giurisprudenza di merito), una tempestiva interpretazione autentica
dello stesso D.M. inserita nell’articolo 52, comma 12 della
“Finanziaria 2002” ha chiarito che “In deroga al disposto degli
articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, i termini per l’adeguamento delle emissioni in atmosfera degli
impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di Murano
previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18
aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si
applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale
o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata
l’esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all’accordo
di programma nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000”[15]
Venendo
all’elaborazione dei dati effettuata dai CC.TT., attraverso la quale la
situazione è adeguatamente rappresentata, si osserva che nel caso delle
vetrerie gli insediamenti controllati ammontano a 88.
Tra
questi,
-
4 vetrerie non sono più
esistenti e hanno dismesso gli impianti produttivi;
-
2 vetrerie non sono risultate soggette agli obblighi
amministrativi previsti dal DPR. 230/88;
-
82 vetrerie sono risultate come aventi impianti in esercizio
Tra le vetrerie in esercizio, 59 risultano esistenti dal 1° luglio 1988,
mentre le restanti 22 hanno installato impianti dopo tale data e quindi
rientrano tra i “nuovi
impianti” contemplati dal DPR 203/88 e dal DPCM 21.07.89.
Tutti gli impianti in esercizio, tanto nuovi che
esistenti, sono risultati operare in contrasto con le disposizioni del D.p.r.
20388.
Anche in questo caso, come è avvenuto per gli
insediamenti industriali dell’area di Marghera, le violazioni contestate
riguardano gli articoli 24 e 25 del citato D.p.r.
Il preventivo esame documentale e l’effettuazione del sopralluogo hanno
consentito, anche in questo caso, di limitare gli accertamenti alle violazioni
formali isolando e limitando i casi in cui, nel corso delle analisi successive
all’adeguamento degli impianti, si sono riscontrati superamenti dei limiti
imposti. In tali ipotesi, infatti, al fine di evitare l’applicazione o il
ripristino della misura cautelare reale ovvero una maggiore durata
dell’interruzione dell’attività conseguente all’applicazione già in
essere della misura medesima, i titolari degli impianti hanno quasi sempre
immediatamente provveduto all’eliminazione dell’inconveniente
apportando all’impianto le modifiche necessarie.
Resta da osservare, per concludere, come
l’adozione del sequestro preventivo unita ad una capillare azione di controllo
per tipologia di impianto rappresenti oggi l’unico strumento efficace per
contrastare fenomeni diffusi di illegalità dovuti non solo alla volontaria
condotta dei titolari degli impianti ma anche ad una distratta gestione del
territorio da parte dei soggetti competenti ai controlli.
Luca RAMACCI
[1]
Dati risultanti dal CED – Cassazione su un totale di 46 documenti presenti
in archivio alla data del 26112001
[2]
A. DI DOMENICO, L. TURRIO BALDASSARRI, G. ZIEMACKI “Relazione di
Perizia Tecnica sulla qualità e quantità dell’impatto antropico nella
laguna di Venezia”
[3]
Va altresì aggiunto, per completezza, che le conseguenze
dell’inquinamento risultano ulteriormente aggravate ed estendono i loro
effetti ben oltre il territorio lagunare a causa del noto
e diffuso fenomeno della pesca abusiva in aree contaminate di
molluschi bivalvi successivamente immessi sul mercato nazionale con
certificazione sanitaria falsa. Sull’argomento v. L. RAMACCI “Il
fenomeno della pesca abusiva dei molluschi nella laguna di Venezia” in
Rapporto Ecomafie - Roma 2001 ed. Legambiente (pubblicato anche in
www.lexambiente.com)
[5]
Vladimiro BONAMIN, Alessandro DI DOMENICO, Roberto FANELLI e Luigi TURRIO
BALDASSARRI “Microinquinanti
tossici nella laguna di Venezia – Livelli di contaminazione ed impatto
ambientale"
[6]
In G.U. n. 171 del 24.7.1989. “ Atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art. 9
della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e
l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante norme
in materia di qualità dell'aria
relativamente a
specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti
industriali”
[7]
Trattasi del Dott. G. BIELLI e dei PP.II. R. FELICI e L. SCATTO. Il quesito
formulato era il seguente “Dicano i consulenti, previa visione della
documentazione acquisita, relativa alle ditte di cui agli elenchi in atti e
previo eventuale sopralluogo, se sussistano situazioni di contrasto con la
normativa tecnica in materia e quanto altro utile ai fini di giustizia.
Dicano altresì i consulenti se sia necessario o opportuno per la tutela
della salute pubblica l’adozione di particolari provvedimenti e
l’effettuazione di prelievi ed analisi delle emissioni”
[9]
Cass. Sez. III 1121998, Sartori ed altri in Riv. Pen. n. 41998 con nota
di L. RAMACCI “Nuovo indirizzo della cassazione in tema di sequestro
preventivo "condizionato""
[11]
In tali casi, data la diversità delle situazioni riscontrate, i CC.TT.
hanno omesso la rilevazione statistica dei dati.
[13]
Nella premessa al decreto viene
fatto riferimento all’articolo 3, comma 2 del D.p.r. 20388 che, a
sua volta, richiama il D.M.
12 luglio 1990 (avente ad oggetto “Linee guida per il contenimento
delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori limite di emissione”). Tale ultimo D.M., infatti, viene
richiamato nella premessa al D.M. 18 aprile 2000 con riferimento particolare
all’articolo 5.
[15]
Le notizie che, sulla stampa locale
(“Il Gazzettino” Giovedì, 15 Novembre 2001) preannunciavano
l’imminente approvazione della disposizione citata precisavano anche,
senza mezzi termini, che si
trattava di “un
emendamento per scongiurare nuovi sequestri”.



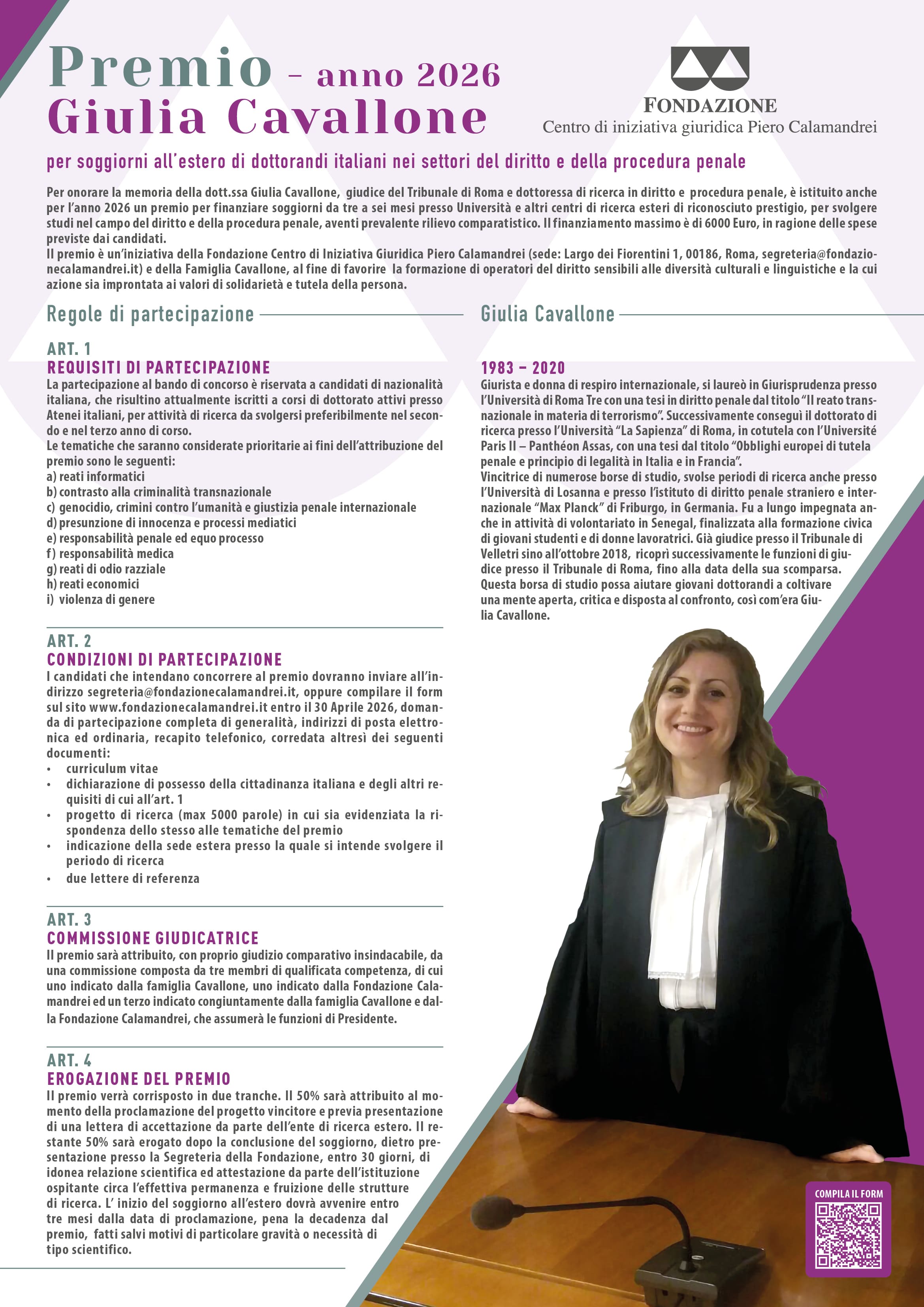 Scarica la locandina
Scarica la locandina