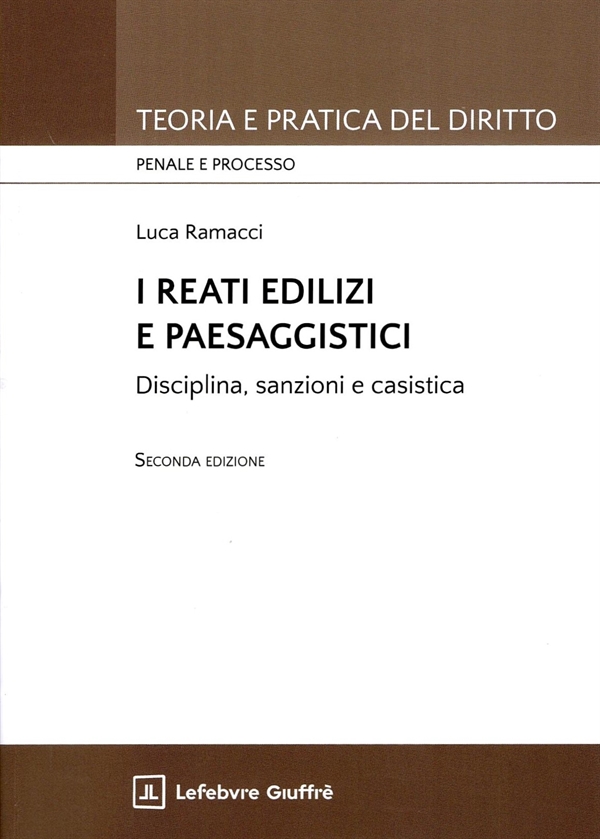PREMESSA
Una
nuova normativa ispirata al "Superfund" americano, per far pagare alle
aziende inquinanti gli interi costi di bonifica delle aree contaminate da
produzioni nocive o da rifiuti tossici; la definizione di una lista di priorità
che scadenzi gli interventi di risanamento delle aree a rischio e crei le
premesse per l'immediata chiusura degli impianti per i quali è ormai accertata
la pericolosità sanitaria, la delocalizzazione
o la riconversione di quelli che hanno comunque un elevato grado di inquinamento
e impatto ambientale. La creazione di nuove figure professionali, che offra
anche una opportunità di riqualificazione per gli addetti del settore
impiegandoli nei lavori di messa in sicurezza e di recupero delle aree
recuperate per la messa in sicurezza e il risanamento delle aree contaminate.
Partendo
dall'allarmante analisi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
realizzato su 15 aree ad elevato rischio di crisi ambientale, Legambiente ha
presentato un ventaglio di proposte per "passare dalla chimica dei veleni
al risanamento ambientale" e alla sicurezza sanitaria per le popolazioni
che vivono a ridosso di aree industriali o depositi di sostanze a rischio e
tutelare i lavoratori impiegati in produzioni che utilizzano sostanze
pericolose. Sia i dati dell'OMS che la predisposizione di questo pacchetto di
interventi richiesto dall'associazione ambientalista si inseriscono tra l'altro,
in una gigantesca partita giudiziaria che ha messo alla sbarra tutta la vecchia
chimica. Sotto accusa la pericolosità sanitaria di un tipo di produzione che,
ormai non ci sono dubbi, ha ucciso, causato malattie, avvelenato l'ambiente,
compromesso gli equilibri territoriali.
Già
lo studio Ambiente e salute in Italia del 1995, coordinato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
rilevava un generale aumento della mortalità e del rischio di insorgenza di
alcune specifiche patologie tumorali e ne attribuiva la causa alle condizioni
ambientali e lavorative. Gli ultimi studi dell'OMS, solo considerando 15 aree a
rischio di crisi ambientale, denunciano addirittura 800 morti in eccesso ogni
anno con un trend che purtroppo, a dispetto del ridimensionamento dell'industria
pesante, non accenna a diminuire.
Decessi dovuti al contatto con sostanze inquinanti cui sono sottoposti i
lavoratori e alle emissioni
inquinanti causate dai processi produttivi che colpiscono anche i cittadini
residenti in quelle aree.
Come
dunque uscire dalla stagione dei veleni che ha lasciato in eredità aree
minerarie, centri siderurgici, complessi chimici e petrolchimici con un carico
ad elevatissimo rischio di contaminazione? Legambiente mette in campo le sue
proposte che prendono in parte spunto proprio da una delle nazioni che fanno del
libero mercato la caratteristica principe della loro economia, dove però, a
differenza dell'Italia, l'onere della riqualificazione ambientale e del recupero
dei siti contaminati è totale carico dei privati.
Proprio
partendo dall'esempio statunitense Legambiente propone infatti un adattamento
italiano del Superfund, ossia dell'insieme di norme che fissano le responsabilità
dell'imprese in caso di contaminazione ambientale, definiscono le procedure per
la valutazione del rischio, individuano una lista di priorità nazionali degli
interventi di bonifica.
In
particolare, il Superfund ha tre livelli di intervento che riveduti e corretti
potrebbero trovare applicazione anche in Italia. Il primo, un fund trust, ossia
un fondo di sicurezza finanziato dalla tassazione principalmente di prodotti
chimici e petroliferi ma anche di altre sostanze inquinanti, vincolato alla
bonifica dei cosiddetti siti orfani (per i quali non è più possibile
riconoscere un proprietario responsabile). In secondo luogo, un'attività
capillare di analisi sui siti inquinati che consenta di stabilire la loro
pericolosità e l'urgenza della bonifica con la definizione appunto di una lista
nazionale di priorità. In terzo luogo, l'obbligo inderogabile per le aziende
che gestiscono impianti ancora in attività, una volta accertata l'eventuale
pericolosità della produzione o delle scorie prodotte sia per l'ambiente che
per la salute della popolazione, di disporre immediati interventi di bonifica.
Una
traduzione italiana di questo modello è possibile, a detta di Legambiente, se
la nostra normativa acquisisse proprio alcuni principi ispiratori del superfund
che hanno reso possibili in 15 anni la bonifica completa (nel 50% dei casi) o
parziale delle emergenze più gravi su tutto il territorio nazionale. Un esempio
virtuoso, soprattutto se raffrontato alla realtà italiana dove colossi
inquinanti hanno fatto, e purtroppo continuano a fare, danni in attesa di
interventi di messa in sicurezza di cui si parla da anni ma che da anni tardano
ad arrivare.
Prendendo
ad esempio la necessità di un fondo di sicurezza pagato dai settori produttivi
inquinanti, vincolando a questo fine una parte della tassazione che già grava
su queste aziende, si potrebbero avviare anche da noi gli interventi su quella
percentuale di siti italiani (discariche abusive, terreni contaminati, depositi
di rifiuti tossici e nocivi) per i quali non è possibile riconoscere la
responsabilità del danno. Nello stesso tempo, lo stesso fondo potrebbe
contribuire ad un capillare accertamento e ad un censimento completo di tutte le
aree a rischio. Una base fondamentale anche per la definizione di una lista di
priorità e per stabilire temporalmente l'inizio e la fine degli interventi.
Infine, ma sicuramente prioritaria, è anche l'idea che ha trovato spazio negli
Usa ma che tarda a trovare applicazione da noi, che debbano essere i privati
responsabili dell'inquinamento e non già questi con il concorso dello stato a
pagare i danni provocati al territorio, all'ambiente, alle popolazioni.
Negli
Stati Uniti, responsabile della gestione del Superfund, è l'Epa, l'agenzia per
la protezione dell'ambiente, che si occupa di identificare e selezionare i siti
da bonificare, e che nel 1985 ha segnalato 1500 siti. Siti che in 15 anni hanno
visto conclusa l'opera di bonifica ben nel 50% dei casi (750 zone), mentre altri
600 (il 40%) sono prossimi al completamento delle operazioni di risanamento.
Nello stesso periodo, sono stati pagati dalle aziende inquinanti per la bonifica
di aree contaminate su cui insistono impianti ancora in attività, ben 32mila
miliardi, mentre le attente indagini condotte hanno portato all'identificazione
di 41mila siti a rischio.
Ovvio
che, pur con le dovute proporzioni tra il caso Italia e quello statunitense, il
ritardo e l'inadeguatezza normativa
del nostro paese appare evidente.
Gli
stanziamenti previsti dall'ultima legge finanziaria prevedono infatti fondi
insufficienti ma comunque onerosi per le casse dello Stato (550 miliardi nel
2001, 150 nel 2002 e 200 nel 2003), poiché la responsabilità del danno
dovrebbe ricadere sulle aziende.
L'attuazione
del principio del "chi inquina paga", secondo Legambiente, dovrebbe
insomma diventare, anche in Italia, uno dei vincoli cui far riferimento per
avviare finalmente il piano delle bonifiche che dovrebbe interessare ben 15mila
siti inquinati in Italia con l'impiego stabile di 5mila nuovi supertecnici. E'
questa infatti, la stima approssimativa realizzata da Legambiente (manca
peraltro sul tema un quadro di riferimento "istituzionale" preciso)
tra aree identificate dal piano nazionale di bonifica redatto alla fine del 2001
(40 siti), i circa 6.000 serbatoi di carburante sparsi per il paese, i 4.500
siti identificati nelle regioni del Nord e in Toscana (tra discariche
autorizzate, siti industriali e sversamenti) a diversa priorità di intervento,
le circa 2.500 discariche abusive della criminalità organizzata nel Centro-Sud
(il cui rischio reale è sconosciuto); le 1.000 o 2.000 zone potenzialmente
inquinate dagli insediamenti industriali e artigianali del centro-sud; le tante
discariche utilizzate o autorizzate prima della metà degli anni ’80 (ossia
prima dell'approvazione del DPR 915/82, prima legge sui rifiuti in Italia) che
in alcuni piani regionali sono già inserite e in generale presentano problemi
di un certo rilievo per la bonifica. Pur se ogni paese classifica i siti
contaminati in maniera diversa, o censendo (ed è il caso della Germania) anche
un solo bidone di rifiuti nocivi come area a rischio o, ed è il caso di altri
paesi, prendendo in considerazione solo le emergenze più gravi, c'è un numero
che può dare l'idea della gravità del problema anche a livello europeo:
secondo il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, sono 150mila in Europa i siti sospetti di inquinamento e oltre 100
milioni gli ettari definiti contaminati (pari a un miliardo di metri cubi di
terreni e rifiuti). Tornando in Italia invece, va anche sottolineato come nel
1995 la spesa calcolata per le bonifiche fosse pari a
30mila miliardi e dovesse interessare almeno 330mila ettari ossia
un'estensione pari alle intere provincie di Milano e Napoli messe insieme. Del
resto, se il piano delle bonifiche riuscisse finalmente a partire, la ricaduta
su occupazione e professionalità tecniche sarebbe estremamente positiva: in un
settore peraltro afflitto da una costante emorragia di posti di lavoro (meno
70mila operai impiegati in 20 anni), vecchie e nuove competenze sarebbero
infatti richieste da tutte le attività di bonifica e ripristino con un'offerta
di lavoro specializzato pari a oltre 5.000 posti, senza considerare l'indotto e
le attività di contorno che potrebbero garantire altre migliaia di occupati.
Ma
chi dovrebbe pagare veramente in Italia? Soprattutto per quanto riguarda EniChem,
per la quale si parla negli ultimi mesi della vendita di parte dei suoi impianti
alla multinazionale araba Sabic, non si ha certezza sulla dismissione degli
impianti obsoleti e della bonifica dei siti contaminati.
D'altronde
a rendere sempre più urgente un intervento di riqualificazione ambientale delle
aree più a rischio sono, di nuovo, i dati sanitari. Come detto, l’allarme per
le conseguenze derivanti da alcune produzioni chimiche, siderurgiche, minerarie
e petrolifere è al centro dello studio condotto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) – Centro Europeo Ambiente e Salute - su richiesta del
Ministero dell’Ambiente. L’indagine è stata commissionata per le 15 aree
classificate come “ad alto rischio di crisi ambientale” con Decreto
Ministeriale dell’8.7.1986 n. 349 a causa della presenza di una o più
potenziali fonti di inquinamento ambientale legate alla presenza di importanti
attività industriali. Va precisato comunque che durante questi ultimi anni sono
aumentati i siti industriali per cui è stato evidenziato un rischio ambientale
e sanitario.
L’OMS
da anni effettua in Italia studi approfonditi, condotti attraverso
l’elaborazione di dati di mortalità disaggregati a livello comunale per un
territorio vasto, che costituiscono un importante contributo informativo a
sostegno dell’intervento del Ministero dell’Ambiente.
Anche
il dossier di Legambiente, come quello dell'Oms analizza il dettaglio delle
singole aree contaminate e, dunque sarà possibile avere un quadro completo ed
aggiornato delle singole situazioni che lungo l'intera penisola minacciano
l'ambiente e la popolazione.
LE
BONIFICHE TRA STATI UNITI E ITALIA
Poli
chimici, industrie a rischio, discariche abusive o autorizzate in tempi ormai
remoti, aree industriali dismesse: sono numerosissime le realtà dell'Italia da
bonificare.
Oltre
alle problematiche legate al rischio industriale e sanitario nelle aziende
tuttora funzionanti infatti, grave e tuttora irrisolto appare anche il rischio
relativo agli impianti dismessi e a
quelli in
via dismissione inseriti in progetti
di bonifica. Progetti che si stanno rivelando critici per
le grandi quantità di materiali da trattare, la complessità delle
contaminazioni (molto spesso non ben conosciute) che oltre ai terreni hanno
interessato le falde acquifere, per
il mancato utilizzo di tecnologie
di trattamento ampiamente impiegate all'estero.
Già
lo studio Ambiente e salute in Italia, del 1995, coordinato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale, rilevava un generale aumento della mortalità e del rischio di
insorgenza di alcune specifiche patologie tumorali e ne attribuiva la causa alle
condizioni ambientali e lavorative.
Gli
interventi della magistratura (alcuni ancora in corso) hanno poi confermato gli
studi che nel corso degli anni sono stati condotti per ricercare una
correlazione tra ambiente di lavoro e problemi sanitari, tra insorgenza di
particolari tipi di tumore e l’aver maneggiato certe sostanze, o addirittura
solo per aver vissuto in prossimità dei camini delle aree industriali.
Quel
che è certo è che in Italia il sistema delle bonifiche è assolutamente
bloccato. Dal 1998, anno in cui la legge 426 ha definito i primi 15 siti di
interesse nazionale da bonificare (tra cui Porto Marghera, Brindisi, il litorale
domitio-flegreo con le discariche dell’ecomafia campana, etc.), ben poco si è
mosso, a parte qualche intervento a Cengio. L’unica grande novità consiste
nell’approvazione del decreto ministeriale 471/99 atteso da tempo. Alla
fine del 2001 è stato poi varato il piano nazionale di bonifica che porta a 40
il numero dei siti di interesse nazionale, stanziando per essi circa 1000
miliardi di lire. Peccato che il numero delle aree inquinate del Belpaese sia
ben più nutrito. Una stima di massima sul numero dei siti inquinati in Italia
prevede infatti: i 40 siti già previsti nel piano nazionale delle bonifiche;
tra i 5.000 e i 7.000 serbatoi di carburanti; circa 4.500 siti nelle regioni del
Nord e in Toscana (tra discariche autorizzate, siti industriali e sversamenti) a
diversa priorità di intervento; circa 2.500 discariche abusive nel Centro-Sud
(il cui rischio reale è molto variabile); circa 1.000 - 2.000 siti
potenzialmente inquinati dagli insediamenti industriali e artigianali del
centro-sud; le tante discariche utilizzate o autorizzate prima della metà degli
anni ’80 (prima dell'approvazione del DPR 915/82, prima legge sui rifiuti in
Italia) che in alcuni piani regionali sono già inserite e in generale
presentano problemi di un certo rilievo per la bonifica.
In
totale si può azzardare una stima di almeno 15.000 siti da bonificare. Da qui
la nota dolente dei costi per le bonifiche. I 1.000 miliardi di lire stanziati
dal Ministero dell’ambiente per i siti previsti dal Piano nazionale di
bonifica sono ovviamente insufficienti. La sola caratterizzazione (analisi
ambientale complessiva) del fiume Bormida inquinato dall’ACNA di Cengio per
esempio, è costata al Commissario delegato 4 miliardi di lire. E’ ovvio
sottolineare che tutti i siti di interesse nazionale hanno bisogno di questa
caratterizzazione, prevedendo per le situazioni gravi come quella di Porto
Marghera costi ancora più elevati.
Ai
1.000 miliardi di lire per i siti nazionali vanno sommati comunque i soldi messi
a disposizione dalle Regioni per interventi su siti inquinati pubblici o senza
più “padrone”. Per cui, si può ipotizzare che il totale dei finanziamenti
tra enti locali, Regioni, Province, Comuni e ARPA, arriverà ai 10mila miliardi
per i prossimi 2/3 anni, per un totale di finanziamento pubblico pari a 11mila
miliardi di lire.
Per
quanto riguarda invece il finanziamento privato, obbligatorio in caso di
contaminazione in base al principio del "chi inquina paga", il costo
degli interventi limitato ai 40 siti nazionali, dovrebbe aggirarsi intorno ad
una cifra pari a circa 5-6 volte il finanziamento pubblico, e quindi a oltre 5
-6.000 miliardi di lire. Le spese dei privati per i siti di loro competenza che
invece non rientrano nei 40 nazionali, possono essere stimate in una cifra tra i
5.000 e i 10.000 Miliardi di lire, per un totale di investimenti privati pari a
circa 15.000 miliardi di lire.
Complessivamente,
nei prossimi tre anni per gli oltre 15.000 siti inquinati stimati del nostro
Paese, verrebbero stanziati quindi circa 11.000 miliardi di lire di
finanziamento pubblico, a cui si dovrebbero aggiungere circa 15.000 miliardi di
lire dagli industriali responsabili della contaminazione, per un totale di spesa
di oltre 25.000 miliardi di lire. Cifra che difficilmente verrà raggiunta.
Del
resto, se il progetto delle bonifiche riuscisse finalmente a partire, la
ricaduta su occupazione e professionalità tecniche sarebbe estremamente
positiva: si innescherebbe un meccanismo virtuoso nelle attività di bonifica e
ripristino (dalla consulenza alla progettazione dell’intervento), nella
costruzione di impianti di trattamento, nell’attività di controllo di
competenza del pubblico (verifiche sul campo, valutazione di istruttorie e
attività di laboratorio), nelle attività dei laboratori privati, che potrebbe
muovere un mercato di oltre 5.000 posti di lavoro, tra tecnici e laureati.
Purtroppo,
nonostante il numero dei siti inquinati sia fin troppo grande, le risorse
finanziarie disponibili risultano carenti.
Al
riguardo, va segnalato che per gli interventi di bonifica e ripristino dei 40
siti identificati dal ministero dell'Ambiente - il Petrolchimico di Porto
Marghera, le raffinerie di Gela, i poli industriali e petrolchimici di Brindisi,
Taranto, Gela ma anche l’Acna di Cengio, la discarica di Pitelli, solo per
citare i più noti - la Finanziaria appena approvata, registra una riduzione di
circa 100 miliardi.
Per
correre ai ripari sarebbe utile riproporre per le bonifiche in Italia un sistema
simile a quello del Superfund utilizzato negli Usa.
Nel
1980, in seguito a una serie di disastri ambientali, il governo degli Stati
Uniti d’America emanò infatti una legge per le bonifiche il cui fondo
iniziale, il Superfund appunto, era di circa 1,6 miliardi di dollari. Questo
fondo fu creato grazie a una tassa speciale imposta ai produttori di sostanze
chimiche e petrolifere che, sei anni dopo, fu estesa a ogni tipo di azienda che
produceva rifiuti tossici, in percentuale dell’utile. Tutte le aziende quindi,
se superano certe dimensioni, devono pagare una quota per il fondo, anche se le
aziende petrolifere e chimiche hanno tassazioni maggiori.
Gli
8,5 miliardi di dollari del fondo attuale vengono usati per varie finalità: per
intervenire immediatamente nei casi di rischio per la salute umana, per le
attività di caratterizzazione iniziale dei siti in modo da stabilire le priorità
d'intervento, per risanare i cosiddetti siti “orfani”, cioè quelli in cui
è davvero impossibile individuare un responsabile, ma anche per recuperare i
soldi, visto che quando si decide di partire subito con le operazioni di
bonifica e ricorrere poi in tribunale per il risarcimento, le spese legali sono
notevoli.
Va
sottolineato che i siti industriali in attività e quelli di gestione dei
rifiuti pericolosi non vengono inseriti nell’elenco del Superfund. In caso di
contaminazione di tali siti infatti è il responsabile della contaminazione a
pagare di tasca propria la bonifica, senza alcun finanziamento da parte dello
Stato.
Se
il sito di smaltimento è abbandonato, se quello industriale non è operativo
oppure se il sito è operativo ma l’azienda ha fallito, entra in gioco invece
il Superfund.
Confrontando
Usa e Italia sulla questione delle bonifiche, vediamo che negli Stati Uniti c’è
un sistema normativo flessibile e pragmatico, che fa la selezione dei siti
mediante la valutazione del rischio, per cui se l’area contaminata è gestita
da un operatore in attività e la contaminazione è attuale o pregressa, lo
Stato non ci mette una lira e gli interventi sono interamente a carico del
privato. Quindi c’è più flessibilità nell’individuazione dei siti da
bonificare e degli interventi da realizzare, mentre c’è una piena
responsabilità finanziaria del privato.
Certo,
il modello degli Stati Uniti funziona proprio grazie all’esistenza di una
struttura pubblica, l’Epa appunto, dotata di risorse finanziarie e competenze
tecnico-scientifiche tali da impedire scappatoie.
In
Italia invece c’è una maggiore rigidità legislativa, poi però lo Stato
interviene e cofinanzia anche i casi in cui l’inquinamento è prodotto da un
operatore ancora in attività. Qui vale quindi uno strano meccanismo per cui
alla rigidità burocratica non corrisponde una severità tale da imporre al
privato tutto l’onere economico del risanamento ambientale.
Per
continuare il confronto, nel nostro Paese non esiste un’agenzia con la stessa
struttura, risorse e compiti dell’Epa statunitense.
L’ipotesi
di ragionare anche in Italia su un meccanismo di finanziamento per i siti
dismessi, basato su un sistema fiscale simile a quello americano, faciliterebbe
di molto il risanamento delle aree inquinate del nostro Paese.
In
conclusione, se l'obiettivo principe è quello di bonificare i siti contaminati
del nostro Paese riducendo i drammatici rischi ambientali e sanitari, riteniamo
fondamentale l'istituzione di un fondo nazionale, realizzato attraverso
l'introduzione di un meccanismo tipo quello statunitense che prevede la
contribuzione ad un fondo nazionale finanziato mediante tassazione diretta alle
imprese, completamente diverso da quello attuale vigente in Italia. E'
necessario quindi aumentare il potere di controllo di un organismo terzo, di
carattere pubblico, a cui affidare il potere d’intervento
nell’individuazione e nella selezione dei siti da bonificare. Vanno poi
modificate le procedure di intervento in modo da dividere i siti dismessi e le
discariche illegali, per i quali si attinge dal fondo nazionale finanziato dal
mondo dell’impresa, dai siti operativi, per i quali l’onere finanziario
delle bonifiche sarebbe completamente a carico
dell’impresa.
Parallelamente,
è necessario estendere gli studi sullo stato di salute della popolazione anche
a tutte le nuove aree considerate o sospettate a rischio, allargando
l’osservazione sanitaria anche all’incidenza di altre patologie
(malformazioni croniche, funzione tiroidea, et.), considerate attualmente come
bio-indicatori e precursori di un possibile maggiore rischio di effetti sanitari
a più lunga latenza (morti per tumore, etc.).
PORTO
MARGHERA
“Marghera
sensa fabriche sarìa più sana,
‘na
giungla de’ panoce, pomodori e marijuana”
(dalla
canzone “Marghera” dei Pitura
Freska)
Una
sentenza di assoluzione a dir poco scandalosa. Non poteva che essere questo il
commento di Legambiente dopo la conclusione del processo ai vertici delle
aziende del petrolchimico di Porto Marghera, svoltosi per far luce sulle morti
di alcuni operai del reparto Cvm (Cloruro vinile monomero) e sul danno
ambientale causato alla laguna di Venezia. Del resto dopo circa quattro anni di
processo e dopo le raccapriccianti deposizioni degli operai sopravvissuti e dei
familiari di quelli ormai deceduti, ci si aspettava un finale completamente
diverso. Soprattutto da parte di chi come Legambiente, parte civile al processo
insieme ad altre associazioni ambientaliste, per anni si è battuta contro la
folle politica industriale delle aziende del petrolchimico veneziano.
Sullo
stato dell’arte delle bonifiche degli innumerevoli siti contaminati di Porto
Marghera il commento non è poi così diverso. Gli interventi di bonifica da
tempo annunciati non sono mai partiti per una serie di intoppi burocratici
assolutamente privi di senso. Dalla firma dell’Accordo di programma sulla
chimica a Porto Marghera dell’ottobre ’98 sono passati più di tre anni
durante i quali in pratica nulla è stato fatto. Nel frattempo è stato
approvato il decreto ministeriale sulle bonifiche (dicembre ’99) e
un’integrazione all’accordo che comprendesse le novità inserite nel decreto
(dicembre 2000), che doveva essere ratificata da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che ancora non è stato varato.
L’unica
novità da segnalare è la transazione di oltre 271 milioni di euro conclusa tra
Montedison e Ministero dell’ambiente, a cui si è ipotizzato possa seguire
quella con Enichem di circa 206 milioni di euro. Facciamo fatica a capire il
motivo per cui la transazione farà desistere il Ministero dal ricorrere in
appello contro la sentenza assolutoria del processo su Porto Marghera, così
come già dichiarato dallo stesso Ministro. Non è chiaro cosa centrino i
miliardi che Montedison ed Enichem devono pagare per risanare i siti contaminati
dalle loro attività produttive, con il ricorso in appello in un processo
svoltosi non solo per i danni arrecati all’ambiente, ma anche per determinare
le eventuali responsabilità penali nelle morti degli operai del petrolchimico.
La
storia di Porto Marghera è tristemente nota all’Italia intera. Così come è
noto l’articolo 15, III comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano
regolatore di Venezia del 1962, che condannò Marghera ad essere quel girone
dantesco che è stato per decenni. Secondo quell’articolo “...nella zona
industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti
che diffondono nell’aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana,
che scaricano nell’acqua sostanze velenose, che producono vibrazioni o
rumori”. E così in effetti è stato.
L’elenco
delle attività produttive che nei trent’anni in cui è rimasta in vigore
questa norma sono state realizzate a Marghera è impressionante: uno dei più
grandi poli chimici del nostro paese, alluminio, cantieristica navale,
petrolifero - raffinazione, siderurgia, energia elettrica, commercio di prodotti
petroliferi. Il polo chimico ha prodotto quasi tutte le sostanze a partire dalle
materie prime, prodotti intermedi, prodotti finali. A partire dal 1951 con i
reparti cloro - soda che producono cloro, soda caustica e ipoclorito. L’anno
successivo inizia la produzione di trielina, acetilene e quindi cloruro di
vinile monomero (CVM) e polivinilcloruro (PVC). E’ a Marghera che verrà
avviata la produzione della plastica in Italia. Ma si producono per decenni
anche fibre acriliche e fertilizzanti, ammoniaca ed etilene, acido fosforico e
fluoridrico, solo per citarne alcune.
Fino
alla fine del 1988, lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella zona industriale
è avvenuto prevalentemente scaricando i cosiddetti gessi in mare. Dopo
l’esportazione internazionale di rifiuti con le “navi dei veleni”, nello
stabilimento Petrolchimico sono tuttora stoccati in 6 zone all’aperto e senza
particolari cautele circa 20.000 fusti di rifiuti tossici.
Il
21 giugno 1989 partecipano all’assemblea degli azionisti Montedison molti
rappresentanti di Legambiente. Una lunga discussione che inchioda l’assemblea
per undici ore ad ascoltare le ragioni del popolo inquinato.
Nell’esaminare
le politiche Montedison i riferimenti a Marghera appaiono nell’intervento di
Ermete Realacci che cita i buoni risultati ottenuti con la fermata degli
scarichi a mare, frutto della pressione ambientalista, invita a destinare i
dividendi dell’anno in corso per risanare i problemi ambientali che gli
impianti Montedison hanno determinato. Renata Ingrao sottolinea la pericolosità
del cloruro di vinile monomero come cancerogeno e chiede che si intervenga sugli
impianti. Duccio Bianchi richiama Montedison ad applicare le leggi sullo
smaltimento dei rifiuti, poiché è accertato che non le applica, chiede
l’impegno a regolarizzare lo smaltimento dei rifiuti e a bonificare le aree
contaminate e chiede spiegazioni sul perché Montedison continui ad investire in
inceneritori piuttosto che in produzioni pulite. Ivo Conti insiste sulla
necessità di chiarire la situazione degli impianti di Marghera, poco chiara in
particolar modo per lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi. Gianni Tamino
esprime preoccupazioni per la compatibilità di settori quali il cloro soda e le
eccedenze di cloro.
Le
forti preoccupazioni, i dubbi, gli interrogativi sui danni della chimica
italiana Legambiente li riaffermò nel maggio 1991, quando, con il dossier
”Enichem. Ambiente, sicurezza, salute dei cittadini. La faccia dimenticata
dell’industria chimica italiana”, ribadisce che i passaggi da Montedison a
Enichem attraverso Enimont hanno lasciato cittadini e ambiente preda di
un’industria chimica rovinosa e spendacciona.
Era
già chiaro a Legambiente che “nelle industrie chimiche, ma non solo in
queste, si sono verificati negli scorsi decenni importanti fenomeni di
contaminazione del suolo e del sottosuolo. Nelle attuali aree industriali si
trovano, spesso senza alcuna autorizzazione o conoscenza, depositi o discariche
di rifiuti tossici. I terreni, inoltre, sono stati contaminati da sversamenti,
perdite di routine, incidenti”. In quell’occasione si affermò con forza la
necessità di misure legislative, finanziarie e tecniche per affrontare il
problema delle bonifiche, che avrebbero dovuto essere a carico dei proprietari
delle aree e dei riutilizzatori.
Il
quadro di Porto Marghera vedeva un settore chimico colpito dalla
ristrutturazione con un calo di oltre 5000 posti di lavoro fra il 1980 e il 1987
e quasi 7000 occupati nel 1990. Le società principali insediate nel
Petrolchimico erano EVC, Montedipe, Montefluos, Enimont Anic, Crion, CPM,
Marghera. Le produzioni “forti”: cracking (etilene e propilene), PVC,
isocianati, caprolattame, fibre. Un complesso che vedeva in funzione “circa
2.000 camini o sfiati che emettono 240.000 tonnellate all’anno di sostanze
varie, tra cui alcune riconosciute cancerogene dall’OMS (come CVM, nitrile
acrilico, ammine aromatiche)”. “Attualmente soltanto pochi camini sono
dotati di apparecchiature di controllo in continuo delle emissioni, mentre
sarebbe necessario estendere l’uso di strumenti di controllo con blocco
automatico degli impianti quando le emissioni superano i valori limite di
legge”.
Quanto
a produzione e smaltimento di rifiuti il dossier notava che “fino a tutti gli
anni ’70 lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella zona industriale è
avvenuto in maniera molto sbrigativa, prima scaricando tutto in mare, poi
progressivamente sempre più lontano dalla costa e poi scaricando a terra un
po’ ovunque in una miriade di siti incontrollati. Una recente indagine con
fotografie da satellite ha consentito di individuare nella provincia di Venezia
circa 200 discariche abusive, alcune delle quali di grandi dimensioni e con
rifiuti industriali. Dei numerosi siti conosciuti come discariche abusive di
rifiuti tossici non è mai stato avviato un piano di bonifica”. “Le
emissioni in acqua attualmente ammontano a 20.000 tonnellate/anno e comprendono
solventi clorurati, oli minerali, cianuri, solfiti, fluoruri, acido cianidrico,
fosfati, mercurio, piombo, zinco, cromo”. “La regione Veneto nel Piano
direttore per il disinquinamento della laguna del dicembre 1989 riconosce che
”l’inquinamento da metalli pesanti e composti tossici (fenoli, cianuri,
solfuri, tensioattivi) è oggi presente nei sedimenti di tutta la laguna””.
Uno
dei coautori del dossier per il capitolo di Marghera è Gabriele Bortolozzo,
ex-operaio del Petrolchimico che, accortosi della morte per cancro di quattro
dei suoi cinque compagni di lavoro addetti alla ripulitura delle autoclavi nella
produzione del CVM, dedica tutto se stesso alla ricostruzione dei disastri
ambientali e dell’annientamento delle vite di tanti operai.
Nel
1994 Gabriele Bortolozzo pubblica il dossier “Il cancro da cloruro di vinile
al Petrolchimico di Porto Marghera”. Lo stesso dossier viene depositato come
esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia.
“Gli
operai delle imprese appaltatrici addetti all’insacco del PVC in polvere erano
98 tra il 1975 e il 1980, si tratta di una mansione estremamente gravosa e
nociva. Nel giugno 1994, 28 di loro mancano all’appello: sono i morti per
“tutte le cause”, pari al 28,57% degli addetti; 23 di essi sono deceduti per
tumori di vario tipo: l’82,14% dei lavoratori deceduti nel medesimo periodo
nel gruppo a rischio. Molti sono stati colpiti all’apparato respiratorio
(laringe-polmoni). Più precisamente i tumori si riferivano: 10 ai polmoni, 3
alla laringe, 2 al fegato, 1 al pancreas, 6 in sedi non precisate, 1 caso di
leucemia…tra il 1975 e il 1980 l’organico al reparto CV6 era di 108
lavoratori. Ne sono deceduti, a tutto giugno 1994, per “tutte le cause”, 24,
pari al 22,22% degli addetti, mentre 15 sono morti di tumore, il 62% di tutti i
lavoratori deceduti nel gruppo a rischio, prevalentemente colpiti al fegato”.
L’esposto di Gabriele Bortolozzo trova pronto ad avviare le indagini il
sostituto procuratore Felice Casson.
Mentre
partono gli accertamenti per avvalorare le tesi di Bortolozzo, Legambiente nel
luglio 1996 ricorda il ventennale dall’incidente all’Icmesa con il dossier
“A vent’anni dall’incidente di Seveso. Industria, ambiente, salute”. Un
inevitabile posto fra le aree a rischio esaminate lo trova Porto Marghera. Alla
costante pericolosità delle produzioni, delle emissioni in aria e acqua oggetto
di “un’indagine della Magistratura di Venezia per appurare se le morti per
tumore si possano attribuire al ciclo di lavorazione PVC - CVM e se l’azienda
(allora Montedison), nonostante fossero noti i rischi per i propri dipendenti,
non intervenne per tutelarne la salute”, vennero aggiunti i rischi di un
transito intenso di navi con prodotti chimici e petroliferi, “un traffico
valutabile intorno ai 2 milioni di tonnellate/anno di prodotti vari che sono
quasi tutti o tossici o infiammabili o esplosivi”.
Il
12 dicembre 1996 il giudice Casson deposita il rinvio a giudizio nei confronti
di Eugenio Cefis, Giuseppe Medici, Mario Schimberni, Alberto Grandi, Giorgio
Porta, Pier Giorgio Gatti, Italo Trapasso, Lorenzo Necci, Antonio Sernia e
altri.
Ognuno
imputato per reati diversi:
-
“…dal 1970 fino al 1988 effettuavano (o facevano effettuare) scavi e
realizzavano (o facevano realizzare) bacini e discariche, all’interno
dell’insediamento produttivo petrolchimico di Porto Marghera o in sua
prossimità, in cui venivano abusivamente smaltiti, abbandonati, scaricati,
depositati e comunque stoccati rifiuti di vario genere e in particolare rifiuti
speciali tossico-nocivi”;
-
”effettuavano lo scarico dei fanghi e degli altri sottoprodotti di
risulta dei trattamenti, attraverso gli scarichi 2 e 15, con concentrazioni di
nitrati e clorurati superiori ai limiti previsti dal Dpr 962/73”;
-
“consentivano la dispersione nel sottosuolo e nelle acque sottostanti
di sostanze tossico-nocive e di acque di rifiuto non trattate”;
-
“omettevano di adottare tutte le misure urgenti e necessarie al fine di
evitare il deterioramento della situazione igienico-sanitaria-ambientale di
tutti i siti… e comunque delle falde acquifere sottostanti e delle acque
confinanti”;
-
“pur essendo consapevoli del grado elevatissimo di tossicità e nocività
dei residui scaricati, ma disinteressandosene ed anzi accettandone il rischio,
contribuivano a dare origine e ad incrementare il progressivo avvelenamento
delle acque di falda sottostanti la zona di Porto Marghera (acque utilizzate
anche per uso domestico e agricolo), in cui sono state rinvenute tracce di
solventi clorurati, solventi aromatici, idrocarburi aromatici, fenoli,
ammoniaca, ammine aromatiche, piombo, cadmio, zinco, mercurio e arsenico in
valori superiori ai limiti consentiti e determinavano altresì un inquinamento
grave dei sedimenti e delle acque nei canali e negli specchi lagunari e i
conseguenti successivi adulterazione e avvelenamento di ittiofauna e
molluschi… con particolare riferimento alle tracce di sostanze pericolose
tossico-nocive e cancerogene nei medesimi rinvenute… con particolare
riferimento alle diossine”;
-
“con le aggravanti… per aver commesso i reati per motivi futili (il
profitto economico)”;
-
“con più azioni e omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, agendo nonostante la previsione dell’evento, per colpa cagionavano
il delitto di strage e disastro, mediante azioni e omissioni che cagionavano
pericoli per la pubblica incolumità, sia all’interno che all’esterno dei
reparti CVM-PVC, tanto che ne derivavano la morte e la malattia di un numero
allo stato ancora imprecisabile di persone”;
-
“gli imputati erano venuti a conoscenza dei risultati delle indagini
scientifiche a livello mondiale e dell’esito degli accertamenti sulla
pericolosità del CVM-PVC, riferito dal prof. Piero Luigi Viola della Solvay di
Rosignano (fin dal 1969), nonché comunicato per iscritto (fin dall’ottobre
1972) e più volte verbalmente dal prof. Cesare Maltoni di Bologna, accertamenti
tutti che segnalavano il pericolo tossicologico e anche cancerogeno derivante
dalla lavorazione e dalla trattazione in qualsiasi forma del CVM-PVC, pericolo
confermato successivamente nella G.u.c.e. del 10.12.76 e dall’indagine
epidemiologica effettuata dall’Università di Padova nel 1975-76 a Porto
Marghera, conclusasi con la relazione finale datata 12 marzo 1977, che segnalava
una “situazione sanitaria complessiva grave”;
-
“la colpa (progressiva nel tempo) è consistita in imprudenza,
negligenza, imperizia… per non aver - pur in presenza delle conoscenze mediche
e scientifiche di cui sopra - adottato nell’esercizio dell’impresa tutte e
immediatamente le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori…
per eliminare totalmente e immediatamente le fughe di gas CVM e di dicloroetano
nell’ambiente di lavoro e nell’ambiente esterno… per non aver curato che i
lavoratori usassero tutti i mezzi necessari di protezione individuale… per non
aver predisposto misure di sicurezza per tutte le fasi del ciclo produttivo…
per non aver fornito informazioni dettagliate e tempestive ai propri
dipendenti… per i periodi di tempo di rispettiva competenza i dirigenti e
amministratori della holding Enichimica-Enichem e delle sue varie società
“figlie”, pur in presenza di sempre maggiori conoscenze mediche e
scientifiche, continuavano ad omettere di adottare nell’esercizio
dell’impresa tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei
lavoratori dipendenti e di quelli delle ditte d’appalto”.
Il
21 marzo 1997 si apriva il processo per la strage di lavoratori e il disastro
ambientale in laguna. Legambiente aveva aperto la discussione con il dossier
“I crimini di Porto Marghera”. L’emergenza sanitaria veniva così
delineata: “I lavoratori del petrolchimico per primi sono stati sottoposti per
anni ad esposizioni di cloruro di vinile che hanno pesantemente sfondato i
limiti di tollerabilità massima per il corpo umano, con concentrazioni che sono
arrivate oltre le 1.000 parti per milione. Tanto per avere un termine di
raffronto si può fare riferimento alle indicazioni dell’organismo americano
che controlla gli ambienti di lavoro (OSHA) che già nel 1974 imponeva
concentrazioni massime di CVM di 1 ppm nell’arco delle otto ore lavorative,
mentre il legislatore italiano (e solo nel 1981) ha imposto il limite di 3 ppm
come media annuale, permettendo così esposizioni a picchi ben più alti. Gli
operai dei reparti CVM-PVC corrono un rischio 7,5 volte maggiore del normale di
contrarre un tumore al fegato e 600 volte più alto di contrarre una rara forma
di tumore epatico, l’angiosarcoma del fegato”.
La
questione “salute” viene ripresa dal dossier “Porto Marghera: la bonifica
innanzitutto. E dopo?” presentato all’apertura del processo. Le indagini di
Gabriele Bortolozzo, quelle della Procura, lo studio dell’Istituto Superiore
di Sanità permettevano di dare un quadro sanitario interno al Petrolchimico:
“Non tutti gli operai segnalati lavoravano effettivamente a contatto con il
CVM, i morti segnalati alla magistratura erano 145 e, di questi, 102 decessi
possono essere correlati alla esposizione al CVM (si tratta infatti di tumori
del fegato, del cervello, del sistema linfoemopoietico e del polmone per i quali
lo IARC dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce un rapporto
diretto e dimostrato con l’esposizione a CVM); compaiono fra le persone
segnalate patologie che con ogni probabilità sono causate dal lavoro a
Marghera, anche se non legate direttamente al CVM. Ad esempio si registra un
eccesso di tumori vescicali (correlabile ad esposizione alle ammine aromatiche
utilizzate a Marghera nel reparto TDI e forse in altre lavorazioni) rispetto
alla frequenza di questa patologia nel resto del Veneto. Si notano anche alcuni
casi di carcinoma alla pleura e al polmone correlati con esposizione ad amianto.
E ancora le conclusioni evidenziano che fra gli insaccatori di CVM c’è
un’anomala frequenza di tumore al polmone e che i casi di epatopatie hanno una
frequenza impressionante (ne sono stati accertati 189 su 571 persone di cui si
è esaminata la documentazione clinica)… Interessante il raffronto con i
risultati delle indagini epidemiologiche condotte dall’ISS… le persone prese
in considerazione sono in tutto 1568 per la polimerizzazione e 208 per
l’insacco. Al 1995 risultavano ancora vivi 1487 polimerizzatori e 166
insaccatori. I deceduti sono dunque
rispettivamente 168 e 41 (mancano tre polimerizzatori e un insaccatore di cui si
è persa ogni traccia)”. Il tasso di mortalità non rivela molto, se si tiene
conto di fenomeni ben conosciuti in epidemiologia, come il cosiddetto “effetto
lavoratore sano”: “Il discorso – continua il dossier – cambia molto se
si verificano le singole cause di morte. I decessi per tumore maligno sono 86
fra i polimerizzatori. Il loro numero giunge addirittura ad essere pari a quello
atteso a livello nazionale e soltanto poco più basso di quello regionale. Se si
sconta l’effetto lavoratore sano e si considera che un aumento relativo dei
morti per tumore è per forza parallelo ad una diminuzione relativa dei morti
per quell’altra grande causa che sono le malattie cardiovascolari, si può
concludere che la percentuale dei morti per tumore è in realtà aumentata o per
lo meno che il profilo delle cause di morte non è normale, essendo alterato il
rapporto fra i tumori e malattie cardiovascolari a favore dei tumori. In altre
parole, aveva ragione Bortolozzo: quasi tutti gli operai, suoi compagni di
lavoro, morirono per tumore…”.
“L’incidenza
del tumore al fegato risulta aumentata in maniera statisticamente significativa.
La frequenza del tumore aumenta tra gli autoclavisti, i più esposti, ed è
particolarmente frequente una rara forma di epatocarcinoma, l’angiosarcoma
epatico. Fra gli autoclavisti l’SMR (il tasso standardizzato di mortalità)
per angiosarcoma raggiunge la bella cifra di 60.000; in altre parole, questi
lavoratori muoiono per angiosarcoma al fegato con una frequenza pari a 600 volte
quella attesa. I morti, fra gli autoclavisti, sono 18 in tutto. Se se ne
verificano le cause, il risultato è sconvolgente: 9 sono morti per tumore al
fegato, 3 per cirrosi epatica, 4 per altri tumori. Uno infine, il cui
certificato di morte denuncia un carcinoma allo stomaco, era in realtà affetto
da una grave forma di epatopatia. Soltanto uno è morto per cause cardiache.
Questi dati sono talmente clamorosi che non hanno bisogno neppure di
elaborazioni statistiche: aveva ragione Bortolozzo nell’affermare che i suoi
amici autoclavisti morivano tutti per cancro al fegato. Purtroppo Bortolozzo non
avrà neppure la soddisfazione di veder confermati i risultati delle sue
indagini: morirà in uno strano incidente stradale, il 12 settembre 1995,
investito da un camion”.
Lo
stesso dossier riprende dal rinvio a giudizio del Pubblico ministero Casson
l’inesistente attenzione alle questioni ambientali dimostrata dalle società
presenti a Marghera mediante la vicenda dell’incarico affidato da Montedison
ed EniChem alla società American Appraisal. Incarico dato per verificare lo
stato degli impianti di Marghera, in occasione della progettata costituzione di
Enimont al fine dell’accertamento del rispetto delle normative ambientali.
L’American Appraisal fa le sue indagini, arriva a delle conclusioni, che mette
per iscritto: si scrive che l’Anic produce PVC, i reflui idrici sono acque
clorurate, i rifiuti solidi vengono inviati in discariche abusive, gli impianti
emettono in atmosfera alte concentrazioni di inquinanti. L’Anic possiede 57
effluenti (43 gassosi, 7 idrici, 2 per rifiuti liquidi, 2 per rifiuti solidi),
gli altri impianti di Marghera hanno 208 effluenti (tra cui 162 scarichi in
atmosfera) e i rifiuti solidi vengono in parte smaltiti in discariche interne
agli stabilimenti (in 17 discariche ben 5 milioni di tonnellate), in parte
incendiati, in parte esportati in Spagna e nell’allora Ddr. L’American
Appraisal aggiunge: “Situazioni di questo tipo possono causare seri problemi
economici e di responsabilità civile e penale per i futuri proprietari delle
aree in questione”. La relazione di American Appraisal finisce naturalmente in
un cassetto di Enichem da dove uscirà solo per opera della magistratura.
A
tre anni dall’avvio del processo, delle centinaia di lavoratori e familiari
costituitisi, solo alcuni rimangono come parti civili, con le associazioni
ambientaliste, il Comune la Provincia, la Regione e lo Stato. Per tutti gli
altri Montedison e Enichem stanzia più di sessanta miliardi per il risarcimento
danni.
Ma
a questo punto vale la pena riprendere alcune delle deposizioni dei consulenti
del pubblico ministero dalle quali emerge il quadro che per anni, invano, gli
ambientalisti avevano additato a istituzioni, imprese e sindacati di categoria.
La
deposizione Spoladori è per certi versi illuminante: per i rifiuti delle
lavorazioni “aree interne del Petrolchimico furono utilizzate per lo
smaltimento; nella zona adiacente ai serbatoi di ammoniaca fredda vicino a
gruppo di produzione AS vennero scaricate terre rosse derivate dalla lavorazione
dell’acido solforico. Altra zona segnalata fu quella adiacente agli ex
impianti TDI, quella del laboratorio e dell’ingresso 4 dove sorge
l’eliporto. Qui vennero coperti con terreni numerosi fusti, sostanze liquide e
tossiche. Le fasi di smaltimento avvennero tra gli anni ‘76 e ’89.
In aree esterne allo stabilimento, Lughetto di Campagna Lupia e lungo il
canale Petroli, sono stati rinvenuti fusti contenenti pece clorurata di
derivazione industriale in una vasta discarica nei pressi delle abitazioni. A
Mirano sono confluiti rifiuti industriali compresi quelli dell’impianto
cloro-soda del Petrolchimico, contenenti alte percentuali di mercurio.
Malcontenta, via Molanzani, dove la Montefluos nell’anno ‘89 con autopompa
scaricava più volte al giorno gessi in vasche che poi furono interrate. Sotto
le linee elettriche che corrono tra Malcontenta e Fusina vennero scavate fosse
profonde 3 o 4 metri, dentro le quali prima si scaricavano acque inquinate da
CVM, le stesse venivano quindi ricoperte da uno strato di cenere della vicina
centrale ENEL, e successivamente si sovrapponeva uno strato di pece del TDI e
così via, al fine di coprire il tutto con uno strato di terra. Ciò è
continuato fino a quando non è stato costruito il forno inceneritore di pece
TDI, intorno agli anni ‘77 e ‘79, anche se gli smaltimenti sono continuati
fino al 1983.
Altra zona segnalata era tra le abitazioni tra la campagna coltivata e il
naviglio Brenta. I rifiuti solidi venivano utilizzati come materiali per
imbonimenti delle zone barenarie, che progressivamente venivano conglobate con
l’espansione della zona industriale. Raggiunta la massima espansione
geografica, non avendo più siti interni di rifiuti, venivano innalzati su tutto
il territorio, interessando prima le aree limitrofe, poi i siti più distanti,
quindi scaricati a mare e anche inviati in paesi del terzo del mondo.
Altro sistema di smaltimento dei rifiuti di estrema nocività è stato
quello di bruciarli direttamente nelle centrali termoelettriche esistenti. Peci
della peggiore specie venivano aggiunte al combustibile o gettate nelle caldaie.
In questo modo venivano eliminate: 500.000 tonnellate annue che venivano di
fatto trasferite nel territorio, di cui in particolare code di distillazione,
peci di TDI ad altri impianti, 9.000 tonnellate annue, residui clorurati 11.000
tonnellate annue, ceneri di pirite 7.000 tonnellate annue, gessi da acido
fluoridrico 400.000 tonnellate annue. Questo si rinviene soprattutto in
particolare dal censimento delle discariche nel territorio provinciale.
Praticamente
questi residui di produzione provenivano dall’impianto del CVM,
dall’impianto TR, che tratta tetracloroetilene, TS, che è la trielina, e il
DL2, che è la produzione di ossido di carbonio. Poi ammine aromatiche e sempre
impianto di produzione del TDI, toluene di isocianato, processo di nitrazione
del toluene per ottenere il disitoluene; successivamente alla riduzione
ottenevano la toluendiammina, fatta reagire con l’ossido di carbonio ottengono
il TDI, quindi anche qui c’è un forte residuo di produzione che veniva
smaltito nel territorio. Poi avevamo anche EPCB, che provenivano dal fluido
elettrico dei trasformatori, impianti, espurghi, trasformatori. Invece le
diossine rinvenute nei rifiuti soprattutto e in particolare i
policloruribenzidiossine e i forani, comunque parliamo di diossine...
Policloruribenzidiossine, questa è una sostanza rinvenuta nei rifiuti. Proviene
dal CVM, ma anche da altre produzioni di cloroalifatici, impianti TR, TS, DL2 e
di cloroaromatici: cloruro di benzene e cloruro di benzale, presso l’impianto
BC1.
Invece
per quanto riguarda i metalli pesanti rinvenuti nei rifiuti da noi campionati,
in particolare il piombo, si può attribuire la produzione per la
stabilizzazione del PVC usato sotto forma di solfito bibasico, di piombo e
stearato di piombo. Il mercurio presente in quasi tutti i rifiuti rinvenuti,
dall’impianto cloro-soda il cloruro mercurico era usato come catalizzatore
nella produzione di dicloroetano, CVM, e nella produzione degli acetati. Il
ferro invece, cloruro ferrico, catalizzatore dell’impianto TS e impianto TR.
Il rame, catalizzatore cloruro di rame usato nel TD2, produzione di ossido di
carbonio. Infine l’arsenico, presente nelle ceneri di pirite, da noi rinvenuto
in maniera massiccia su aree che dopo andrò ad elencare; produzione di acido
fosforico da Enichem Agricoltura, in particolare Fertimont e Agrimont.
Praticamente il rifiuto da noi rinvenuto in quelle aree era direttamen